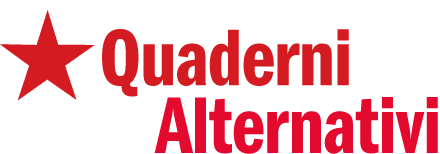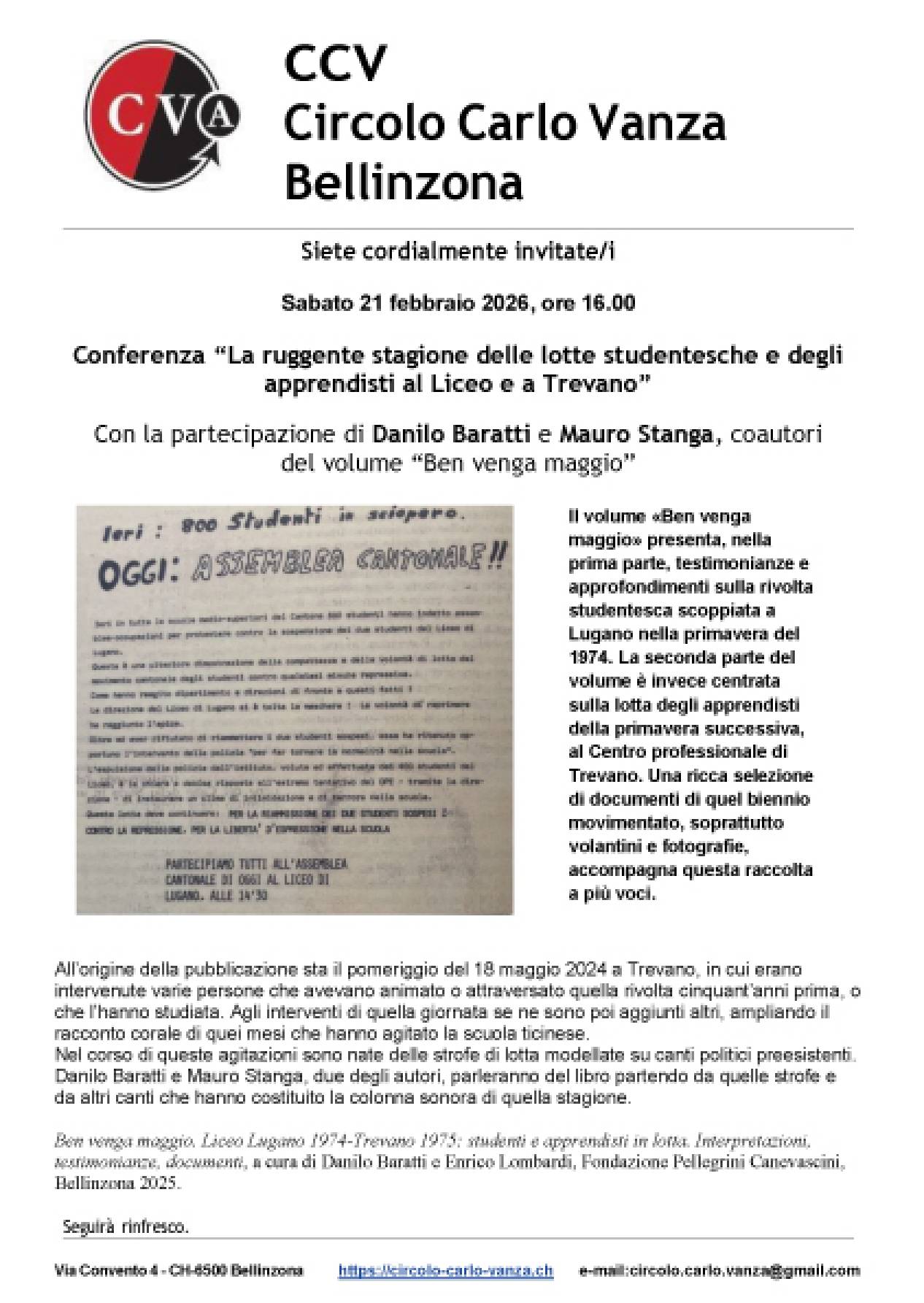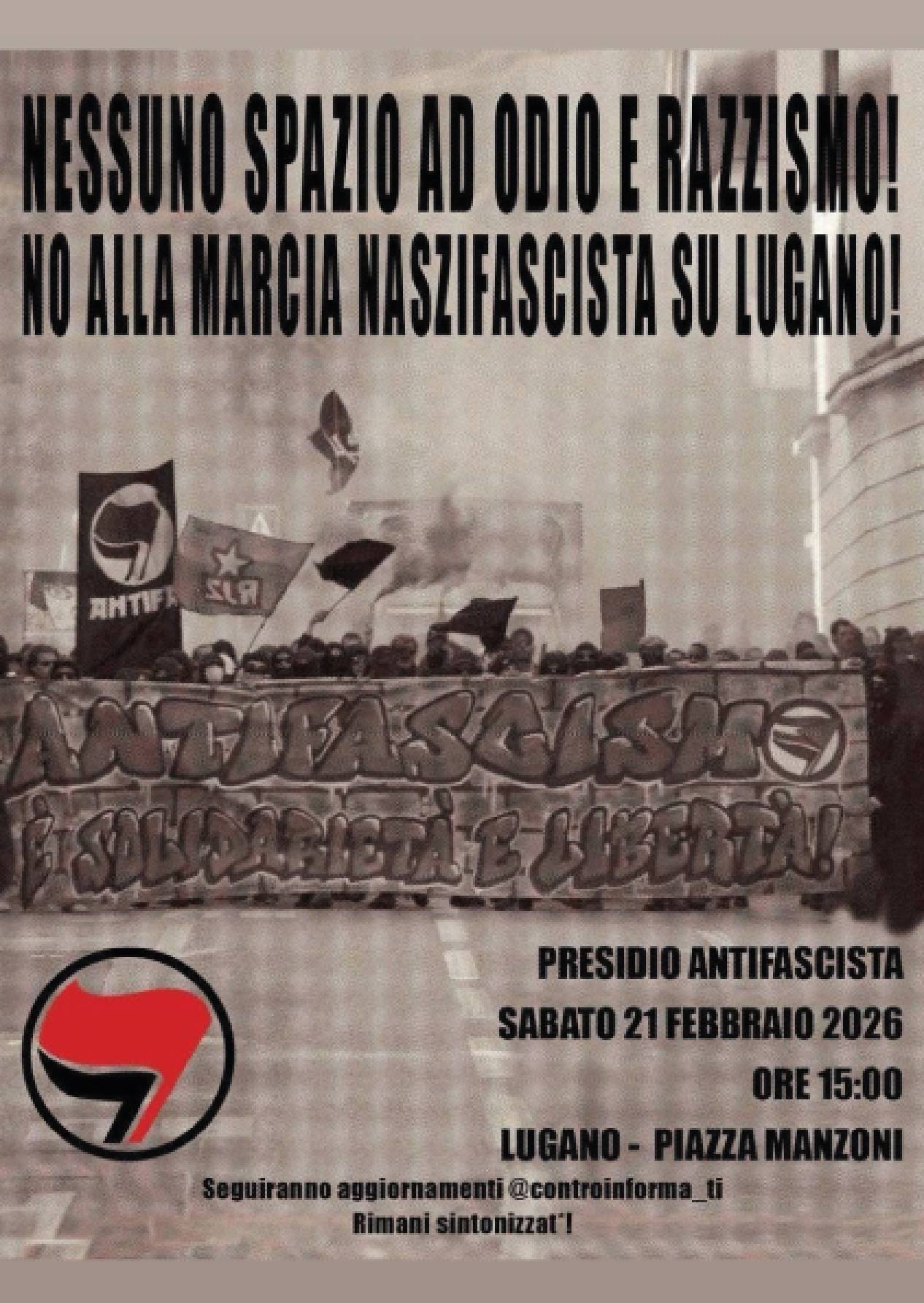Il libro di Giacomo Müller, nato da una tesi di laurea all’Università di Friborgo, affronta un capitolo finora assai trascurato dalla storiografia locale: la nascita, intorno al Sessantotto, di gruppi extraparlamentari radicali che per qualche anno saranno uno strepitante soggetto politico, seppur frammentato, anche in una realtà relativamente tranquilla come quella ticinese. In particolare la ricerca di Müller porta l’attenzione sul più importante di questi gruppi, il Movimento Giovanile Progressista (MGP) – che poi prenderà il nome di Lotta di Classe (LdC).
Inseguendo nella memoria l’età della rivoluzione
Il corso di formazione organizzato dal FA sulla “Nuova sinistra degli anni ’70 e sull’operaismo” si è arricchito di un’appendice inizialmente non prevista: la presentazione della ricerca di Giacomo Müller pubblicata di recente dalla Fondazione Pellegrini Canevascini con il titolo Inseguendo la rivoluzione.
Il ricercatore ha cercato di ricostruire, partendo da fonti orali e documentarie, le tracce di rosso molto particolari di una formazione politica, il Movimento Giovanile Progressista diventato successivamente Lotta di Classe, che in contrapposizione ad altre formazioni, nate nel medesimo periodo, non ha mai voluto confluire nell’alveo della tradizione socialista volendo perseguire in modo solitario e radicale il proprio “assalto al cielo”.
A Müller va riconosciuto, come sostiene Danilo Baratti nell’introduzione del libro, il merito di aver contribuito a colmare una lacuna proprio “alla vigilia del dissolversi della memoria diretta dei protagonisti”. Nei suoi intendimenti iniziali, le interviste fatte sulla base di campioni rappresentativi gli avrebbero dovuto permette di cogliere “la dimensione psicologica e cognitiva del rapporto con l’ambiente esterno e con la pratica della violenza (?), così come le traiettorie biografiche dei protagonisti”, toccando la sfera importante dei “legami affettivi e di amicizia” e mettendo in risalto, come ha precisato Baratti, “la diversità degli sguardi retrospettivi su quell’esperienza”. Le risposte degli intervistati, non tutti disposti a misurarsi con gli aspetti soggettivi del loro passato dentro l’organizzazione e, dunque, a fare uno sforzo d’introspezione retroattivo, hanno però portato il ricercatore a spostare l’obiettivo.
Oltre a questo, il ricercatore si è trovato a dover indagare un gruppo il cui percorso non è stato di certo lineare. Alla fase adolescenziale dell’inizio (MGP), caratterizzato dallo stile e dai contenuti della ribellione sessantottina, era seguita in discontinuità quella dell’impegno maturo contro la pace del lavoro e dei contatti con la classe operaia (Lotta di Classe). L’indagine sulla soggettività dell’impegno, le domande sulle sensazioni , sui rapporti tra compagni e con la famiglia potevano adeguarsi bene alle condizioni della prima fase, di cui tra l’altro nessuno durante la serata ha voluto parlare, ma non si adattavano al tentativo di voler interpretare la fase seguente, quella ispirata in un qualche modo all’operaismo e maggiormente vissuta nella dimensione collettiva. Dall’intento di affrontare “le problematiche delle emozioni e della socializzazione del gruppo per capirne l’influenza sulle identità individuali”, come dire dall’intento di analizzare l’ideologia delle persone intervistate, Müller si è così visto costretto a riposizionarsi e a cercare una soluzione attraverso un’interpretazione complessiva di tutta la traiettoria del gruppo dal 67 al 73/75 e a entrare nel merito dei suoi progetti, delle sue pratiche e delle sue relazioni, comprese quelle internazionali. Questo cambiamento di rotta appare chiaramente espresso nel sottotitolo aggiunto ex-novo in occasione della pubblicazione avvenuta cinque anni dopo la soutenance universitaria.
Già prima della presentazione del libro, all’autore non deve essere sfuggito il fatto che, cambiando obiettivo, si sarebbe inevitabilmente trovato nella condizione scomoda di essere contraddetto dagli stessi personaggi che aveva intervistato e da cui aveva preso l’ispirazione. Memoria e ricostruzione storica spesso confliggono. Nello specifico, è difficile per militanti di cinquant’anni fa accettare che alla loro memoria venga sovrapposta una ricostruzione effettuata con intendimenti legati all’attualità e, di conseguenza, non farsi prendere dalla foga di ricostruire filologicamente, in contrapposizione a una versione considerata astratta se non addirittura arbitraria, il vero percorso da loro effettuato in quegli anni. Questo è tanto più vero se si considera che, dopo lo scioglimento del MGP/LdC, molti conti tra gli stessi vecchi militanti sono rimasti irrisolti. Il lungo tempo trascorso non è bastato per assopire i dissidi e le contraddizioni che in quegli anni covavano all’interno dell’organizzazione. Il rischio della polemica finisce poi per assumerlo chi, come Müller con la sua ricerca, fa lo sforzo di riportare il tutto, o quello che egli ritiene tale, in superficie e offre involontariamente l’occasione ai vecchi protagonisti di togliersi qualche sassolino dalla scarpa .
Müller dichiara di essere interessato “a capire i processi che hanno portato alla genesi del MGP/LdC” e li cerca “nel fortissimo rigetto della cultura capitalista e consumistica” dentro un contesto socialmente chiuso come quello ticinese nel momento in cui cominciavano a farsi sentire dall’esterno forti segnali di rivolta. La radicalizzazione dei giovani ragazzi del MGP avviene attraverso quella che lui chiama ”educazione rivoluzionaria”. Un’educazione che permette loro di trovare una soluzione organizzativa alla ribellione ma che finisce per creare “un progressivo distacco dalla realtà” soprattutto nella fase in cui il gruppo subisce il fascino di teorie nate in altri contesti e si allaccia a formazioni rivoluzionarie che operano nelle regioni industriali italiane. I contatti con Potere Operaio permettono al MGP/LdC di arricchire la teoria e di dare una svolta operaista ai suoi obiettivi pratici (“il percorso rivoluzionario deve nascere nelle fabbriche”) ma finisce per creare dentro il gruppo una scissione tra la volontà di sovvertire l’ordine delle cose e le azioni che esso è fattibilmente in grado di intraprendere.
Müller, soprattutto nell’ultima parte del libro, forse condizionato dal fatto che la sua ricerca universitaria è stata iscritta in una ricerca più generale sulla violenza politica in Svizzera, si sofferma con insistenza sulla deriva che avrebbe portato il MGP/ LdC ad avvicinarsi, seppure in astratto, ai temi della lotta armata. Ne individua la prova nel linguaggio violento usato dal suo giornale e nella volontà di dotare la propria organizzazione di un livello semi-clandestino. Riconosce tuttavia che, malgrado abbiano sempre mantenuto i contatti con gruppi italiani praticanti l’illegalità, i militanti del MGP/LdC “non hanno mai creduto veramente alla lotta armata contro lo Stato”.
Vincenzo Di Dio e Bruno Strozzi, i due militanti del MGP/LdC invitati alla presentazione del libro, pur apprezzando gli intendimenti e l’impegno del giovane storico, hanno voluto mettere in discussione alcune sue argomentazioni e contrapporre una diversa interpretazione della storia del loro gruppo.
Per evitare di dare una lettura ideologica dell’esperienza del MGP/LdC , secondo Strozzi, occorrerebbe partire da una precisa contestualizzazione dei fatti. Solo così facendo si può riuscire “a capire i processi che hanno portato alla genesi del MGP/LdC” e rispondere alla domanda che nella ricerca di Müller viene posta. Alla fine degli anni sessanta, quando nasce il MGP/LdC, anche in Svizzera si sta modificando la composizione della classe operaia, non solo a causa delle migrazioni, e inizia una rivoluzione globale del sistema lavoro con l a fine del fordismo. Chi si avvia a una lotta radicale contro il sistema deve partire dalla crisi del movimento socialista e porsi il problema, tutt’ora di attualità, di costruire uno strumento politico diverso, non più ispirato semplicemente al tentativo di riprodurre a un livello maggiore di antagonismo i modelli del passato. Non si tratta più di pensare ad avanguardie organizzate dal partito. Non si tratta di fiancheggiare i partiti socialisti nella speranza di spostarli a sinistra. L’esperienza incompiuta del MGP/LdC va giudicata dentro questa necessità e non dando giudizi sul suo presunto avvicinamento ideologico alla clandestinità e alla lotta armata. Avvicinamento, semmai c’è stato, dedotto da altri contesti di conflitto. L’esperienza del MGP/LdC , al di là delle velleità di alcuni suoi militanti, non ha mai potuto prescindere dal quadro economico, sociale e giuridico determinato dal grande capolavoro del padronato svizzero: la pace del lavoro.
Di Dio sottolinea alcune specificità che nella ricerca di Müller, forse troppo attratta dalla descrizione dei successivi “anni di piombo”, vengono un po’ oscurate. Il MGP/LdC non scaturisce da esperienze organizzative precedenti. Viene fondato da giovani che inizialmente non hanno nessuna militanza di partito alle spalle. La loro mente è sgombra dai precedenti della sinistra tradizionale. Per tutta la sua breve esistenza il gruppo non si pone questioni di tipo istituzionale e non ambisce mai a nessuna partecipazione parlamentare. Dopo il periodo d’iniziazione sessantottina, la centralità della sua azione politica è perseguita nello stretto contatto con la classe operaia. Grazie a questa prossimità cercherà sempre, nel proprio piccolo, di individuare temi di lotta e rivendicazioni in grado di scardinare la pace del lavoro. Attraverso gli interventi nelle fabbriche con forte presenza di operai italiani, portoghesi, spagnoli … e l’impegno nel contrastare l’iniziativa Schwarzenbach, riuscirà ad andare oltre le campagne umanitarie contro il razzismo e a individuare la funzione strumentale che la discriminazione razziale svolge all’interno del mondo del lavoro. In anticipo rispetto agli economisti del PS come Angelo Rossi, riesce a mettere bene in luce come l’uso della gestione migratoria da parte della Confederazione diventi strumento di politica economica industriale.
Può apparire sorprendente che nessuno tra i contendenti, per valorizzare o smentire la tesi sul fiancheggiamento di azioni illegali da parte di Lotta di Classe e sulle sue affinità politiche con gruppi radicali operanti in Italia dopo l’”autunno caldo” del 69, abbia voluto soffermarsi su fatti concreti. Né Müller né i due testimoni invitati alla presentazione hanno fatto un preciso accenno al processo che nel 1981 fu intentato a Locarno contro cinque persone che appartenevano a Lotta di Classe fino al momento del suo scioglimento. Essi furono accusati di aver dato rifugio a brigatisti e di aver partecipato al procacciamento di armi. Nella sua ferocia requisitoria il procuratore pubblico Dick Marty li definì “frutti marci del sessantotto” senza pur tuttavia fare riferimento alla loro appartenenza. I giudici del Tribunale, distanziandosi dagli attacchi denigratori e moralistici dell’inquisitore, tentato di emulare il protagonismo dei colleghi italiani, ritennero “eccessivo e ingiusto porre il marchio della banda a quei loro rapporti di solidarietà che erano allora improntati ad ideali politici seguiti con intelligenza e sacrificio. (… ) Il giudizio sulla punibilità, è da rendere secondo l’atmosfera politica di quegli anni, ovvero evitando di considerare i prevenuti quali terroristi” (foglio 55 della sentenza). A molti anni di distanza, che significato vogliono dare i contendenti, tesi tra memoria personale e ricostruzione storica, al fatto che fra chi, almeno fino al 1973, militava accanto ai cinque compagni arrestati, nessuno li abbia apertamente sostenuti e rivendicato per le loro gesta d’illegalità la paternità dell’organizzazione? Estraneità o rimozione?
Nel dibattito avvenuto in seguito agli interventi principali, centrato soprattutto sulle diverse interpretazioni dei movimenti sessantottini, si è voluto riconoscere al MGP/LdC il merito di aver dato una scossa ai giovani studenti ticinesi di allora, portando una parte di essi a superare i limiti elitari della contestazione studentesca e a investirsi con passione, forse anche in modo coraggiosamente avventato, nel mondo delle contraddizioni tra lavoro e capitale. Non è mancato neppure chi, ricordando il maschilismo insito nei movimenti di quella contestazione, ha rimproverato al MGP/LdC un certo conformismo che riduceva il ruolo delle compagne ad “angeli del ciclostile”.
L’idea di promuovere un corso di formazione di base sulla nuova sinistra degli anni 70, con riferimento particolare all’Italia e al Ticino, non ha voluto essere per il FA un esercizio di pura memoria storica, sia pure militante. Chi lo ha frequentato è stato reso consapevole che i corsi di formazione, così come le analisi teoriche, devono sempre essere situate dentro gli obiettivi della lotta politica. Gli stessi protagonisti dei gruppi a cui si è fatto riferimento insegnano che “sono le problematiche del presente a dover interrogare il passato”. Ripensando a questa serata in cui si è parlato e discusso sull’eredità della nuova sinistra degli anni 70 e sull’organizzazione MGP/LdC che l’ha particolarmente rappresentata, viene da porsi un interrogativo inquietante. La mancata partecipazione di esponenti del POP, del PC e del MPS è forse la dimostrazione che l’unico dibattito, l’unica riflessione ancora possibile fare in comune nella sinistra radicale ticinese è quello sulle alleanze e sulle strategie elettorali?