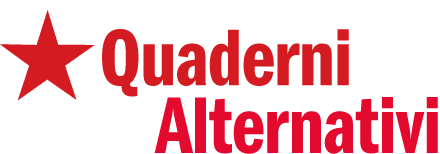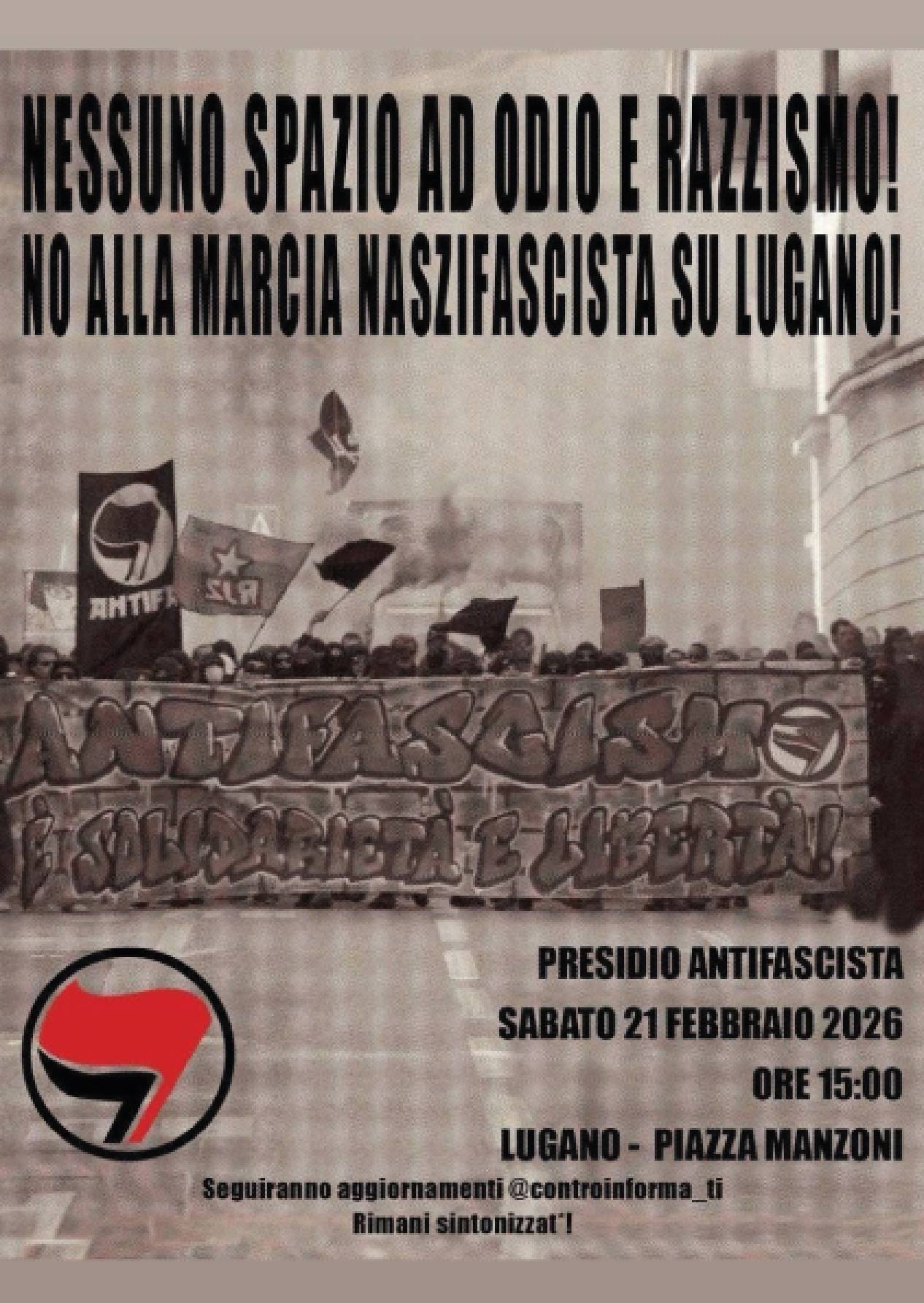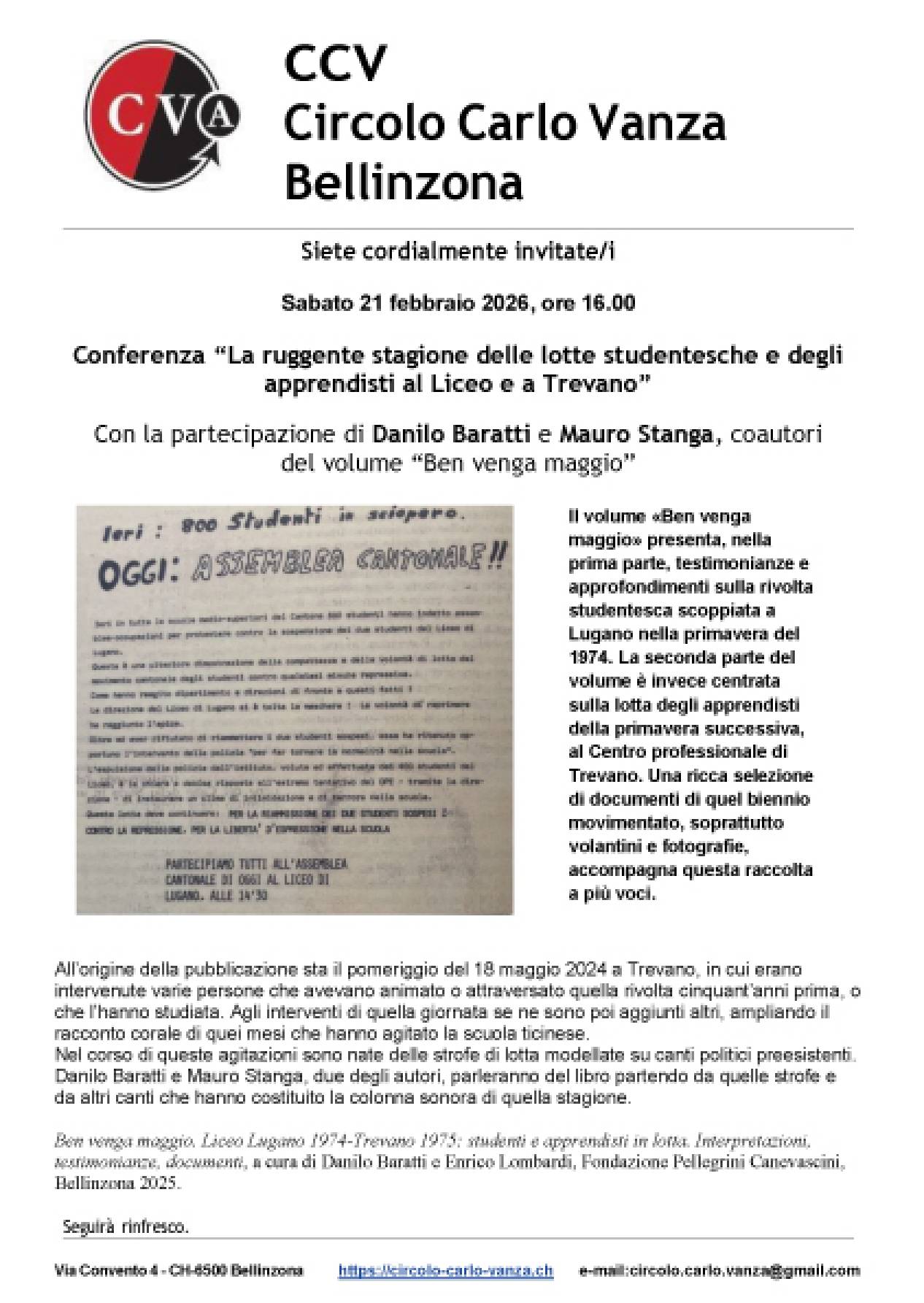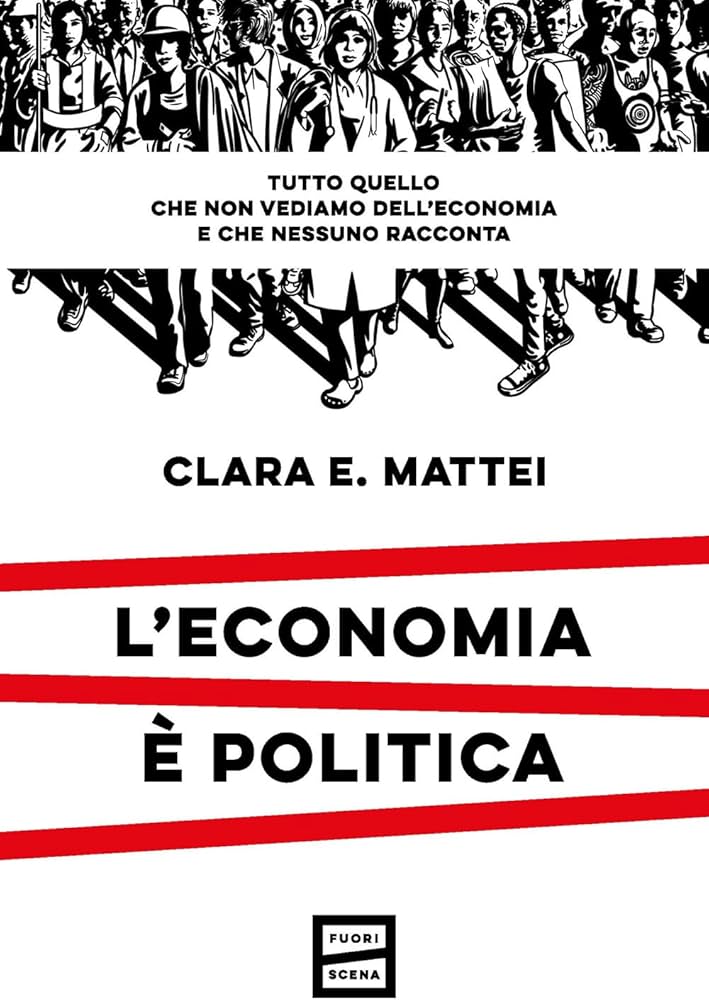
Era il 2014 quando il premio Nobel per l’economia Jean Tirole ha affermato in una lettera alla Ministra francese dell’Università e della ricerca Geneviève Fioraso che il pensiero economico eterodosso è “l’anticamera dell’oscurantismo”. La lettera aveva animato un ampio dibattito in Francia, portando alla pubblicazione di un contro pamphlet – Misère du scientisme en èconomie (Edition du Croquant, 2017), che criticava il pensiero mainstream e le politiche da quello supportate come foriere di diseguaglianza. Se l’economia sia o meno una scienza esatta come la fisica è un tema che tiene banco nel dibattito internazionale da decenni. Il nuovo libro di Clara Mattei parte da qui, dalla necessità di demistificare l’economia e di tornare alle radici politiche della disciplina.
Economista alla New School of Social Research di New York, ne “L’economia è politica” (Fuoriscena, 2023) Mattei torna al fascismo, rinvenendo in una delle epoche più cupe della nostra storia le radici squisitamente politiche di specifiche pratiche economiche. È un tema che Mattei aveva approfondito nel suo primo libro: “The capital order” (University of Chicago Press, 2022), tradotto in italiano da Einaudi e definito dal Financial Times come uno dei dieci testi più importanti del 2022. Nel suo primo lavoro, Mattei ci portava agli anni del primo dopoguerra, quando la politica si serve di politiche d’austerità per riportare l’ordine sociale. In quegli anni, la società italiana era in fermento. La guerra aveva generato il desiderio diffuso di una vita migliore. La leva e l’arruolamento volontario avevano portato una carenza di personale, costringendo i datori di lavoro ad aumentare i salari per attrarre la poca manodopera disponibile. L’occupazione delle fabbriche, inoltre, sembrava suggerire l’imminenza di una rivoluzione in Italia. Per Mattei, gli anni del biennio rosso furono un periodo di rinata consapevolezza per la classe lavoratrice, in cui il desiderio di autogoverno popolare si propaga velocemente nelle fabbriche e nelle campagne. C’era una sorta di «scioperomania», scrive l’autrice: i lavoratori non erano “più disposti ad accettare un sistema nel quale il loro lavoro veniva comprato e venduto sul mercato come una qualunque merce”. È in quel contesto che il fascismo si presenta come un regime capace di riportare l’ordine nella società. Ed è all’austerità che il fascismo affida questo compito.
Mattei fa dell’analisi storica delle politiche economiche utilizzate durante il ventennio il fondamento teorico della sua cassetta degli attrezzi. In questa analisi, l’austerità non appare come una politica neutra, bensì come uno strumento politico, il cui fine non è il pareggio di bilancio, ma disciplinare la società. Mattei distingue tra austerità fiscale, monetaria e industriale, descrivendo ciascuna di queste tre anime come parte di un progetto politico teso a stabilizzare la politica e a ridurre gli scioperi. È quanto avviene un secolo fa, quando la politica internazionale loda il regime fascista per la sua capacità di trasformare gli italiani in un popolo “disciplinato, silenzioso e pacifico” e di stabilizzare le finanze dello Stato, riducendo gli scioperi del 90 per cento e le giornate lavorative perse del 97 per cento, come spiegava un comunicato dell’Ambasciata inglese del 1923. È così efficace l’austerità come strumento politico che essa è il perno delle politiche odierne, osserva Mattei.
L’autrice sceglie una delle fasi più buie della nostra storia per mostrare come le politiche economiche adottate oggi non siano scelte tecniche, bensì espressione di un progetto spesso antidemocratico, capace di aumentare drasticamente la diseguaglianza sociale. C’è distanza tra l’epoca odierna e il secolo scorso, tuttavia ancora oggi i tagli alla spesa sociale, le privatizzazioni, la tassazione regressiva, deflazione e repressione salariale, sono al centro della cassetta degli attrezzi della politica. Inoltre, come un secolo fa il fascismo si serviva dell’austerità per disciplinare i lavoratori, cosi il Governatore della Federal Reserve Jerome Powell ha fatto ricorso all’aumento dei tassi di interesse per raffreddare l’economia e ridurre il potere negoziale del lavoro, rivolgendosi all’austerità monetaria per incidere sulla carenza di personale che, complice la crisi demografica, il turnover volontario, la crisi del senso del lavoro e l’aumento dei processi di sindacalizzazione, nei mesi post-pandemici ha costretto i datori di lavoro a competere tra loro per reclutare manodopera. Una volta ancora, la politica si rivolge all’austerità per riportare l’ordine nei luoghi di lavoro. È una scelta su cui Mattei ci invita a riflettere. Già un secolo fa, questa logica di disciplinamento ha avuto la meglio su chi chiedeva maggiori diritti. E, chiaramente, non è stata una scelta lungimirante.