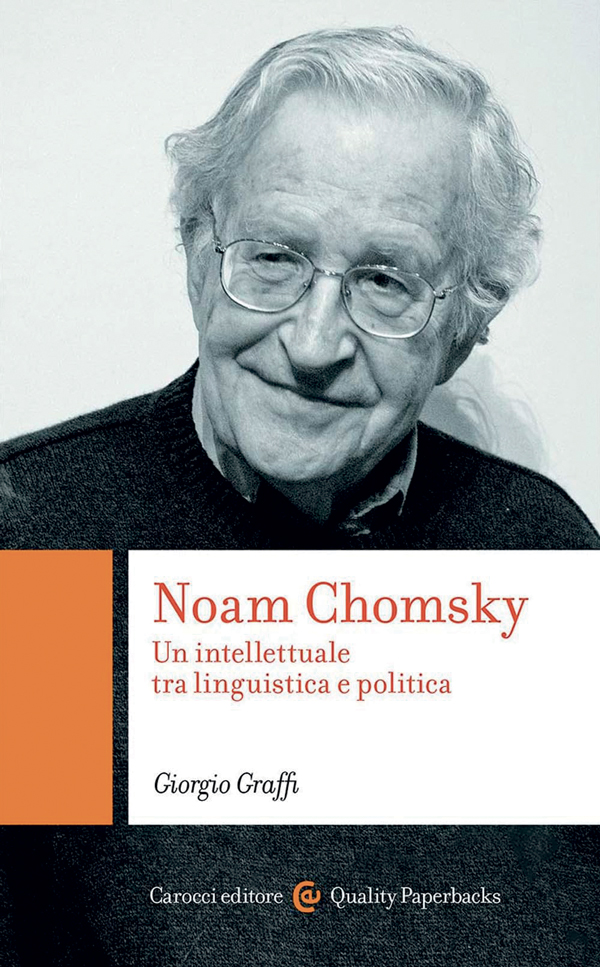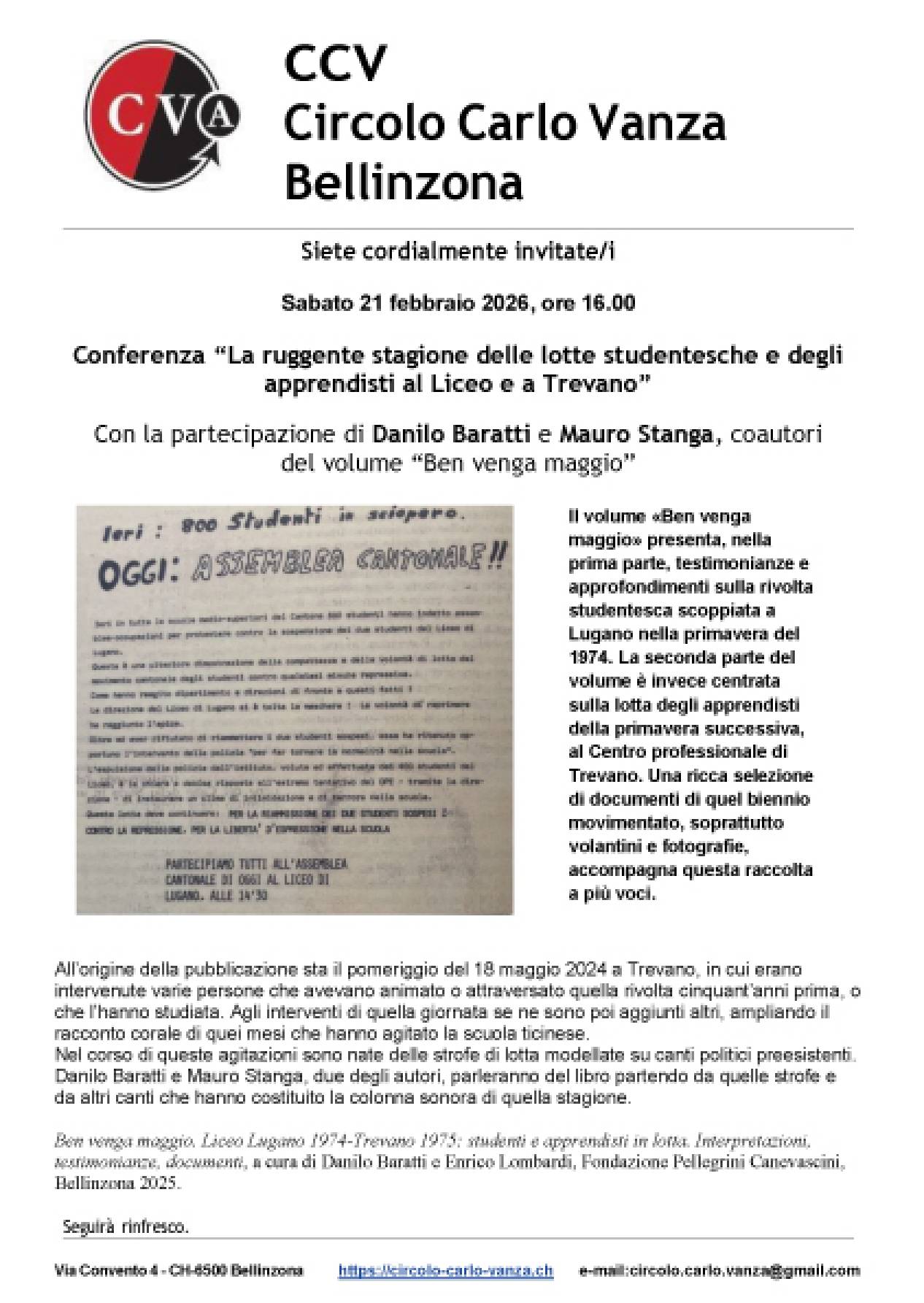Noam Chomsky, che compirà 97 anni il 7 dicembre, è figura nota tanto agli ‘addetti’ degli studi linguistici che a un pubblico più vasto, sedotto dall’impegno politico che ha caratterizzato il linguista a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Il ritratto che ne propone Giorgio Graffi tiene insieme queste due vocazioni facendo interagire (come non deve essere stato facile) settant’anni di storia accademica (1950-2020) con l’impegno maturato dall’intellettuale americano su un ampio scacchiere geopolitico che ricorderermo. E il risultato vale la lettura1.
Dalla semitistica alla linguistica
All’Università di Pennsylvania, Chomsky si orienta inizialmente verso la semitistica e, in particolare, verso l’arabo, un interesse favorito dall’incontro con Giorgio Levi Della Vida (1886-1967), emigrato alla fine degli anni Trenta per aver rifiutato di giurare fedeltà al fascismo. Fu il primo di una serie di incontri, completati ad Harvard e poi al Massachusetts Institute of Techology (M.I.T.), che ci avverte della valenza umana e intellettuale che ebbe per lui quella disciplina. L’intellettuale, scrive nel suo primo intervento politico (American Power and the New Mandarins, marzo 1966), deve andare oltre l’orticello della propria specializzazione “smascherando menzogne e controverità” e mettendo in discussione principi e opinioni costituiti. In questo Chomsky è, come Graffi sottolinea, un perfetto “figlio dell’Illuminismo”.
Il passaggio alla linguistica è in parte frutto (come accadrà spesso nel suo percorso intellettuale) di un nuovo incontro, quello con Zellig S. Harris esponente della linguistica strutturale statunitense, nel quale Chomsky trova il suo primo maestro. Ne avrà altri, ma Harris resta probabilmente il principale anche perché sa incoraggiarne gli interessi politici. Ne risulterà la tesi (1951) sulla morfofonemica in ebraico moderno, lingua che Chomsky conosce per tradizione familiare, dove per la prima volta compare l’aggettivo “trasformazionale”, che ne ipotecherà la teoria linguistica successiva, col significato di “operazione sintattica generativa” di un insieme infinito di frasi (p. 74).
Da altri incontri, col linguista Yehoshua Bar-Hillel e poi, ad Harvard, con Eric Lenneberg, origineranno le teorie innatiste e biologiche del linguaggio che Chomsky farà sue e che implicheranno altre importanti ricadute teoriche (l’esistenza di “universali linguistici”, cioè una teoria di una “Grammatica Universale delle lingue”). I suoi interessi non andavano però alla descrizione delle lingue, quanto piuttosto al modo in cui queste si acquistano e si sviluppano, e l’’esperienza e l’insegnamento parentale rivendicato dalla linguistica comportamentistica non gli sembrano sufficienti a spiegare l’acquisizione del linguaggio. In questo, si consuma la differenza con altre branche della linguistica, in particolare con quella strutturale di Sapir e quella comportamentista di Blooomfield, o la distanza con un filosofo come Quine, che pur lo aveva attratto durante il periodo di Harvard spiegando l’acquisizione linguistica con meccanismi innati. Il confronto che Graffi propone tra le teorie chomskiane e quelle di altri teorici, come il linguista tedesco Hermann Paul, lo stesso Benedetto Croce o quelle “costruttiviste” dello psicologo svizzero Jean Piaget (1896-1980) sono di grande interesse e mostrano che per far giudizio di Chomsky occorre trascorrere dalla linguistica alla filosofia dalla storia della scienza a quella economica e delle dottrine politiche.
La politica
Non facile è conciliare il ruolo dell’innatismo nell’acquisizione linguistica di Chomsky con una visione storicizzante e progressista del mondo, tanto più se, come Graffi sottolinea la costruzione della personalità è per Chomsky un fatto, in gran parte, genetico, del quale si intuiscono le possibili derive che in termini di discriminazioni di diritti e trattamento.
Su questo punto, il confronto che negli anni settanta Chomsky ebbe con Michel Foucault resta esemplare di due visioni del mondo e, come in altre occasioni, la capacità del linguista fu nel ribaltare i termini del problema: non è l’dea dell’innatismo ad essere nefasta, è piuttosto la società responsabile di non saper valorizzare correttamente le competenze degli individui
Una tale fiducia nella ‘ragione’ colloca Chomsky nel campo opposto al “postmodernismo”, del quale lamenta la dimensione irrazionale. Ragione e ‘buon senso’ (ma sulla loro coincidenza Pasolini non sarebbe stato d’accordo) sono per lui parametri sufficienti per intervenire nella politica non invece nella scienza, che è sostanzialmente ‘una’ e non troppo influenzata, a livello teorico, dalle componenti proletarie e borghesi che segnano la società civile o dai rapporti di produzione. C’è spazio, evidentemente, per un forte dissenso a fronte di un’argomentazione che, mentre sembra ricuperare qualcosa della polemica postmodernista contro le élite, fa della scienza un baluardo retto unicamente da pilastri morali. Il discorso politico richiederebbe invece solo ragione, buon senso e buona informazione. Graffi mostra come queste tematiche derivino a Chomsky da una lettura dei classici del pensiero occidentale, da Adam Smith a Hume, filtrata da una visione anarchica del mondo in cui convergono due filoni principali di pensiero: quello socialista e quello liberale (pp. 194-197). È una visione che deve probabilmente qualcosa anche allo studio che Chomsky ha fatto della Spagna della Repubblica e del modello di collettivizzazione dal basso che fu patrimonio del maggior sindacato d’ispirazione anarchica in quegli anni, la Confederación Nacional del Trabajo in lotta con un partito comunista d’ispirazione strettamente sovietica (p. 198).
A un ambito più politico introducono gli episodi della difesa dei diritti di Robert Faurisson, professore all’Università di Lyon 2 (noto per aver negato a più riprese le camere a gas naziste e processato per questo) e delle vignette su Maometto della rivista ‘satirica’ “Charlie Hebdo”, costato nel 2015 la vita a dodici giornalisti in seguito all’attacco di un gruppo di fondamentalisti musulmani. Qui, e soprattutto nel primo, prevalse in Chomsky la difesa del diritto a manifestare idee giudicate detestabili, posizione del resto, osserva Graffi, fatta propria anche dalla Corte suprema americana a proposito delle idee suprematiste del Ku Klux Clan (pp. 208-211). L’episodio dimostra comunque la particolare ‘sovraesposizione’ cui il linguista andò incontro su questo terreno.
Nel seguito, il libro entra in uno spazio geopolitico più robusto e internazionale, che si misura su tre contesti diversi: le guerre d’Indocina e l’implicazione degli Stati Uniti in Vietnam, Cambogia e Laos; il conflitto mediorientale, che lo occupa a partire dagli anni Sessanta e la guerra seguita all’invasione russa dell’Ucraina, nel 2022. Con l’attenzione sempre vigile alla “fabbrica del consenso” (come la chiama Chomsky) espressa dalla democrazia americana. Sul medioriente si misura forse la maggiore evoluzione di questo intellettuale d’origini ebraiche, che partito da posizioni filosioniste passa, all’inizio del 1953, alcuni mesi in Israele attratto dal mito di un “socialismo da kibutz” in cui vedeva forse riflesso qualcosa dei processi di collettivizzazione spagnoli ricordati. Chomsky crede insomma, anche dopo la tragedia della Nakba che accompagna la creazione dello stato di Israele, nella possibile convivenza di ebrei e arabi-palestinesi. Poi, lentamente, ne intuisce l’impossibilità verificando anche la divisione che corre tra una parte del mondo ebraico e il nazionalismo sionista. Il piano di spartizione dell’ONU del 1947 è per lui “un macroscopico errore”, perché solo si può dare (e qui l’accordo con Edward Saïd è completo) uno stato binazionale e non due stati, solo all’apparenza indipendenti. La sua interpretazione corre parallela all’occupazione e parcellizazione sionista della Palestina storica, che rende pressoché impossibile la costruzione di un’entita statale.
Qui Graffi, sempre molto misurato nella ricostruzione del contesto storico-politico, indica le ragioni del fallimento degli accordi di Oslo (1993 e 1995) nel fatto che “ognuna delle due parti [cioè sionisti e palestinesi] scaricò (e continua a scaricare) la colpa sull’altra” (p. 237); ma qualche pagina dopo il tiro è opportunamente corretto, con la precisazione che “di fatto, quegli accordi rappresentavano l’accettazione ufficiale della politica fino a quel momento condotta da Israele nei territori occupati. Non prevedevano la costituzione di uno Stato palestinese indipendente, né tanto meno l’autoderminazione dei palestinesi, ma solo la concezione di una limitata autonomia ai territori occupati, che rimanevano comunque sotto il controllo di Israele” (p. 243). Insomma, l’ennesima prova di come nella mentalità israeliana ci sia posto solo per uno stato ‘ebraico’.
Il libro è chiaro anche quando la materia di fa complessa e, iscrive Chomsky in una storia del pensiero occidentale anticolonialista, quale possiamo far iniziare con Frantz Fanon, autore decisivo anche per un intellettuale americano d’origine palestinese come Edward Saïd. Il nome di Fanon non compare nel libro, ma non mi pare indecente avicinare il ruolo che l’Algeria ha avuto per lui con quello che Israele ha avuto per Chomsky.
1 Alla diffusione del pensiero di Chomsky, Giorgio Graffi ha contribuito con importantio studi, di cui ricordo solo “Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica”, con S. Scalise, Il Mulino, IV ed. 2024, “La grammatica generativa. Idee, storia e modelli di analisi”, Carocci 2022 (con C. Donati), “Breve storia della linguistica” (ibid., 2019); “Due secoli di pensiero linguistico. Dai primi dell’Ottocento a oggi” (rist. 2019); “Capire la grammatica. Il contributo della linguistica” (con A. Colombo, 2017). Ma dove si singolarizza forse rispetto a molti colleghi è senz’altro per i suoi interessi di politica internazionale, dei quali ha scritto e scrive per esempio su “Terzogiornale.it” e altre testate e piattaforme.
di Massimo Danzi, Università di Ginevra