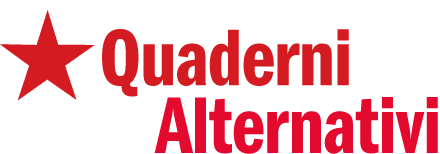Per i baby boomer (1946-64) cresciuti in Ticino, soprattutto figli di famiglie di sindacalisti, socialisti e comunisti, ma non solo, Rodi ha un significato particolare: non è solo un comune leventinese. È un’esperienza di vita vissuta alla Colonia dei Sindacati.
Due ex ragazzi che hanno fatto questa esperienza, Sergio A. Dagradi e Ilario Lodi, si sono cimentati nella ricostruzione della storia della Colonia di Rodi, percorrendo in modo dettagliato il cammino che va dal 1923 al 1983. Assieme al profilo storico, l’opera “Per nuovi sentieri” edito da Fontana e dalle Colonie dei sindacati, offre una sostanziosa disamina sul senso di quell’esperienza e sui contenuti pedagogici.
La storia delle Colonie dei Sindacati, nel corso degli anni non solo in Leventina, ma anche sulla riviera romagnola e nel canton San Gallo, ha un alto valore politico. È un esempio illuminante di come il sindacato ha saputo intervenire nella società civile al di fuori, o accanto, ai compiti tradizionali. La difesa degli interessi dei lavoratori è passata anche dall’offerta di un servizio di sostegno alle famiglie e di educazione per i bambini. Una vicenda esemplare che verrebbe voglia di veder replicata oggi in altri campi.
La ricerca di Dagradi e Lodi si fonda sulla minuziosa consultazione dei verbali delle Commissioni che gestivano le Colonie, sulle lettere e sui documenti elaborati dai vari responsabili dell’attività. Un lavoro da certosini che ricostruisce, anno dopo anno, le vicissitudini di questa esperienza.
Sono più di 400 pagine, non è quindi questa la sede per riassumerne i contenuti. Ci limiteremo a citare alcuni punti chiave che ci permettono di inquadrare il discorso. Una cosa merita di essere sottolineata: questa ricerca elenca una miriade di persone che si sono dedicate alle Colonie con grande impegno, serietà e competenza. Bello ritrovare le loro preziose esperienze in questo racconto.
Salute
La prima esperienza di colonia, promossa dalla giovane Camera del lavoro di Lugano, nata nel 1902, si realizza nel 1923 ad Astano e si chiama Colonia Proletaria di vacanze. Sarà una colonia che assomiglia piuttosto a un ospizio curativo, per combattere le malattie del tempo che colpivano la fanciullezza. Ad Astano si ritrovano 16 bambini, solo maschi, dagli otto anni e mezzo ai dodici. Di questi, sette sono italiani e nove venivano definiti, alla visita medica d’entrata, gracili.
Tra il 1931 e il 1938 la Colonia diventa dei Sindacati e si sposta a Varenzo, in Leventina. Lo scopo è ancora climatico assistenziale e l’aspetto educativo o pedagogico è assente. Nel 1939 la Colonia si insedia a Rodi ma nel periodo di guerra l’attività si interrompe.
Cittadinanza
Saranno gli anni cinquanta a ridare slancio al progetto. Vengono acquistate le prime case, la rosa e la gialla, e poi costruite le altre sedi, così che la Colonia diventa un villaggio, Solprimo. I giovani che partecipano sono ormai centinaia.
Negli anni cinquanta e sessanta la figura più importante al vertice dell’organizzazione è Basilio Scacchi, attivo all’Ufficio del lavoro, socialista militante e, assieme a Pietro Martinelli, Werner Carobbio ed Elio Galli, sospeso dal PST alla fine degli anni sessanta.
Scacchi ha un ruolo fondamentale nel promuovere la formazione dei monitori. Oltre all’aspetto legato alla salute dei ragazzi, assume maggiore importanza l’educazione alla cittadinanza. La Colonia non è solo svago ma anche educazione alla vita comunitaria, conoscenza dell’ambiente, lezioni di geografia, ecc. Fin dal 1953 a Rodi si introducono i corsi CEMEA (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva), organizzazione di origine francese che promuove nuovi modelli educativi.
Autogoverno
Lo spirito del tempo degli anni sessanta non può non contagiare anche Solprimo. Si discute sul senso della Colonia. Da una parte c’è l’esperienza educativa, dall’altro l’aspetto sociale e sindacale. Basilio Scacchi sottolinea l’importanza della partecipazione attiva e della collaborazione dei ragazzi con discussioni, conversazioni e incontri “allo scopo di favorire l’educazione all’autogoverno”. Un obiettivo molto ambizioso di non facile realizzazione. Il 68 crea qualche sussulto anche nelle case della Colonia, mettendo in discussione ruoli, funzioni e responsabilità dei diversi attori, dalla dirigenza, ai monitori, ai ragazzi. Scacchi nel 68 si dimette, a seguito della frattura all’interno del PST. Ma non manca di ribadire la sua convinzione: “sindacato e partito, anche se corrono su binari diversi sebbene paralleli, hanno il medesimo scopo: l’emancipazione dei lavoratori e cioè la loro liberazione dallo stato di subordinazione e di sfruttamento in cui sono tenuti dal sistema capitalista”.
Istituzione indispensabile
Il 1973 presenta una grande novità. Un riconoscimento dell’esperienza sindacale (e non solo perché vale anche per altre associazioni) di fare Colonia.
Il Cantone vota la “Legge sul promuovimento ed il coordinamento delle colonie di vacanza”, un traguardo importante e di grande valore politico, tant’è che il Messaggio afferma: “Considerato come la Colonia sia alla portata di tutti gli strati sociali, essa costituisce una istituzione operante nell’ambito dell’educazione popolare ed appare indispensabile come integrazione all’educazione familiare e scolastica”.
Senso di comunità
Gli anni passano e il mondo cambia. Negli anni ottanta il sindacato perde mordente, il numero dei partecipanti cala.
Anche le famiglie più modeste possono permettersi vacanze al mare o in montagna. Comunque le Colonie sopravvivono e all’interno si apre una riflessione sulle basi pedagogiche di fare Colonia e sulla qualità dell’azione sindacale nella società e sul senso della Colonia.
A quest’ultimo tema gli autori dedicano la seconda parte del volume, altrettanto ricca e interessante.
Due domande a Ilario Lodi
Tre storici protagonisti della Colonia dei Sindacati, Dario Mec Bernasconi, Giancarlo Nava e Ivan Pau-Lessi, concludono la loro presentazione con una proposta inedita: “Disciplinare per via legislativa per gli allievi dagli 8 ai 15 anni la frequentazione di almeno 3-4 turni di colonia sull’arco del periodo dell’obbligatorietà scolastica quale condizione formale per il conseguimento della licenza di scuola media”.
È d’accordo Ilario Lodi che, tra l’altro, è direttore di Pro Juventute?
Sì, certamente. Io ritengo che oggi i bambini e i giovani soffrano di un importante ‘deficit di collettività’; non imparano a (e quindi non sono costantemente in grado di) vivere insieme, e i motivi li conosciamo molto bene. Quindi: ben venga detta frequentazione, che offra a tutti la possibilità di poter imparare a vivere insieme, in società.
Qual è il senso e il valore della colonia oggi e domani?
Il senso dell’esperienza di colonia rimane profondamente educativo. La questione del senso delle Colonie dei Sindacati di Rodi come, credo, anche in altre colonie, è legata anche al problema della percezione che le famiglie hanno di questa iniziativa. Noi sappiamo bene che, oggi, le famiglie usano il tempo libero dei bambini e dei giovani per ‘recuperare’ o per ‘avanzare’ in ambiti che hanno direttamente a che fare con la scuola o con la preparazione al mondo del lavoro: durante l’estate non vado in colonia ma faccio dei corsi di recupero di inglese, o di matematica o di informatica.... Tutto ciò mi dice che dobbiamo investire maggiormente, in ambito di politiche familiari, sul senso delle attività residenziali non strettamente legate al ‘recupero’ di qualcosa che si teme il proprio figlio o figlia ‘non abbia adeguatamente colto’ (se posso esprimermi così...) ma votate ad un concetto molto più ampio, quello, appunto, di collettività. Per quanto attiene al futuro la questione rimane aperta: che impatto avranno le nuove tecnologie sulla crescita dei bambini e dei giovani, in chiave collettiva? Pongo la domanda in maniera provocatoria... Che effetti stanno generando l’esasperata individualizzazione e la sfrenata competitività a cui i giovani sono quotidianamente confrontati?
L’istituzione colonia è chiamata, oggi, a riflettere a fondo sul proprio senso, non riproponendo forzatamente modelli educativi e di gestioni che appartengono al passato, ma cercando di immaginarsi come una iniziativa ‘che prova a fare tendenza’, magari anche sviluppando qualcosa che, oggi, non ha ancora trovato cittadinanza alle nostre latitudini.