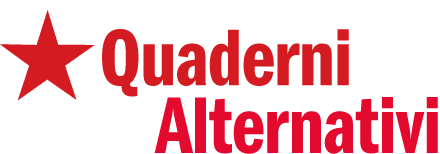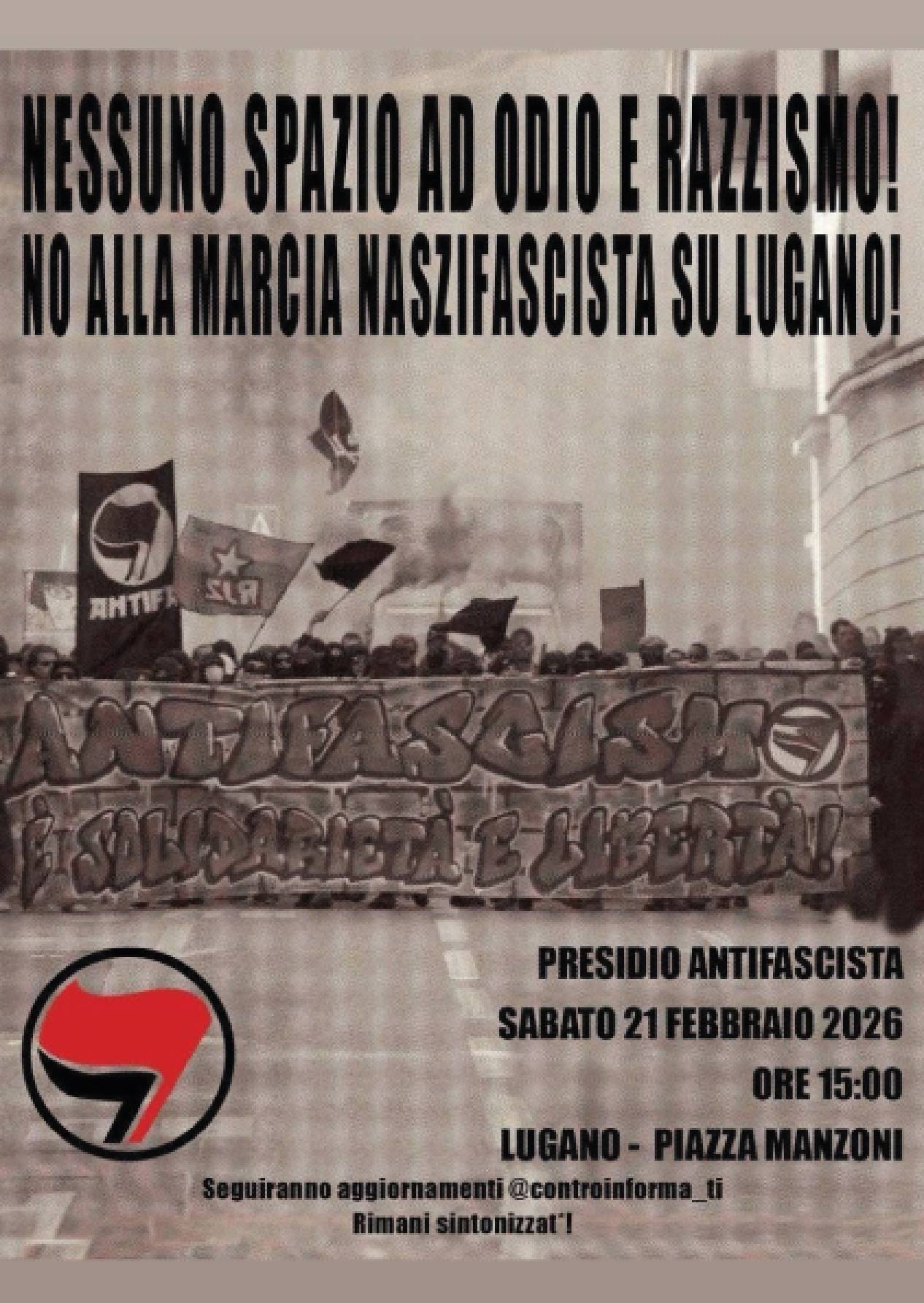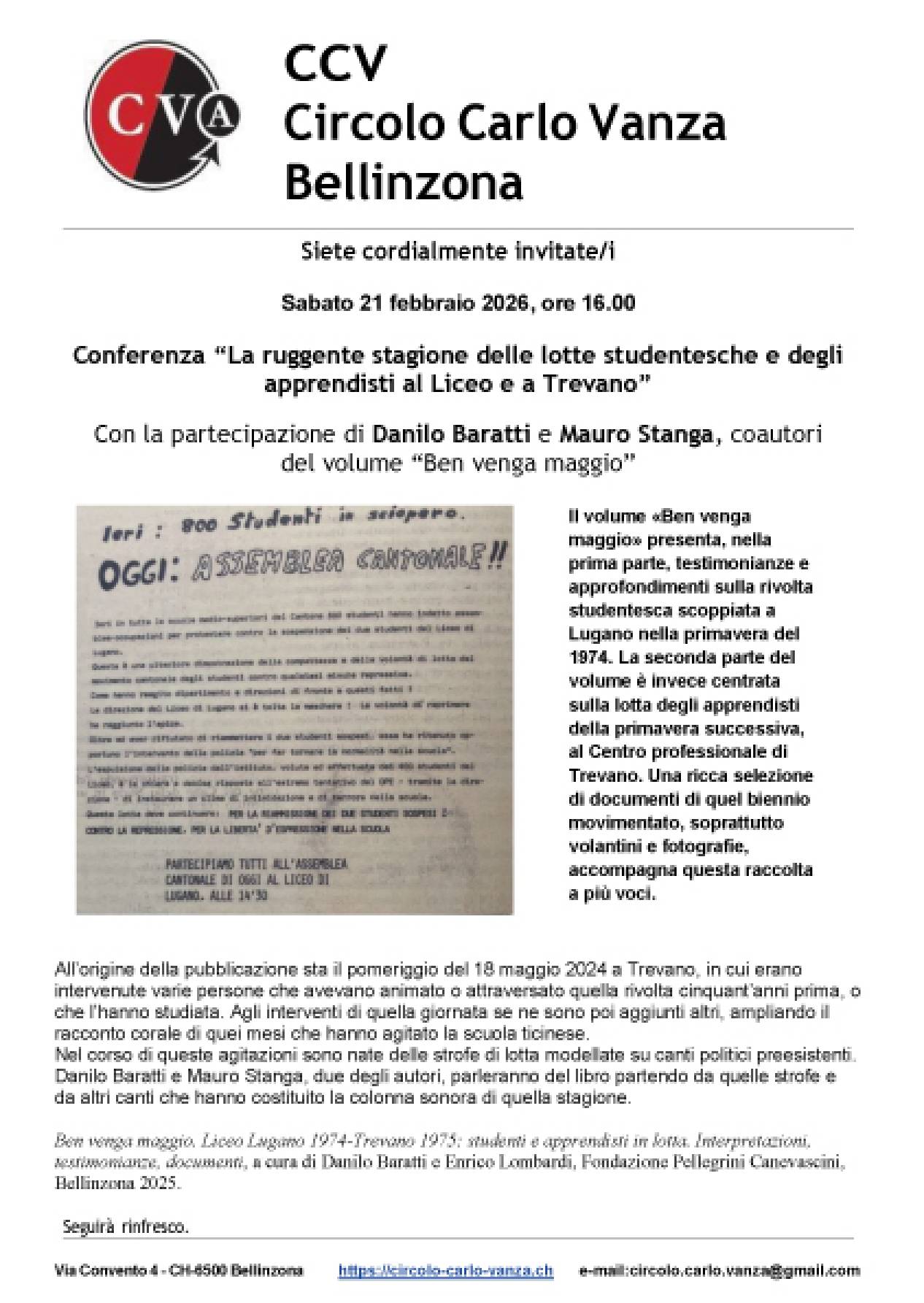Segreti svizzeri (Rizzoli 2023) è l’ultima di una serie di inchieste realizzate grazie a una fitta rete internazionale di giornalisti investigativi. Dopo i Panama Papers, i Pandora Papers o i Luxemburgs Leaks, le rivelazioni riguardano questa volta il Credit Suisse, banca che dal lontano 1977 (allora si chiamava Ska, Istituto di Credito Svizzero) con lo scandalo di Chiasso ha segnato, per lo più nel male, la storia del mondo bancario elvetico.
L’inchiesta, molto rigorosa, è stata coordinata da tre giornalisti del quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung in collaborazione con 48 testate internazionali e con la supervisione dell’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 18 mila conti passati al setaccio, ottenuti grazie a un “leak” (fuga di documenti) da parte di un anonimo impiegato, consentono di capire quanto, malgrado un complessivo miglioramento della trasparenza bancaria, gli affari sporchi hanno continuato a contrassegnare la vita di quello che è stato il secondo istituto bancario elvetico dietro l’UBS.
Autocrati, mafiosi, trafficanti di droga, torturatori, evasori fiscali, hanno potuto occultare cifre astronomiche (attorno ai 100 miliardi di dollari) grazie alla compiacenza (o a volte negligenza) dei responsabili della banca. Il libro, molto scorrevole e chiaro, rivela nomi in base al principio giornalistico dell’interesse pubblico: nessun piccolo pesce, ma capi di Stato, ministri, dirigenti d’azienda, responsabili dei servizi segreti dalla Russia all’Algeria, dalla Giordania all’Egitto, Venezuela, Paesi europei tra cui in primis la Germania. Se non segnaliamo i loro nominativi in queste righe, è per una ragione molto semplice: rischieremmo di essere accusati di violazione dell’articolo 47 della legge bancaria, incorrendo in una pena di prigione. Per la stessa ragione l’inchiesta non ha potuto avvalersi della collaborazione di giornalisti svizzeri, in particolare della cellula investigativa del gruppo Tx (ex Tamedia). Certo, dal 2010 la legislazione delle banche ha subito profondi mutazioni, in particolare dopo l’ammissione di colpevolezza con la quale nel 2014 il Credit Suisse riconobbe di aver volontariamente aiutato migliaia di cittadini americani a evadere le tasse pagando una multa miliardaria.
Dal 2017 (in seguito all’asfissiante e decisiva pressione statunitense e dei Paesi Osce) è in vigore con numerosi Stati lo scambio automatico di informazioni. In altre parole, le banche sono tenute a fornire al fisco di diversi Paesi i dati dei titolari dei conti. Ma, come ricordano gli autori dell’inchiesta, nessun accordo è stato siglato con una novantina di altri Stati. In teoria le banche svizzere dovrebbero comunque segnalare all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) i clienti sospetti: ma le segnalazioni, ci dicono gli autori di “Segreti svizzeri” sono molto rare, soprattutto se paragonate a quelle inoltrate dalle banche tedesche all’analogo loro istituto di sorveglianza. Criminali di mondiale notorietà hanno potuto aprire conti nominativi senza alcun ostacolo. La fuga di capitali, anche quando non strettamente in violazione della legislazione dei Paesi di provenienza, pone enormi problemi etici e sociali, come ricorda la direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio Ngozi Okonjo-Iweala: “Ogni giorno, soldi destinati alle scuole, alla sanità, alle infrastrutture nelle economie nazionali più deboli del pianeta vengono sottratti e nascosti in centri finanziari e paradisi fiscali in tutto il mondo”. Per anni le banche elvetiche, non solo il Credit Suisse, hanno contributo a questa sottrazione planetaria di risorse economiche. I miglioramenti negli ultimi anni sono innegabili, ma del tutto insufficienti, come dimostra questa importante inchiesta giornalistica.