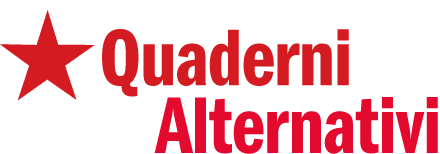La famosa livella di Totò è rotta, e insieme all’ascensore sociale andrebbe riparata: no, davanti alla morte non siamo tutti uguali. Le condizioni socioeconomiche (leggasi classe sociale), in particolare stato civile, formazione, occupazione e reddito continuano a incidere sulla durata della vita, ancora di più in seguito alla pandemia, come conferma un nuovo studio dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Ciò solleva interrogativi sull’accessibilità del nostro sistema sanitario sull'efficacia delle politiche sociali in Svizzera e su quanto viene fatto in termini di educazione alla salute e prevenzione. Ne abbiamo parlato con l’oncologo ticinese Franco Cavalli.
Professor Cavalli, dagli anni Novanta a oggi la speranza di vita generale è aumentata, ma le differenze in base a criteri socioeconomici sono ancora sinjnificative e non diminuiscono. C’è un problema di accesso al sistema sanitario?
Negli Stati Uniti, le differenze in termini di speranza di vita tra le diverse classi sociali (e il fatto che anche la sopravvivenza media generale stia addirittura diminuendo) sono perlopiù legate a problemi di accessibilità. Da noi, piuttosto, chi è ricco e ha un’assicurazione privata riceve certi medicamenti o trattamenti prima rispetto a chi non ce l’ha. Anche da noi, in termini più generali, ci sono quindi degli ostacoli nell’accesso alle cure, ma esistono anche altri fattori che peggiorano l’aspettativa di vita dei ceti sociali più sfavoriti: per esempio l’educazione, la disponibilità di informazioni, il fatto di essere più esposti allo stress sul lavoro, il fatto che si mangia peggio, si fuma e si beve di più perché si è meno informati e più stressati. Oggi è difficile trovare un manager che fumi, mentre ci sono tanti operai che lo fanno e che in più sono meno inclini ad andare in palestra, a fare sport o a impegnarsi per evitare di mettere su peso. Sono questi elementi – che sono correlati all’educazione, associata a sua volta al ceto sociale –, sommati allo stile di vita, che impattano sulla sopravvivenza o sullo sviluppo più frequente di malattie cardiache e tumorali.
In termini di salute pubblica, quindi, c’è stata e c’è tuttora poca considerazione per le questioni prettamente legate alla classe sociale?
Da noi, nelle scuole, andrebbe fatta molta più educazione alla salute. Bisogna agire già durante la gioventù: farla al liceo è troppo tardi, va fatta alla fine delle elementari quando i giovani sono molto più ricettivi. È lì che ci si forma una coscienza. C’è quindi poca istruzione alla salute nelle scuole e, inoltre, non c’è alcuna educazione mirata rispetto alla classe sociale. Eppure, si sa: chi appartiene alle classi sociali più svantaggiate mangia peggio, fa meno sport, fuma o beve di più. L’informazione che attualmente viene fatta è pensata in un modo che non arriva a chi dovrebbe arrivare e in modi non adatti: è fatta per quelli che in fondo, queste cose, le sanno già.
Oltre a problemi di informazione e sensibilizzazione, però, c’è anche un problema di accesso: per esempio, il cibo spazzatura costa molto meno del cibo sano e di qualità.
Certo, è un dato di fatto. Da noi, però, questa realtà è più smussata rispetto a paesi come gli Stati Uniti, dove un terzo della popolazione è sovrappeso – in particolare la popolazione più povera – proprio perché il cibo spazzatura costa poco. Da noi la realtà è meno drammatica, però è evidente che il problema riguarda anche noi.
La pandemia ha contribuito ad aumentare gli scarti di mortalità tra i diversi gruppi socioeconomici. Perché?
Chi faceva un lavoro ad alto reddito poteva lavorare da casa senza esporsi al pericolo, mentre chi faceva le strade o costruiva le case non poteva di certo lavorare da remoto. Anche se in Ticino si è verificato di meno, nel resto della Svizzera queste professioni hanno continuato a lavorare come prima e, quindi, sono state molto più esposte rispetto alle professioni intellettuali o impiegatizie. Oltretutto, queste persone erano di salute già meno buona rispetto agli altri, quindi subivano un decorso più difficile quando contraevano la malattia. Nel resto della Svizzera, inoltre (in Ticino meno, grazie alla struttura multilocalizzata dell’Ente Ospedaliero Cantonale che ha concentrato tutto a Locarno, consentendo agli altri ospedali di continuare a lavorare normalmente), molte delle attività diagnostiche non essenziali sono state bloccate. Pensiamo alle mammografie e agli screening: non essendo urgenti, non venivano fatti. Chi aveva soldi, quegli esami li ha potuti fare lo stesso, mentre gli altri no. In ogni caso, penso che l’aspetto determinante sia stato che queste persone sono state obbligate a continuare a lavorare.
Oltre a reddito e formazione, a incidere sulla speranza di vita è anche lo stato civile: le coppie sposate vivono di più. Lo studio chiarisce che a sposarsi sono più spesso le persone con un reddito alto e con un lavoro più prestigioso. In sostanza, allora, è davvero tutta una questione di soldi a disposizione?
In parte, sì. Pensiamo al divorzio, che spesso è più traumatico per chi è finanziariamente al limite. Per queste persone, divorziare costituisce una catastrofe alla quale è difficile sopravvivere e che causa una crisi esistenziale più grave rispetto a quella di chi sta bene economicamente. Anche l’elemento dello stato civile, quindi, porta con sé un aspetto monetario che diventa più pesante per le categorie sociali più deboli, e a ciò si deve aggiungere l’aspetto emotivo, dello stress, della sicurezza. Sicuramente non è solo una questione di reddito, ma è anche una questione di reddito.
Nonostante aspettative di vita diverse a seconda delle condizioni socioeconomiche, tutti andiamo in pensione alla stessa età. È un sistema coerente e giusto?
Assolutamente no, sono convinto che un’età di pensionamento uguale per tutti sia una cavolata. Il pensionamento a 65 anni è troppo tardi per alcune professioni, mentre per altre sarebbe addirittura meglio se si potesse lavorare fino a 70 anni o più. L’età di pensionamento dovrebbe essere flessibile, e trovo che questo concetto venga combattuto proprio perché non si vogliono riconoscere le innegabili e grandi differenze che le condizioni socioeconomiche comportano. Forse, anche per i sindacati non è un discorso così semplice. È poi però soprattutto la destra economica che cerca di ignorare il fatto che un dirigente vive 10-15 anni in più di uno spazzino o di chi passa la vita a costruire strade. Questa, comunque, è una realtà non solo svizzera: dappertutto è così. Ci sono realtà, come nel Nord dell’Inghilterra, dove le differenze di aspettativa di vita tra un certo gruppo sociale e un altro possono anche essere di vent’anni.
La letteratura medica è concorde nell’affermare che alcune disuguaglianze in questo ambito potrebbero essere evitate con politiche di sanità pubblica più adeguate. Come si potrebbe agire, nel concreto?
Bisogna prioritariamente agire sul fattore dell’accessibilità, ambito nel quale il grande problema è costituito dalle franchigie. Conosco persone che ricevono sussidi insufficienti o che non ne ricevono del tutto perché, per poco, sono oltre la soglia prestabilita. Queste persone mettono la franchigia a 2.500 franchi e dal medico, poi, non ci vanno mai. Ho conosciuto pazienti deceduti per un tumore diagnosticato tardi, perché nonostante la presenza di sintomi avevano paura ad andare dal medico a causa della franchigia. Se non eliminate, quindi, le franchigie andrebbero almeno calmierate tramite politiche sociali, perché rendono il sistema meno accessibile ai meno abbienti. Per quanto riguarda la prevenzione, le disuguaglianze – posto che non dovrebbero esistere – andrebbero almeno corrette con politiche educative mirate.
Anche i problemi mentali sembrano essere una questione di classe. Chi è senza reddito ha un rischio di mortalità legato a problemi mentali 5 volte più alto rispetto a chi ha un reddito medio-alto. Quali sono le altre malattie associate a un basso ceto sociale?
Precarietà, disoccupazione e difficoltà finanziarie creano stati di depressione e ansia. Aumentando i fattori di stress aumentano anche la frequenza e la gravità dei disturbi mentali, che possono avere pure conseguenze mortali: uno stato mentale precario causa uno stato di salute peggiore. Per quanto riguarda le altre malattie, oggi è dimostrato che anche i tumori sono più frequenti in chi è più povero e che, soprattutto, i poveri hanno più spesso un decorso peggiore (per questioni di accessibilità ad esami e trattamenti, di diagnosi precoce e di condizioni generali del fisico perché possa sopportare le terapie). Nell’ambito del World Oncology Forum, dove tracciamo un bilancio, a livello mondiale, sulle patologie oncologiche, è emerso che la crescita delle disuguaglianze sociali e della precarietà impatta sulle malattie, cancro incluso. Uno studio pubblicato qualche anno fa dal Registro tumori di Ginevra mostrava come nel cancro della prostata la sopravvivenza dei pazienti che appartengono al 10% più ricco della popolazione era doppia rispetto a quella del 10% più povero. Riassumendo: le tre grandi categorie di malattie oggi sono le malattie mentali, cardiovascolari e tumorali. In tutte e tre, chi è più povero è sfavorito. Non c’è dubbio.
Lo studio
Salute e longevità dipendono da lavoro e reddito
Dagli anni 70 l’aspettativa di vita media è aumentata di oltre 10 anni, non andando però a colmare le differenze in base alla classe sociale: chi guadagna meno ed è meno formato vive meno e queste differenze non tendono a diminuire: la pandemia, anzi, le ha esacerbate.
Uno studio sulla mortalità differenziale (cioè che esamina il tasso di mortalità su vari gruppi specifici della popolazione, in questo caso in base a criteri socioeconomici) era già stato svolto nel 2012, tenendo conto dei dati relativi al periodo 1990-2005. Il nuovo rapporto dell’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS), basato stavolta sui dati del periodo 2011-2022, chiarisce che i risultati confermano quelli ottenuti 13 anni fa: le differenze nella speranza di vita tra le varie classi socioprofessionali continuano a essere significative. Secondo gli autori, lo studio “mette in evidenza l’esistenza di scarti significativi in funzione dello stato civile, del livello di formazione, del reddito da attività lucrativa o della catgoria professionale, scarti che si protraggono nel tempo”. Le differenze di aspettativa di vita tra uomini e donne, in generale, diminuiscono, mentre a giocare un ruolo decisivo (oltre allo stato civile, con gli uomini coniugati che a 25 anni vivono in media 6 anni in più di quelli celibi) sono il lavoro e il livello d’istruzione. Per esempio, la probabilità che un uomo tra i 40 e i 49 senza attività lucrativa muoia nei cinque anni successivi è di 7 volte superiore rispetto a quella di un uomo che lavora. Per le donne, la probabilità è di circa 3 volte superiore. Per quanto riguarda la formazione, invece, a 25 anni l’aspettativa di vita di un uomo con un titolo di studio universitario è di 4 anni più lunga rispetto a quella di un uomo con un diploma delle scuole medie, 2 anni più lunga per le donne. Chi ha svolto una formazione universitaria, inoltre, risulta meno esposto a malattie tumorali e circolatorie (a cui sono più esposti gli uomini); cause di decesso, queste, fortemente legate a comportamenti quali lo stile di vita e la prevenzione.
Nelle persone con un livello di formazione più basso, sia uomini che donne, si è pure riscontrata una mortalità accresciuta in relazione al Covid. Questa serie di dati, quindi, “mette in discussione la nozione di uguaglianza di fronte alla morte e rende estremamente ineguale il rapporto tra gli anni di attività professionale e quelli di pensionamento”, interrogando, in particolare, proprio la bontà di un sistema pensionistico che prevede un’età di pensionamento uguale per tutti, nonostante sussistano grandi differenze in termini di aspettativa di vita proprio in base alla professione, al reddito e alla formazione. Sono sempre gli stessi autori della ricerca a sostenere che i dati raccolti a livello statistico per quanto riguarda la mortalità in base a specifiche categorie professionali sono manchevoli e insufficienti. Lo studio non è perciò potuto entrare nel merito, anche se è stato possibile confermare che "gli uomini con una funzione dirigenziale vivono più a lungo rispetto a quelli che svolgono professioni manuali o elementari”, grazie in particolare all’analisi della mortalità in funzione del reddito da lavoro che ha dimostrato come le persone che percepiscono un reddito minore presentino “un rischio di morte significativamente maggiore rispetto a quelle con un reddito elevato”. Infatti, per gli uomini che non dispongono di un reddito da lavoro o che ne percepiscono uno modesto, il tasso di mortalità è di circa 2-3 volte superiore a quello di chi dispone di un reddito medio o superiore.
Federica Bassi
Tratto da AREA del 21.03.25