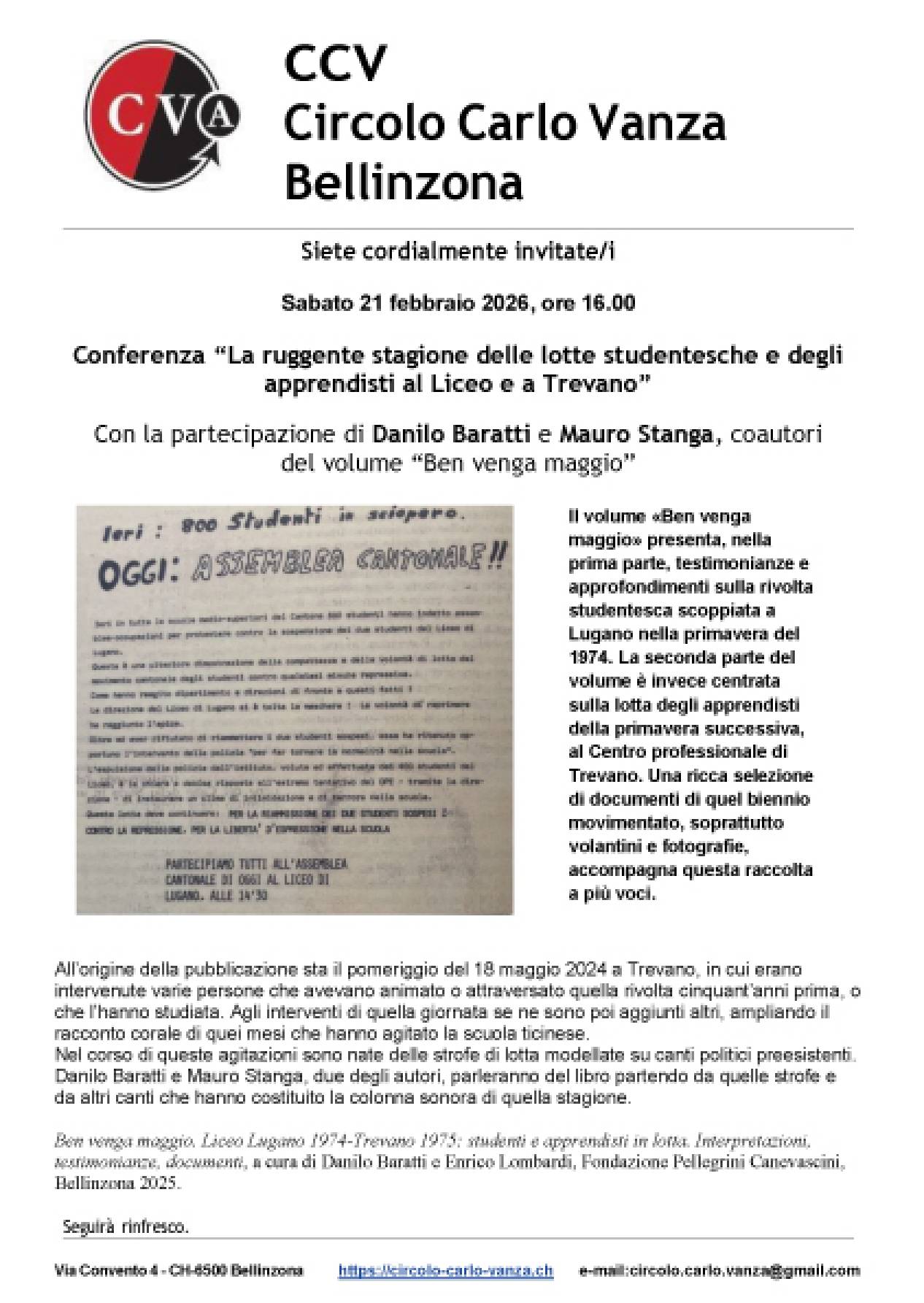Il capitalismo digitale ridefinisce il lavoro tramite dati, piattaforme, flessibilità estrema e controllo algoritmico, generando polarizzazione e precarietà. Cresce il lavoro gratuito, radicato in processi storici e nella digitalizzazione. Per invertire la rotta servono giustizia salariale, welfare inclusivo e investimenti in cura, formazione e partecipazione sociale. Del capitalismo digitale si parla in questo colloquio con Spartaco Greppi, responsabile, dal 2015 al 2025, del Centro competenze lavoro, welfare e società (CLWS) della SUPSI.
La realtà del capitalismo contemporaneo è caratterizzata da una molteplicità di fenomeni, sovente contraddittori, che ne determinano un continuo riassetto: l’avvento della globalizzazione (con l’accresciuta interconnessione delle catene globali del valore) e il recente ritorno delle politiche protezioniste; lo sviluppo di modelli di produzione flessibile connessi al toyotismo in un contesto generale dove permangono forme di taylorismo digitale; l’avvento delle piattaforme e del capitalismo digitale (automazione ed estrattivismo [1] di dati inclusi) e la diffusione delle nuove forme di lavoro gratuito; le nuove culture che circondano il lavoro, dall’autoimprenditorialità neoliberale sino alle forme di “rifiuto” dello stesso ascrivibili al quadro interpretativo delle “grandi dimissioni” [2].
Questo insieme di fenomeni, a prima vista lontani dal lavoro socioeducativo, in realtà lo riguardano estremamente da vicino, poiché definiscono gli assetti produttivi, sociali e culturali in cui l’attività educativa si trova a operare. Essi, infatti, contribuiscono a determinare i modelli di lavoratore e lavoratrice auspicati, gli standard di prestazione, le competenze richieste ai sistemi formativi e, più in generale, il clima rispetto a un’attività, il lavoro, che occupa e definisce gran parte delle esistenze individuali e collettive.
Abbiamo rivolto alcune domande a Spartaco Greppi, già Professore presso il DEASS e responsabile, dal 2015 al 2025, del Centro competenze lavoro, welfare e società (CLWS), attivo a livello di insegnamento e ricerca negli ambiti delle trasformazioni delle forme di sicurezza sociale e del welfare, delle politiche sociali, dell’evoluzione delle nuove forme di lavoro e, più in generale, delle condizioni lavorative, di vita e di salute.
Professor Greppi, nell’introduzione si è fatto riferimento ad alcuni dei molteplici fenomeni che circondano il lavoro. Nei suoi ultimi anni, ha molto lavorato sul tema del capitalismo digitale. Quali sono le sue principali caratteristiche? E quali le conseguenze sul mondo del lavoro (anche locale)?
Il capitalismo digitale si fonda su una nuova logica di accumulazione, in cui i dati diventano la principale risorsa economica e politica. Essi non sono semplicemente “raccolti”, ma estratti, elaborati e messi a valore attraverso il lavoro vivo e processi di automazione algoritmica che trasformano ogni interazione in una potenziale fonte di rendita e di profitto. Le piattaforme digitali rappresentano l’infrastruttura centrale di questo sistema: intermediando lavoro, produzione e consumo, si collocano al crocevia tra economia e vita quotidiana. Da un lato concentrano il potere economico e informazionale in poche mani, dall’altro impongono nuovi modelli di organizzazione del lavoro fondati su flessibilità estrema, sorveglianza digitale e remunerazioni variabili.
Queste trasformazioni accentuano la polarizzazione occupazionale: accanto a un segmento di professioni altamente qualificate e ben retribuite, cresce a livello planetario una massa di lavori precari, standardizzati e sottoposti al controllo algoritmico. La promessa di autonomia e di “autoimprenditorialità” si traduce spesso in isolamento, mancanza di tutele ed esternalizzazione dei rischi d’impresa ai lavoratori stessi. L’ideale della libertà digitale, sulla quale si era fondata la controcultura negli anni Sessanta, cela così nuove forme di subordinazione, rese meno visibili ma più pervasive.
Anche a livello locale queste dinamiche sono tangibili. Penso, ad esempio, al settore della logistica, ai servizi di cura o al lavoro culturale, dove le piattaforme ridefiniscono tempi, ritmi e compensi, spostando su chi lavora gran parte dei costi di produzione. Si pensi alla necessità di mantenere e migliorare le competenze professionali, agli investimenti in materiale ed equipaggiamento, ai costi legati alla mobilità spaziale. Anche quando il lavoro non è propriamente “digitale”, le sue logiche si diffondono per imitazione: la valutazione continua delle performance, la disponibilità permanente, la gestione algoritmica delle risorse umane e la monetizzazione dei dati organizzativi stanno permeando imprese e istituzioni di ogni tipo.
In questo senso, il capitalismo digitale non rappresenta soltanto una fase tecnologica, ma un nuovo sistema di potere e di soggettivazione, che trasforma la natura stessa del lavoro e del valore. Il compito della riflessione critica è dunque quello di decifrarne i meccanismi, ma anche di individuare spazi di resistenza e di reinvenzione del lavoro, affinché la tecnologia possa essere messa al servizio della dignità umana e non viceversa.
Il fenomeno del lavoro gratuito [3] è stato un suo tema di ricerca importante negli ultimi anni. Esso richiama da vicino il rapporto tra il tempo di vita e di lavoro, il tema della cura (in particolare per le donne), ma anche il riconoscimento della prestazione lavorativa, sia in termini di straordinari, sia di prestazione non retribuita tout court. Perché a suo avviso viviamo una sua diffusione? Quali sono le ragioni storiche della sua affermazione e quali le sue conseguenze?
La diffusione del lavoro gratuito è uno dei fenomeni più rivelatori del capitalismo contemporaneo. Essa non è frutto di una semplice deriva etica o culturale, ma il risultato di processi storici profondi che si intrecciano: la crisi del fordismo, la precarizzazione postindustriale, la retorica neoliberista dell’autoimprenditorialità e, più recentemente, la digitalizzazione dell’economia. Negli ultimi decenni, l’idea che il lavoro debba generare un reddito proporzionato allo sforzo impiegato è stata progressivamente erosa, sostituita da una logica in cui la disponibilità, la passione e la “vocazione” vengono considerate parte integrante della prestazione lavorativa stessa.
Il lavoro gratuito si manifesta in molte forme: dalle ore non retribuite – ore straordinarie, reperibilità costante, micro-attività digitali - alle collaborazioni “volontarie” e ai tirocini non pagati, fino all’attività di produzione di contenuti online, che genera valore economico per altri senza alcun riconoscimento per chi li produce. Si tratta di un fenomeno che, lungi dall’essere marginale, struttura interi segmenti del mercato del lavoro, specialmente quelli giovanili e femminili.
Storicamente, la gratuità si radica nella svalutazione del lavoro di cura e di riproduzione sociale, tradizionalmente femminile, rimasto per lungo tempo invisibile o non riconosciuto economicamente. Il neoliberismo ha poi esteso questa invisibilità a nuovi ambiti: oggi si pretende che ogni individuo “investa su di sé”, accettando di lavorare gratis in cambio di opportunità future o visibilità. Non a caso si parla di “economia della promessa”. Il digitale amplifica ulteriormente questa tendenza, rendendo porosi i confini tra tempo di vita e tempo di lavoro e trasformando ogni gesto – un clic, una recensione, un like – in fonte di valore estratto e monetizzato altrove.
Le conseguenze sono molteplici. Si accentuano le disuguaglianze di genere e di classe, si indebolisce il nesso tra occupazione, sicurezza economica e protezioni sociali, si consolidano forme di sfruttamento che spingono le persone a percepire la gratuità come normale o inevitabile. Ma, soprattutto, si perde il senso del lavoro come diritto e come mezzo di emancipazione. La sfida politica e culturale consiste allora nel riportare alla luce questa dimensione nascosta, restituendo dignità e riconoscimento a tutte le forme e di attività che producono valore sociale, economico e relazionale.
In questo panorama a dir poco complesso e nebuloso, caratterizzato da una precarizzazione e da un impoverimento crescenti, quali sono a suo avviso le politiche sociali e del lavoro che potrebbero permettere un cambio di rotta?
Invertire la tendenza verso la precarietà, la gratuità e la svalutazione del lavoro richiede un ripensamento profondo delle politiche sociali e del lavoro. Non si tratta solo di adattare il welfare alle nuove forme occupazionali, ma di ridefinire il rapporto tra economia, società e cittadinanza. Occorre partire dal riconoscimento che il lavoro, in tutte le sue forme, resta un pilastro di coesione e di dignità: non un costo da contenere, ma un bene comune da tutelare e valorizzare.
A mio avviso, le priorità si articolano su tre assi principali.
Il primo riguarda la giustizia salariale e temporale: servono salari minimi dignitosi, una riduzione effettiva dei tempi di lavoro e una regolamentazione più severa degli straordinari e della reperibilità, per contrastare la normalizzazione del lavoro gratuito. L’obiettivo non è solo redistribuire reddito, ma restituire tempo, autonomia e salute alle persone.
Il secondo asse concerne il rafforzamento della protezione sociale. I sistemi di welfare devono includere chi lavora in forme “atipiche” o intermittenti – freelance, lavoratori delle piattaforme, indipendenti – oggi non sufficientemente protetti e spesso esclusi dai regimi di assicurazione sociale. Ciò implica un’estensione delle coperture assicurative, ma anche una semplificazione delle procedure di affiliazione e accesso alle prestazioni e una fiscalità che non penalizzi il lavoro indipendente. In questa direzione, andrebbero esplorate soluzioni innovative, come un reddito minimo garantito dignitoso o strumenti di reddito di base incondizionato, che rafforzino la libertà di scelta e riducano la dipendenza da impieghi precari o sottopagati.
Il terzo asse riguarda le politiche di investimento che riconoscano valore economico e sociale alla cura, alla formazione continua, alla cultura e alla partecipazione civica. Investire nel welfare, nella scuola, nella sanità, nella cultura, nell’educazione significa sostenere la riproduzione sociale senza la quale nessuna economia è sostenibile. Ma serve anche una politica industriale capace di orientare la transizione digitale verso obiettivi di equità e benessere, promuovendo tecnologie che estendano le capacità umane anziché ridurle.
Solo ricomponendo queste dimensioni sarà possibile ridare senso al lavoro e restituirgli la funzione di strumento di emancipazione, anziché di precarizzazione. La posta in gioco non è solo economica, ma democratica: riguarda il tipo di società che vogliamo costruire.
[1] Cfr. Mezzadra S., Neilson B. (2021), Operazioni del capitale. Capitalismo contemporaneo tra sfruttamento ed estrazione, manifestolibri, Roma.
[2] Cfr. Coin F. (2023), Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita, Einaudi, Torino.
[3] Greppi S., Cavalli S., Marazzi C. (2022), La gratuità si paga. Le metamorfosi nascoste del lavoro, Edizioni Casagrande, Bellinzona.
Tratto da DEASS/SUPSI
Intervista a cura di Simone Romeo, docente professionista