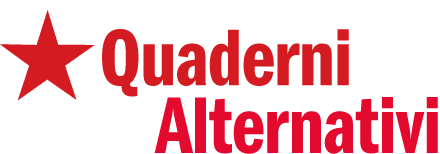Attraverso una succinta storia dei migranti che hanno segnato 100 anni fa l’inizio del riconoscimento di Ascona e Locarno come centro artistico, filosofico e politico europeo, vorrei segnalare il progressivo slittamento squalificante delle rappresentazioni dominanti sulla migrazione e interrogare il conseguente smarrimento della memoria storica di questo nostro patrimonio non soltanto nelle giovani generazioni.
Siccome io non sono una storica, ho cercato quali fossero le pubblicazioni attendibili su questo tema e ne ho travati ben pochi nonostante il fatto che la presenza degli stranieri in Svizzera costituisca oggi un fatto sociale, politico, economico e culturale di primaria importanza. Per la chiacchierata odierna mi sono basata sulla tesi di laurea di Angela Garrido del 1987, Le début de la politique fédérale à l’égard des étrangers1, sul saggio di Gérald e Silvia Arlettaz, La Suisse et les étrangers, immigration et formation nationale 1848-1933 del 20042 e su quello di Joëlle Kunz, La Suisse ou le génie de la dépendance del 20133 che mi hanno rivelato un cambiamento di prospettiva sugli stranieri durante la Prima Guerra mondiale del quale ero totalmente all’oscuro. Vedremo come questa svolta costituirà il fondamento di una politica nazionale radicata nel timore degli stranieri e sulla volontà di controllarne gli spostamenti.
Ma vorrei iniziare con una piccola parentesi personale
Il ramo paterno della mia famiglia attraversa la storia europea a partire dalla seconda metà del 19° secolo ed è stata confrontata all’evoluzione del discorso politico sugli stranieri dall’inizio dei flussi migratori in Svizzera. Brevemente il mio nonno paterno era un ebreo lituano nato a Pinsk nel 1859 quando ancora la Lituania faceva parte dell’impero Russo. Era un avvocato, un uomo politico e un membro della Duma, il primo parlamento dell’impero zarista nel 1906-1907 nonostante l’antisemitismo e i Pogrom contro gli Ebrei in seguito alla crisi agraria russa. Durante gli ultimi 20 anni del XIX° secolo i Pogrom producono multiple conseguenze: l’emigrazione di 600'000 Ebrei, il coinvolgimento di molti giovani intellettuali nei movimenti socialisti e la creazione del movimento sionista. È dunque per sfuggire ai Pogrom zaristi del 1903 che mio nonno ha fatto partire la moglie, le due figlie e mio padre per la Svizzera dove un’élite intellettuale europea veniva allora bene accolta. Lui è rimasto al servizio della comunità ebraica lituana come Ministro per gli affari ebraici fino alla morte di Lenin nel 1924. Poi con Stalin non è più riuscito a negoziare un’esistenza vivibile per gli ebrei in Unione Sovietica e, da convinto sionista, è emigrato in Palestina dove ha vissuto fino alla sua morte a Tel Aviv nel 1934. Mio padre, arrivato ancora bambino in Svizzera nel 1903, è stato rapidamente naturalizzato. A quell’epoca la naturalizzazione era considerata come il miglior modo di integrare i nuovi venuti nel territorio nazionale. Poi mio padre ha vissuto il cambio del discorso politico ufficiale rispetto agli stranieri a partire dalla Prima Guerra Mondiale che ha prodotto lo slittamento dalla rappresentazione di “banale cittadino” a quella di “Papierschweizer”.
Ma per parlare della rappresentazione dello straniero in Svizzera devo fare un passo indietro nella storia per situare e capire come e quando è nato il concetto di cittadinanza svizzera nel nostro territorio.
Una circostanza storica maggiore determina la costruzione dell’identità nazionale confederata ed è la fondazione dello stato svizzero moderno:
Al Congresso di Vienna del 1815 tutte le potenze europee che hanno sconfitto Napoleone ridisegnano l’Europa e proclamano fra altre anche l’indipendenza e la neutralità della Svizzera. Ma fra il 1820 e il 1840 il neostato rischia di esplodere con la guerra civile del Sonderbund in cui i Freisinnige liberali e progressisti hanno la meglio sui cantoni cattolici e conservatori. Questa frattura si perpetua fino al giorno d’oggi. Ma è a partire dalla costituzione del 1848 che esiste una Svizzera contemporanea come la conosciamo oggi e che inizia la laboriosa elaborazione del concetto di cittadinanza svizzera. Infatti il nostro territorio era fino allora una federazione di Cantoni, piccoli Stati autonomi, che disponevano di importanti diritti, in particolare quello di otorgare la cittadinanza a una persona di un altro cantone o di un altro paese. Nella Costituzione del 1798 si era creato un indigenato elvetico riservato ai soli Patrizi e abitanti perpetui di un comune, tutti gli altri essendo reputati stranieri. Nel 1848 viene dunque istituito uno stato federale che abolisce le frontiere interne fra cantoni, che impone una moneta unica e un esercito di milizia federale. Tutto ciò che può unire i confederati viene allora privilegiato e pubblicizzato dai fautori dell’opinione per far sì che una parte dei loro radicati sentimenti di appartenenza cantonale, religiosa e linguistica si spostino verso la nuova Confederazione. È così che vengono costruiti i miti fondatori dell’Helvezia e di Guglielmo Tell. Infatti la prima sfida che il paese deve affrontare dopo la guerra civile è innanzitutto l’integrazione del popolo svizzero nello spazio nazionale. Perciò in una visione liberale dominante, la maggioranza delle formazioni politiche preconizzano una politica di assimilazione per tutti, cioè sperano di annullare l’alterità grazie ad un assorbimento giuridico e culturale. La conseguenza di questa politica è anche la naturalizzazione degli stranieri equiparati ai Confederati stabiliti al di fuori dei loro cantoni d’origine. Il concetto di nazionalità svizzera entra nel vocabolario giuridico soltanto con la revisione della Costituzione del 1874!!!
La credenza diffusa fra molti specialisti, è che il fenomeno della rappresentazione squalificante dello straniero risalga agli anni 1950-60, e cioè al periodo in cui la Svizzera ha avuto bisogno di operai soprattutto italiani per costruire le infrastrutture del paese. Ma in realtà il fenomeno risale alla ribollente storia europea degli anni 1880 per raggiungere il suo primo apice nella Grande Guerra.
Perciò durante la seconda metà del XIX° secolo la rappresentazione dello straniero diventa un elemento costitutivo della scena socio-politica nazionale, il respingente necessario all’elaborazione di un’identità nazionale confederata ancora mal definita.
La costruzione del “problema degli stranieri”
Nel primo periodo della storia moderna della Confederazione i dirigenti politici del paese affermano dunque che l’assimilazione dello straniero viene ottenuta grazie alla naturalizzazione: l’idea dominante non è di limitare l’immigrazione o di espellere, ma di prendere gli stranieri e “farne degli Svizzeri” (Boissier 1911). Per questa élite liberale e repubblicana, è attraverso l’esercizio dei diritti politici che lo straniero è portato ad interessarsi alla vita nazionale e alle istituzioni svizzere e soltanto la naturalizzazione può conferire questi diritti agli stranieri. Perciò il pensiero dominante di questo primo periodo è che la naturalizzazione è la condizione necessaria dell’assimilazione.
Questa concezione di una assimilazione civile e civica degli stranieri alla vita politica svizzera è accompagnata da una visione culturalista della società. Infatti postula che i valori svizzeri ne costituiscono la misura e che lo straniero deve sentirsi chiamato a contribuire all’avvenire di una nazione viva, imitando i nostri mitici avi e offrendo cuore e braccia per la difesa degli interessi comuni (Georges Addor). Persino delle jus soli parziali vengono accordate da certi cantoni.
Inoltre la proclamata tradizione dell’accoglienza è una costante del discorso politico svizzero e assume un carattere mitico durante tutto il XIX°sec4. È l’attualizzazione di un ideale collettivo integrato in un’ideologia nazionale in costruzione che intende rinforzare la coesione del paese. La missione caritativa della Svizzera viene valorizzata per servire da cimento morale all’integrazione nazionale. Soprattutto rispetto alla politica estera, l’asilo viene definito una manifestazione di indipendenza, una cauzione morale che valorizza una politica di neutralità necessaria al mantenimento dell’indipendenza del paese. È in questa prospettiva che il discorso ufficiale qualifica il diritto d’asilo come l’espressione della sovranità nazionale, una “massima della politica svizzera”.
Comunque nella Costituzione del 1848 l’asilo e la politica dei rifugiati dipendono ancora dalla polizia degli stranieri attribuita ai Cantoni. La Confederazione interviene soltanto per espellere dal territorio quei rifugiati che compromettono la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Sul piano del diritto l’asilo non è codificato. Una legge sarà elaborata solo nel 1979.
Fino alla Prima Guerra Mondiale, l’onda liberale e socialista che attraversa l’Europa fa sì che arrivino nella nuova Confederazione molti anarchici russi, antimilitaristi e socialisti perseguitati dalle leggi antisocialiste di Bismark. Questi esiliati si integrano all’azione politica di stampo repubblicano e le frange conservatrici cominciano a considerarli come una minaccia potenziale per la società svizzera poiché molti si coivolgono nei nascenti movimenti operai e pure in un’azione “transnazionale” con lo scopo di promuovere la pace. Dal 1880 in poi e fino alla 1° guerra mondiale, l’immigrazione operaia diventa infatti un fattore importante per l’industrializzazione e la modernizzazione delle infrastrutture del paese.
Ma durante la Prima Guerra mondiale la politica svizzera riguardo agli stranieri si modifica completamente. Questa rottura costituirà un nuovo tipo di rapporti fra Svizzeri e stranieri.
Nel contesto turbato del conflitto europeo, il tema dell’immigrazione di guerra si trasforma in ossessione per la borghesia. Gli stranieri vengono designati come “indesiderati”. In particolare la questione della naturalizzazione alimenta un vasto dibattito spesso xenofobo. Una nuova morale patriottica scava il fossato fra nazionali e stranieri. D’ora in poi non si tratta più di assimilare gli stranieri ma di controllarli. La pratica della naturalizzazione viene capovolta: l’idea dominante diventa che la naturalizzazione verrà d’ora innanzi otorgata soltanto agli stranieri già assimilati, cioè a quelli la cui mentalità corrisponde allo spirito svizzero e che vi sono domiciliati da lungo tempo.
Eppure durante la Grande Guerra, la popolazione straniera in Svizzera diminuisce di 1/3. Bisogna sottolineare che durante tutto il secolo 19°, la Svizzera è stata un paese di emigrazione e che il rovesciamento della bilancia migratoria risale al 1888. Ma la maggioranza dei dirigenti politici e dei media lo occultano. Speculano su dati immaginari e soprattutto sull’arrivo di un’immigrazione di guerra giudicata perturbatrice di un ordine sociale già fragilizzato dalle ostilità. La Svizzera accoglie dei prigionieri di guerra internati ma soprattutto disertori e refrattari agli eserciti stranieri. La paranoia di una potenziale invasione di militari smobilitati, di socialisti e anarchici, di prodotti stranieri che ambiscono di ottenere il marchio svizzero, supportano un nuovo slogan demagogico e manipolatore, quello di Überfremdung. Questo vocabolo polimorfo rappresenta il vettore per eccellenza di un’ideologia nazionalista armata per combattere e eradicare tutto ciò che non viene considerato come autenticamente svizzero.
Già nel 1885 cominciano ad apparire i termini di “aumento anormale”, “situazione malsana”, “infiltrazione”, “invasione”, “colonizzazione” che si generalizzano nel 1914 in un discorso che presenta gli stranieri come una popolazione pericolosa. In modo generale, la situazione professionale e sociale degli immigrati, diversa a seconda delle origini, diventa un fattore discriminatorio.
- Gli Italiani, concentrati nei cantieri in condizioni di vita deplorevoli, suscitano reazioni xenofobe e razziste. L’avvicinamento fra socialisti svizzeri e italiani avvelena ancora maggiormente il clima.
- L’espansione tedesca e l’ascendente crescente del Reich sulla Svizzera viene risentita come una minaccia pangermanica dagli ambienti francofoni. Molti universitari sono tedeschi e la Germania procede a investimenti finanziari bancari e industriali.
- Le piccole comunità di persone originarie di paesi dell’Europa Orientale e gli Ebrei diventano particolarmente sospetti. Perdono pure le loro appartenenze proprie che si dissolvono nella designazione generale di Slavi, Orientali, Levantini ecc.
Ma soprattutto è la definizione di assimilazione che cambia a partire dalla Grande Guerra:
- La concezione di assimilazione viene capovolta: si considera La naturalizzazione come l’ultima tappa dell’assimilazione. Questa evoluzione dell’atteggiamento rispetto agli stranieri costituisce il passaggio della Svizzera da una concezione repubblicana a una concezione etnica di nazione.
Più profondamente, è il sistema nazionale di rappresentazione, cioè i valori politici, sociali e culturali, considerati come substrato collettivo, che si modifica. Con il questionamento della cultura politica liberale degli anni 1900-1914, si sostituisce una nuova idea di patria. Questa concezione si riallaccia a una tradizione e a una strategia identitaria che rompe con la razionalità civica della partecipazione.
Nel 1915 la propaganda razzista si espande nella stampa conservatrice. Il miscuglio delle razze viene presentato come il più grande pericolo per la patria e per il carattere nazionale. Si auspica una separazione stretta fra nazionalità e l’attribuzione restrittiva della jus soli alle persone di stessa razza, cioè ai Tedeschi in Svizzera tedesca, ai Francesi in Svizzera romanda e agli Italiani in Ticino, escludendo dal diritto di cittadinanza i non Europei, gli Slavi, i Turchi, gli Orientali e gli Ebrei. Quello che conta è la cultura, la formazione e l’educazione che modellano l’uomo. Questo processo si realizzerebbe soltanto nella seconda generazione, l’unica che possa “sentirsi svizzera”, l’immigrato adulto rimanendo uno straniero.- Questo discorso inizia con l’arrivo dei prigionieri di guerra feriti, poi convalescenti che possono lavorare e che vengono designati come una minaccia per i posti di lavoro nostrani.
- Poi sono i disertori o refrattari chiamati “rifugiati militari” che non vengono riconosciuti come rifugiati politici e non beneficeranno mai del diritto di asilo anche se non verranno espulsi durante la durata del conflitto. Nel 1917, dopo la rivoluzione russa, l’opinione e la stampa reclamava l’espulsione di tutti gli “immigrati di guerra” indesiderabili. La parola d’ordine era “La Svizzera agli Svizzeri”. È così che il 1 maggio 1918 il Consiglio Federale rovescia i fondamenti della politica d’asilo. D’ora in poi, disertori e refrattari che vorranno attraversare la frontiera dovranno essere respinti.
È così che i tempi per inoltrare le richieste di naturalizzazione si allungano rapidamente: 2 anni nel 1903, 4 anni nel 1917, 6 anni nel 1920 e 10 nel 1941. Persino la naturalizzazione facilitata per i giovani stranieri cresciuti in Svizzera viene rifiutata nel 1983 e nel 1994.
Alla politica di assimilazione grazie alla naturalizzazione si sostituisce una politica di immigrazione restrittiva e selettiva che si fonda sulla situazione del mercato del lavoro, sulla presunta capacità di accoglienza del paese e sulla difesa dell’identità svizzera.
La cultura liberale che ha prevalso prima del conflitto cede il passo a una idea di patria che si richiama d’ora innanzi a una tradizione identitaria passeista:
-
- Nel 1933 si istituiscono i 4 tipi di permesso di soggiorno o
- Le autorità cauzionano lo slogan “Das Bot ist voll”
- Nel 1991 viene elaborato il modello dei tre cerchi: se l’immigrato è europeo, viene classificato in una categoria che porta il nome del suo paese: spagnolo, portoghese, italiano. Al dilà del Mediterraneo le appartenenze nazionali vengono fuse in raggruppamenti per etnie che non corrispondono alle realtà territoriali.
Il concetto di Überfremdung
Siccome la Grande Guerra ha radicato nell’opinione svizzera la falsa convinzione che il paese è sovrapopolato di stranieri, l’armistizio genera la paranoia di una “invasione pacifica”, sia intellettuale che economica, in particolare da parte dei tedeschi.
Il concetto di Überfremdung, inizialmente legato alla menzogna di un eccedente demografico, si è allargato per designare ora l’insieme delle cariche, reali o supposte, attribuite alla presenza straniera e che costituirebbero un pericolo per la formazione nazionale al punto di costituire un rischio di “denazionalizzazione” della società svizzera attraverso
- Una Überfremdung culturale;
- Una Geistige Überfremdung, spirituale. I “cittadini del mondo” disprezzerebbero le antiche tradizioni e segnerebbero la cultura indigena con la loro impronta;
- Una Überfremdung economica per via di una penetrazione anormale di mano d’opera, di imprese e di capitali stranieri;
- Una Übefremdung come vettore di ideologie nazionaliste: già nel 1915, con lo scopo di combattere la Ausländerei, si valorizzano i dialetti, il Heimatschutz, il canto popolare, la letteratura passeista ecc.
Da qui parte la petizione del 1918 “La Svizzera agli Svizzeri”, poi nel 1919 la “Asländerinitiative” e il discorso xenofobo e antisemita.
Lo straniero accumula tutti gli handicap: abita in città, lavora nell’industria, importa teorie politiche internazionaliste e praticamente non appartiene al ceto contadino. La sua figura può essere soltanto negativa.
Nel 1919 i leitmotiv del partito agrario sono la preminenza della cellula familiare, il gusto per una vita semplice, la gioia del lavoro, la religiosità, il patriottismo, l’attaccamento ai valori agrari. Da lì nasce l’immagine della Svizzera ideale: una Svizzera che conserverebbe un settore primario dominante; dove l’importanza della popolazione cittadina sarebbe controbilanciata dal ruolo di guida morale dei contadini; una Svizzera infine che vivrebbe in stato di totale indipendenza rispetto ai suoi vicini e dove la proporzione di stranieri verrebbe ridotta al minimo necessario. Un’immagine nostalgica e sorpassata, ma questo discorso passeista è rivelatore della profonda crisi ideologica che attraversa il paese nel dopo-guerra.
Che il sottogruppo degli Altri – gli stranieri – sia stato designato come capro espiatorio di questo malessere è quello che dimostra il lancio della prima iniziativa sugli stranieri del 1921, preceduta dal mito del Patto del Grütli forgiato nel 1920 dai Repubblicani e dalla Nouvelle Société Helvétique.
Nelle fonti ufficiali l’immagine degli stranieri è molto contrastata e categorizzata:
- Un primo livello etnocentrico: si fonda sulla differenziazione sempre espressa fra Svizzeri e stranieri: lo straniero si trova al livello inferiore di una scala di valori impliciti. Basti pensare all’uso del termine allogeno per designare lo straniero. Questo vocabolo sottintende una differenza biologica fra la nazionalità svizzera e gli altri, e dunque il carattere quasi irreversibile dell’appartenenza nazionale. Ciò che ne consegue è una difficoltà a riconoscere i naturalizzati come degli autentici cittadini.
- Il secondo livello di categorizzazione è selettivo: opera una discriminazione all’interno del gruppo degli stranieri. E questo secondo una visione molto manichea poichè si distingue fra i buoni e i cattivi stranieri, fra i desiderabili e gli indesiderabili (come nel racconto Milò di Alberto Nessi appena uscito). Quanto ai tratti specifici di ciascun gruppo, le minute del Consiglio degli Stati e del Foglio Federale fra il 1919 e il 1921 sono edificanti:
- Lo straniero desiderabile dev’essere sinceramente attaccato alla Svizzera, stabile, di buona moralità e mentalità, culturalmente imparentato al popolo svizzero, acquisito alle abitudini elvetiche. Ma deve anche godere di buona salute, essere materialmente autosufficiente, economicamente utile alla Svizzera e politicamente moderato.
- L’indesiderabile è opportunista, bugiardo, instabile, magari con un fedina penale o di dubbia moralità e con una mentalità inadattata alla Svizzera. È anche politicamente sovversivo – e lì entriamo in una terminologia molto forte – semplicemente losco, tarato, pericoloso, per tutto dire nocivo. (Consiglio degli Stati 1919, 1921; Foglio Federale 1919, 1920, 1921).
Nel messaggio del 1920, il Consiglio Federale menziona in modo ripetitivo (19x) i termini di apprensione, timore, pericolo urgente, pericolo nazionale. È la pretesa Überfremdung che alimenta la paura e il discorso sulla Svizzera che deve resistere, lottare contro l’invasione.
Sopprimendo la libera circolazione in Europa e invalidando i trattati dei permessi di soggiorno, la Guerra a creato le condizioni favorevoli all’adozione di una vera politica di limitazione dell’immigrazione. Il fondamento riposa su un ulteriore concetto demagogico avanzato nel 1920, quello della Aufnahmefähigkeit der Schweiz che è il prolungamento logico del concetto di Überfremdung istituito qualche anno prima.
Sempre nel 1920, il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia parla di Lieferung von Bauarbeitern con lo statuto di stagionale. Le persone sono ormai solo “mano d’opera”.
Attorno allo sciopero generale del 1918, la stampa liberale non esita ad amalgamare dei termini diversi come sindacalista, anarchico e terrorista (Gazette de Lausanne). L’immagine dello straniero viene denigrata: lo si qualifica di ripugnante canaglia, gentaglia. A partire da alcuni casi precisi di atti reprensibili compiuti da persone di nazionalità straniera, si effettua la convalidata generalizzazione che getta il discredito su tutti gli stranieri.
Conclusione
L’obbiettivo dei politici degli anni 20 è quello di normalizzare le legislazioni d’eccezione adottate durante gli anni di guerra e dell’immediato dopo-guerra.
La formula di Überfremdung non è da rapportare ad un aumento della popolazione immigrata poiché il tasso di stranieri stabiliti in Svizzera cala, ma bensì al contesto di crisi economica e ideologica degli anni 20 e 30.
Il corpo sociale cerca di ridefinire la sua svizzeritudine. Finalmente si assiste all’emergere di un nuovo patriottismo portatore di nazionalismo con tinte xenofobe che verrà tanto più assunto e diffuso dai partiti conservatori che si coniuga con un marcato antisocialismo.
Appena mezzo secolo dopo, negli anni 60-70, assisteremo di nuovo all’espressione di una forte spinta xenofoba. E poi a quella del giorno d’oggi con i Musulmani come nuovi capri espiatori. Ma uno studio che mostrerebbe fino a che punto si può stabilire un parallelismo fra questi tre periodi resta ancora da fare. Infatti i numerosi lavori dedicati alle iniziative lanciate dall’Azione Nazionale o UDC hanno tutti omesso di segnalare l’esistenza di questo precedente nella Svizzera turbata degli anni 20.
Un oblio storico che i saggi che ho consultato hanno parzialmente contribuito a riparare ma che deve continuare a interrogarci.
1 Annales d’Histoire et Société Contemporaines de l’Université de Lausanne
2 Société d’Histoire de la Suisse Romande, Antipodes, Lausanne
3 Ed ZOE, Le Temps
4 Con Dufour e Dunant e la creazione della Croce Rossa.
Francine Rosenbaum,
saggista e formatrice etnoclinica,
Ascona