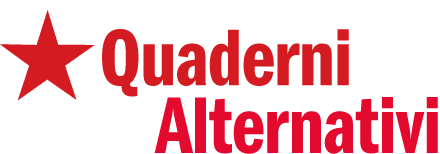Il successo di candidati progressisti nelle elezioni dell’ultima domenica di agosto in Guatemala ed Ecuador hanno riacceso caute speranza di un «anelito democratico» di cui il subcontinente latino americano ha estremo bisogno.
Da anni, infatti, le inchieste di Latinobarómetro indicano che «l’America latina sta attraversando un periodo di alti livelli di critica alla forma mediante la quale esiste e si disimpegna la democrazia». Per ampli settori della popolazione non importa la natura democratica o meno dei governi-regimi, quanto i risultati che vengono ottenuti (o prospettati).
L’esempio più citato è il presidente Nayib Bukele che ha trasformato il Salvador in una gigantesco carcere per contenere la violenza criminale delle maras, ma anche qualsiasi forma di opposizione alla fine dello Stato di diritto. Recenti inchieste informano che Bukele mantiene un tasso di approvazione popolare attorno al 70%. E che al suo modello di “regime di eccezione” (dallo Stato di diritto) si riferiscono ormai vari leaders delle destre, dal neo vincitore delle primarie in Argentina, Javier Milei, a María Fernanda Cabal, esponente di punta della destra uribista in Colombia, allo schieramento di Bolsonaro in Brasile, a José Antonio Kast in Cile. Ma anche la presidente progressista dell’Honduras, Xiomara Castro, ha adottato una linea dura «alla Bukele» contro le pandillas.
L’indifferenza al tipo di governo-regime dimostra come i cittadini latinoamericani si siano in generale allontanati dalla politica, dichiarando che «les da lo mismo» che i governi siano democratici o meno, purchè diano risultati concreti soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Se i governi e i partiti progressisti non hanno potuto dar sbocco alle richieste di miglioramento di vita, partecipazione democratica, lotta alla corruzione e sicurezza che vengono dal basso, «non possiamo incolpare la gente perché ci volta le spalle» nelle urne, afferma l’ex vicepresidente e analista boliviano Álvaro García Linera. In sostanza, per García Linera, una parte pesante di responsabilità è del progressismo latinoamericano della “seconda ondata rosa” di questo secolo che si è progressivamente spostato al centro e ha perso la parte radicale dei programmi dei leader della precedente “ondata”, Correa in Ecuador, Morales in Bolivia, in parte i Kirchner in Argentina e, naturalmente, Chavez in Venezuela. Certo, l’elezione di Lula in Brasile in un quadro politico e sociale sfavorevole alle forze popolari è stato un evento di importanza strategica. Ma non si può ignorare che, per riconquistare la presidenza, Lula ha dovuto allearsi anche con uno schieramento che di sinistra non ha nulla. E nemmeno che il suo governo non ha la maggioranza in parlamento per portare avanti riforme radicali. Un quadro simile caratterizza anche il governo del presidente colombiano Gustavo Pedro e ben peggiore è la situazione del governo cileno di Gabriel Boric.
In aggiunta a queste difficoltà degli attuali governi e schieramenti progressisti bisogna tener conto, e non è un fattore di secondo piano, di una crescente militarizzazione delle società latinoamericane, che si sta rafforzando dalla crisi mondiale del 2008 e che mira al mantenimento – anche se non in prima persona come negli anni del golpismo del secolo scorso – dei poteri oligarchici che hanno fatto dell’America latina «la regione con maggiori diseguaglianze del mondo».
Ma vi è anche un fattore nuovo: «Nello scenario latinoamericano sta facendo un’incursione una nuova ultra destra razzista e antifemminista, con discorsi peggiorativi in relazione alle donne, al matrimonio ugualitario e alle dissidenze sessuali», avverte l’analista argentino Aram Aharonian. Nei fatti, la formazione di una destra estrema ha una propria dinamica, interna e globale, ed è il risultato dell’incrocio tra la finanziarizzazione del capitalismo e i nuovi modi di produzione di soggettività liquide e senza storia. Si è attuato così «un corte historico (globale) che ha prodotto un nuovo tipo di soggettività neoliberale e autoritaria: da Trump (Usa) a Abascal, Ayuso, Le Pen, Meloni (in Europa). E Bullrich, e Milei in Argentina. «Non collegare il “fenomeno” Milei a quanto accade fuori dell’Argentina sarebbe come ritenere che il negazionismo nei confronti del cambio climatico sia un prodotto locale», afferma l’analista Jorge Aleman.
Come conseguenza di questa congiuntura di crisi dei partiti politici, anche progressisti, la cittadinanza cerca altre alternative per trovare soluzioni alle sue richieste prioritarie (gravi problemi economici, corruzione, sicurezza dei cittadini, enorme forbice sociale). Soluzioni che si prospettano anche contrarie al sistema istituzionale e che «propongono un modello autoritario, una specie di “regime plebiscitario”, una sorta di modello iper-presidenzialista, sottraendo margine di azione ai contrappesi istituzionali, alle opposizioni, ai partiti e anche all’opinione pubblica» sostiene García Linera.
In questo quadro, riferendosi al Guatemala, dove più chiara è stata la vittoria dell’esponente progressista del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, eletto (col 58% dei voti) nuovo presidente, è bene ribadire la cautela. Sconfitta nelle urne l’oligarchia, corrotta e di destra, che da decenni controlla tutta l’istituzionalità del Guatemala, ha avviato un lawfare – «un golpe politico in nome della legge», come afferma la scrittrice Arantxa Tirado (2021) – per impedire che Arévalo assuma la presidenza. O che abbia una forza parlamentare e una legittimità per dar vita al suo programma di creare «una nuova primavera democratica» in Guatemala. All’inizio di settembre Arévalo ha denunciato un tentativo di golpe iniziato dal procuratore generale María Consuelo Parras – noto braccio legale dell’oligarchia – e altri alti funzionari per «rompere l’ordine costituzionale» e impedire che il presidente e gli eletti del Movimiento Semilla possano insediarsi alla presidenza e in Parlamento.
Altrettanto complicata è la situazione in Ecuador dove la leader progressista Luisa González (in testa col 33% dei voti nelle elezioni di agosto) rischia di essere battuta nel ballottaggio del 22 ottobre dalle destre coalizzate attorno al suo avversario, il giovane imprenditore (milionario) Daniel Noboa. E in un clima di violenza nel quale i militari possono dire far sentire la propria voce.
Sia Arévalo che Gomez hanno rivolto un appello allo schieramento democratico e progressista internazionale perché sia garante del rispetto della volontà delle urne e impedisca colpi di stato “legali” o meno.
Ed è proprio questo l’obiettivo prioritario che le sinistre e gli schieramenti democratici devono saper mettere in campo per impedire che le ultra-destre si sbarazzino di Arévalo e impongano Milei o Noboa. «Il campo popolare ha la necessità, più che mai, di rimanere unito con un programma economico e sociale chiaro. E deve essere disposto – come fanno Lula e il Pt in Brasile – a costruire alleanze assai ampie per difendere la pace e i diritti fondamentali del popolo» affermano gli analisti argentini Alejandro Grimson e Claudio Katz.
Ma poi si deve cambiar strada: il progressismo deve assumere linee di vera sinistra «sintonizzandosi con le preoccupazioni diarie della popolazione» (García Linera) e saper impostare una democrazia dal basso (Zibechi, Aharonian). «Perché dall’alto si costruiscono solo i pozzi» (Katz).