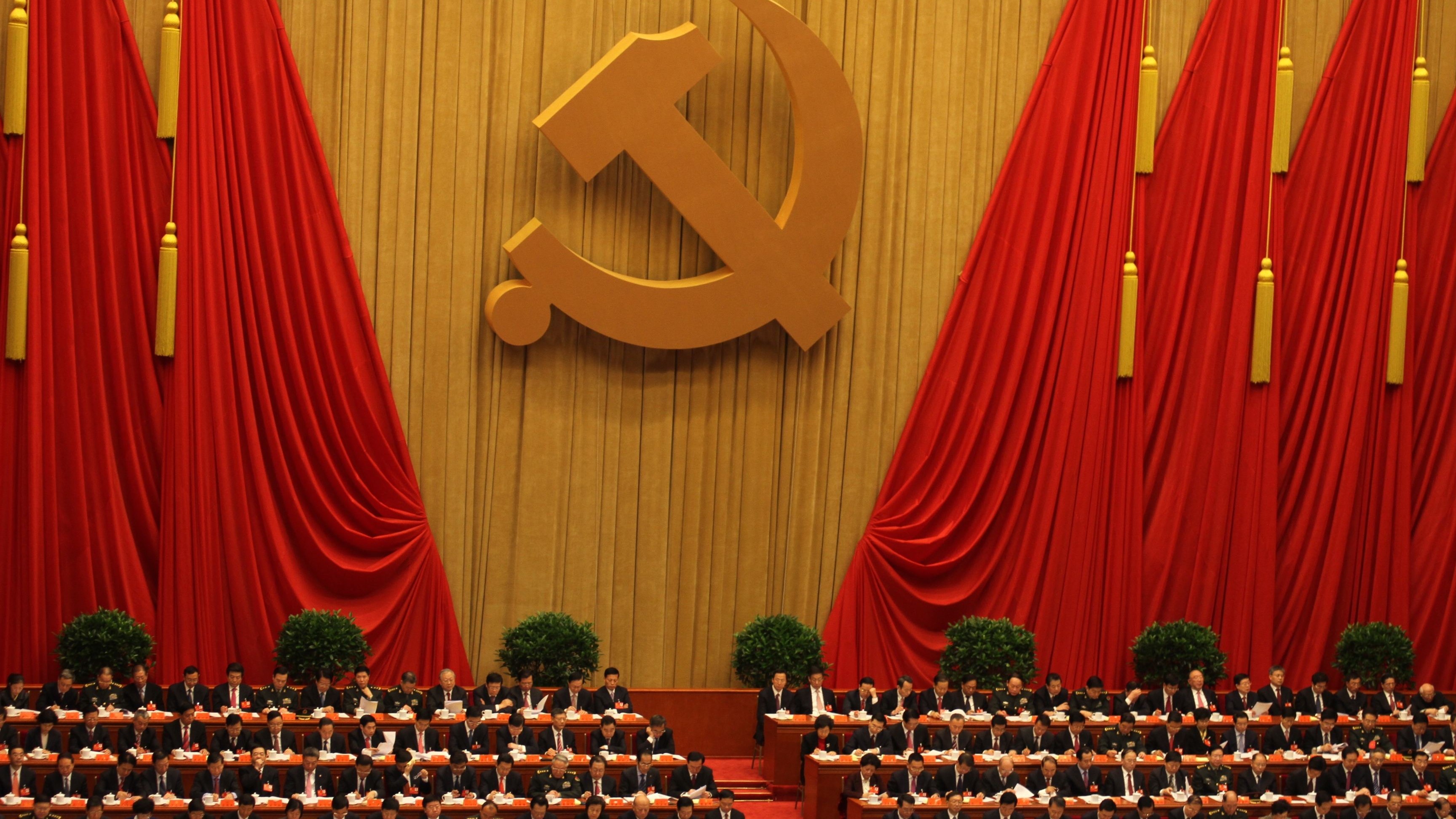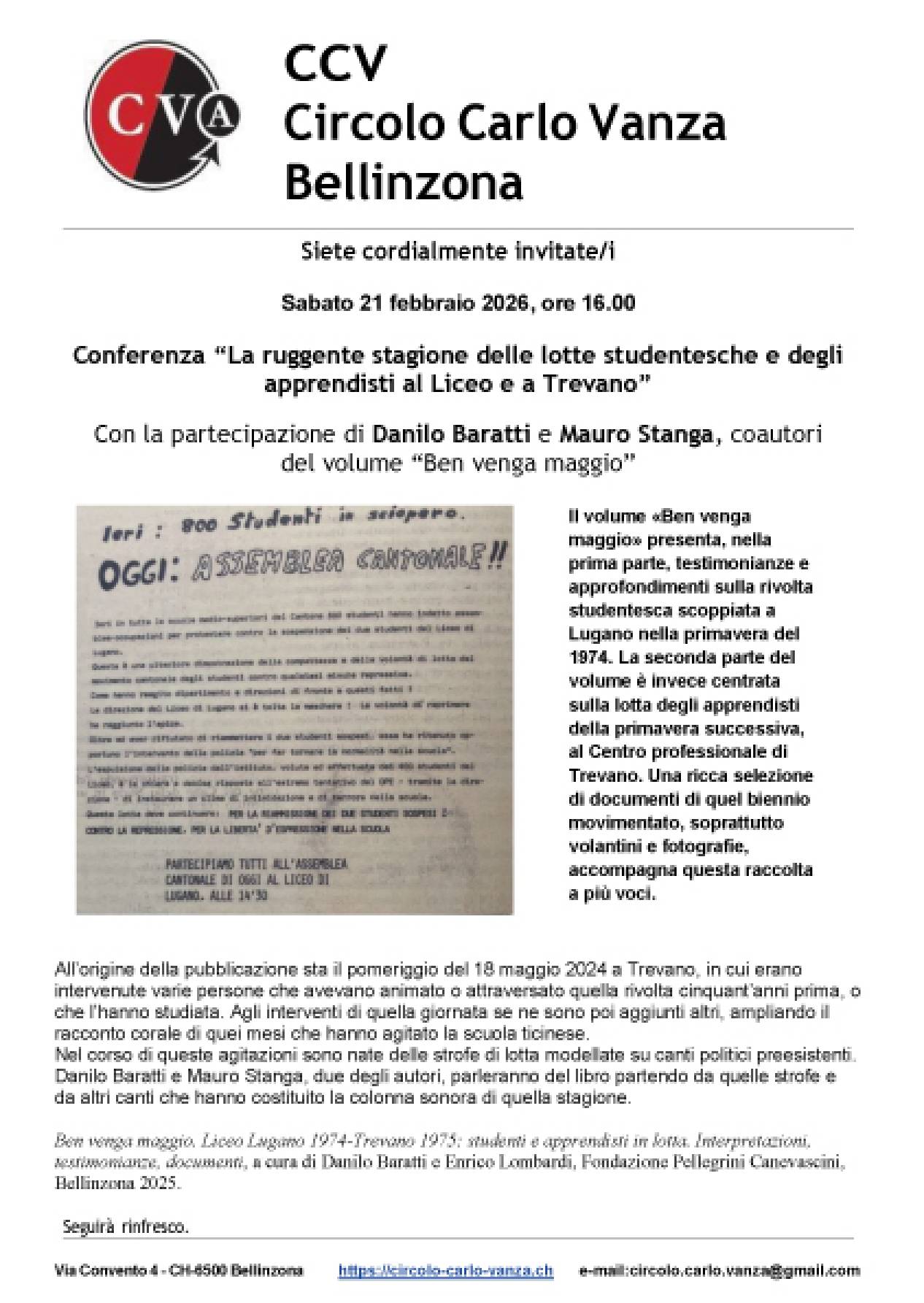Può apparire strano ai suoi detrattori, ma in Cina esiste un dibattito. Sfuggente, cambia luoghi e approcci, si difende da attacchi, talvolta perisce, altre volte riesce addirittura a lambire e ad avere udienza presso i vertici del Partito comunista. In sostanza, talvolta non si sa neanche dove trovarlo. Spesso infatti evapora, insieme ai siti e agli account social di intellettuali che hanno passato un limite: non si sono solo limitati a ragionare, ma hanno criticato apertamente il Partito.
Altre volte, invece, da aule universitarie o minuscole librerie raggiungibili solo grazie al passaparola, alcune riflessioni diventano proprie del Partito comunista, come accaduto con la cosiddetta «Nuova Sinistra», una sigla nella quale si è fatto rientrare in generale ogni intellettuale schierato con la necessità di riequilibrare socialmente lo sviluppo cinese e frettolosamente liquidati come «neomaoisti».
La «Nuova Sinistra» aveva rilanciato l’esigenza di una redistribuzione delle ricchezze, di una rinnovata attenzione alle zone più povere del paese. Tra il 2002 e il 2012, durante la leadership di Hu Jintao alla presidenza e Wen Jiabao premier, alcuni di questi intellettuali avevano trovato udienza e grandi possibilità di esprimersi. La leadership di allora arrivava dalla Lega della gioventù comunista, una sorta di serbatoio di futuri leader e funzionari tradizionalmente composta da persone di origini umili e provenienti dalle zone più povere del paese. Poi è arrivato Xi Jinping – un «principino», figlio di uno dei grandi vecchi del Partito – ed è cambiato tutto.
Xi ha imposto una chiara connotazione ideologica al proprio mandato, dimostrato dall’inserimento all’interno della Commissione permanente del Politburo (il cuore politico del paese) di Wang Huning, un ideologo, sostenitore di un «neo autoritarismo» che pare calzare a pennello con l’impronta voluta da Xi Jinping. La conseguenza è stata la chiusura di molti spazi pubblici o virtuali di confronto, un clima di sospetto nei confronti di professori considerati a rischio, quando non direttamente rimossi.
Nonostante questo, il dibattito non si è fermato, così come gli ammonimenti. Xi Jinping ha riportato in auge il «sogno cinese», e oltre a chiari riferimenti a Mao non ha mai mancato di ancorare la propria leadership ai grandi classici cinesi, come Confucio. Proprio seguendo la strada dei classici tanto cara a Xi, qualche anno fa un suo tiepido sostenitore come Cao Jinqing, professore di sociologia e oggi in pensione, aveva messo in guardia il Partito da corruzione e abusi, ricordando cosa è accaduto alle dinastie che persero il «mandato celeste». Rivolte, guerre, disastri sociali. Altri, come il professore dell’Università di Nanchino Liu Xiulian, sono intervenuti su un dibattito molto acceso riguardo la cultura del lavoro in Cina e le tante denunce dei post ’95 sui ritmi stressanti e l’obbligo di fare sempre straordinari (da cui è seguita una campagna feroce del Pcc contro le piattaforme).
Non mancano poi le riflessioni sulla «governance», su come procedere con riforme in senso democratico, senza modificare l’assetto politico del paese.
A questo proposito, Yu Keping, un intellettuale considerato «liberale», autore di un libro tradotto anche in inglese dal titolo «Democracy is a good thing», racconta che «ci sono slogan sui valori fondamentali appesi ovunque, ma dobbiamo prenderli sul serio e metterli davvero in pratica. In assenza di democrazia, libertà e giustizia, cos’è il socialismo? Come siamo cambiati? I nostri cambiamenti sono avvenuti per lo più a livello di governance, con modifiche al rapporto tra centro e regioni o attraverso una evoluzione del governo da una posizione di controllo a una di servizio nei confronti delle persone, verso quello che assomiglia sempre di più a uno stato di diritto». Yu Keping è ottimista – o vuole sembrarlo, ben sapendo come funziona la censura in Cina – ma indica un tema fondamentale per capire il gigante asiatico, ovvero la tensione tra lo Stato incarnato nel Partito comunista e il governo, l’amministrazione: è in questo secondo campo che le riforme in senso democratico possono trovare più agibilità, senza mutare o criticare la struttura politica del paese. Lo dimostra il nuovo codice civile, la nuova legge sulla privacy, le preoccupazioni che ormai molti intellettuali dimostrano nei confronti dei rischi della sorveglianza.
Ordine internazionale: la Cina all’esterno
Sebbene con fatica, il dibattito all’interno della Cina dunque procede, ma si deve confrontare con il resto del mondo e con una tendenza che sembra delinearsi all’orizzonte, ovvero lo scontro tra democrazie e autocrazie, come emerso dall’ultimo G7 e dal summit Nato svoltosi quasi contemporaneamente. Al riguardo, abbiamo molto chiaro quale sia l’idea di ordine internazionale americano – ne abbiamo avuto molte applicazioni anche – ma si parla pochissimo di quale sia quella cinese, di cui si suppone sempre una volontà egemonica e volta a scoperchiare l’attuale rete di relazioni tra Stati. Diventa dunque importante, al di là di registrare le reazioni di rito di Pechino, esaminare un aspetto: che idea ha la Cina del futuro dell’ordine internazionale? Una delle pietre angolari dell’idea cinese di ordine internazionale è la sovranità. Sottolineare i concetti di sovranità e del rispetto della sovranità altrui serve a Pechino per richiedere che anche gli altri facciano lo stesso con la Cina, cioè non interferire nei suoi affari interni.
Quanto all’ordine internazionale, la posizione cinese è piuttosto chiara: abbiamo vissuto per anni sotto l’egemonia americana – sostengono i cinesi – che ha disegnato le relazioni internazionali in un certo modo, ovvero utilizzando i valori occidentali per valutare qualunque Stato.
Secondo la Cina questo «mondo» è cambiato. Per Pechino, ad esempio, ogni paese è libero di perseguire «la propria via nazionale alla modernità e di respingere le influenze ideologiche occidentali. Ciò porta a rifiutare l’idea che un ordine globale debba necessariamente essere fondato su una radice normativa comune e su valori comuni, quali democrazia, liberalismo e diritti umani» (come spiega in modo egregio Matteo Dian in La Cina gli Stati Uniti e il futuro dell’ordine internazionale per Il Mulino).
Date queste premesse, secondo la Cina il nuovo ordine dovrebbe essere basato sulla cooperazione pacifica e sull’armonia: senza pretese di cambiare i sistemi politici altrui non ci sarebbero problemi, pensano a Pechino.
Ma tutto questo presuppone un altro concetto: il Tianxia (letteralmente «tutto quanto è sotto il cielo»). Come scrive il giurista cinese Liang Zhiping in una definizione molto precisa, «Tianxia descrive un ordine morale universale efficace, senza limiti geografici o etnici». Ovviamente si tratta di un ordine sinocentrico, risalente all’epoca imperiale. Alla base del Tianxia c’era il riconoscimento della Cina come civiltà superiore, espresso attraverso i tributi. Oggi questa teoria è di nuovo in voga, perché Xi Jinping ha agganciato la storia del Pcc a quella della storia antica cinese, facendo diventare il Partito il custode di tutta la storia cinese e il suo massimo interprete nei tempi contemporanei. Anzi, è il continuatore della grandezza cinese.
Ecco allora che il concetto di «società armoniosa» può essere esteso alle relazioni internazionali; ecco che il «sogno cinese» diventa il sogno di una «comunità dal destino condiviso». In pratica la Cina ci racconta due cose: che è una potenza benevola e che paternalisticamente si pone alla guida di un nuovo ordine retto dal concetto di «win win» di cui la Cina è guida e garanzia. E che la Cina non è più un paese da «integrare» nell’ordine voluto da americani e Occidente, perché oggi, raggiunto lo status di potenza mondiale, può essere invece creatrice di un nuovo ordine basato non su valori ritenuti universali (che per i cinesi, e non solo, tali non sono), ma sulla cooperazione volta alla crescita delle economie e del benessere di tutti i paesi.
Può apparire una visione un po’ ingenua o addirittura subdola, e ovviamente pone molti interrogativi e dilemmi, ma al momento – ed è per ora la forza della proposta cinese – non presuppone un «modello» da esportare né con le buone, né con le cattive. E questa visione si può rifiutare, ovviamente. Ma non si può non tenerne conto o non conoscerla.