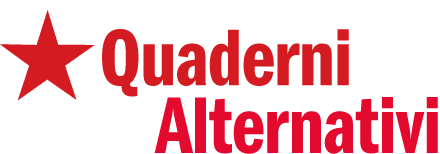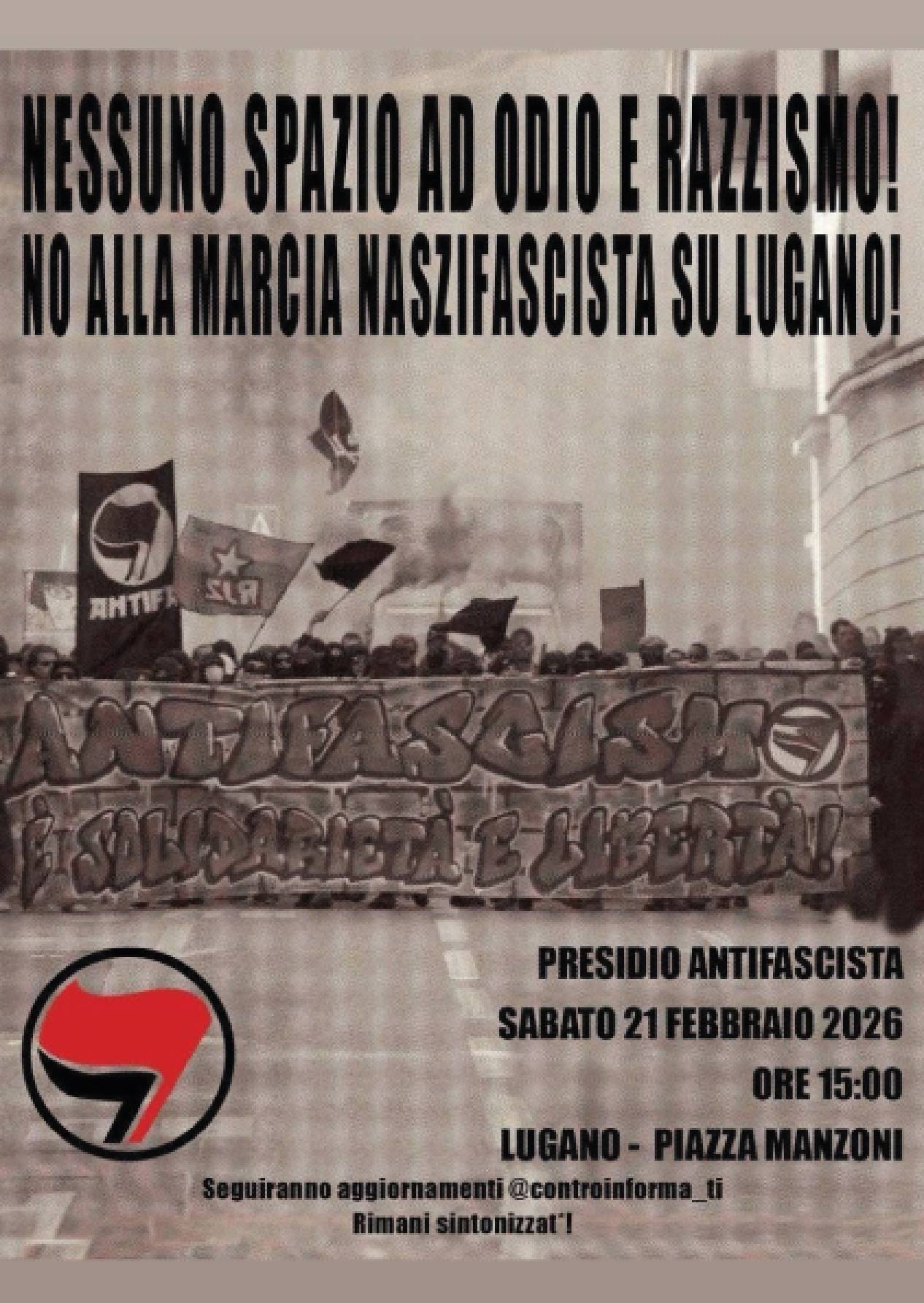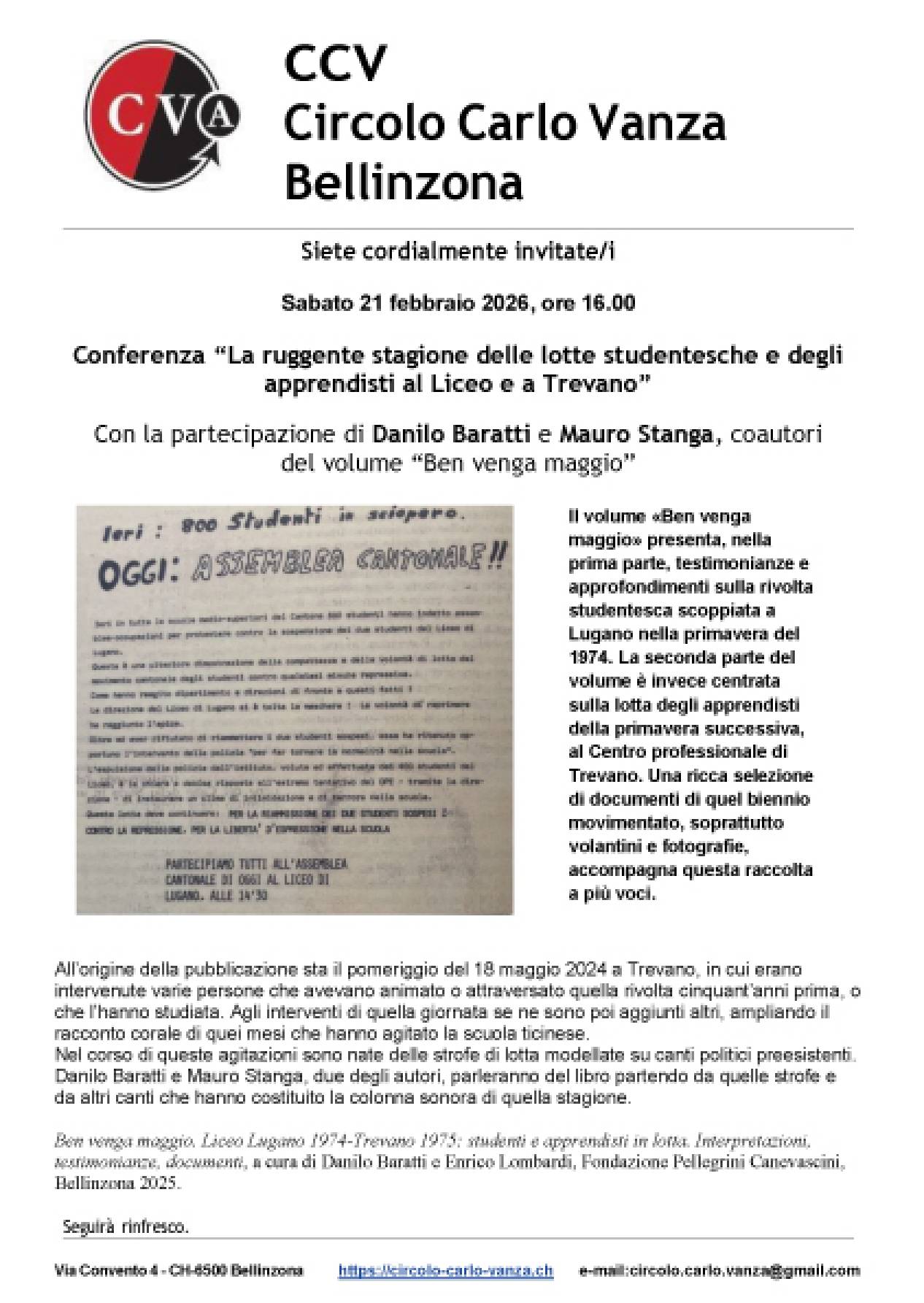Nota della redazione dei Quaderni.
Ci sembra doveroso precisare che il seguente simil-comunicato del Partito Comunista, un po’ declamatorio e polemico, non corrisponde alle attese che avevamo riposto nei confronti di Zeno Casella – di cui abbiamo avuto modo in passato di apprezzare i contributi concreti, rigorosi e propositivi – al momento di invitarlo a scrivere un articolo per la nostra rivista. Sorvolando sulle varie polemiche sollevate, ci aspettavamo qualcosa di più che un appello alle nazionalizzazioni, le quali sono senz’altro una parte della risposta al problema del cambiamento climatico, ma non l’unica. Fatta questa premessa, l’analisi del voto offerta qui di seguito è più che valida e merita le dovute riflessioni, mentre la proposta delle nazionalizzazioni tocca una questione importante della lotta al cambiamento climatico sin qui passata sotto silenzio.
Lo scorso 13 giugno, il popolo svizzero ha respinto in votazione la revisione della Legge federale sul CO2: un risultato risicato (i contrari hanno raccolto «solo» il 51.6% dei voti) ma significativo, considerato l’ampio schieramento che sosteneva la riforma (composto da PSS, Verdi, PLR, PPD, Economiesuisse e altri attori di peso). Le ragioni che hanno spinto il Partito Comunista a schierarsi in favore del NO sono note e sono già state riportate anche su queste pagine. A mente fredda, è però ora sicuramente utile chinarsi su questo risultato per comprenderne le ragioni, ma soprattutto per riflettere su come affrontare la questione ambientale alla luce del rifiuto popolare di questa legge, lungamente venduta come l’unica soluzione possibile al problema climatico.
Una legge respinta dalle campagne e dai ceti medio-bassi
È apparso chiaro fin da subito come uno dei principali fattori della bocciatura della Legge sul CO2 sia stata la ferma opposizione delle campagne: secondo l’Ufficio federale di statistica, solo il 36% dell’elettorato rurale l’ha sostenuta alle urne (contro il 65% dell’elettorato urbano). Un dato recentemente collegato alla forte mobilitazione contro le due iniziative anti-pesticidi. Ma a guardare più da vicino i risultati secondo il luogo di residenza, appare chiaro come a risultare determinanti siano state le periferie, dove la legge non è riuscita a raccogliere una maggioranza (i SÌ vi hanno raggiunto solo il 45% circa).
Un’osservazione che conferma il secondo elemento esplicativo emerso in seguito al voto: l’opposizione alla legge da parte dei ceti medio-bassi (che popolano le periferie e le cinture urbane). Secondo l’indagine realizzata lo stesso 13 giugno dal gruppo Tamedia, solo il 39% dei votanti con un salario compreso fra 3000 e 5000 franchi ha votato sì alla legge (contro il 58% dei cittadini con un reddito superiore a 11’000 franchi). Un’opposizione popolare che trova il suo fondamento nel timore di un importante aggravio finanziario per le famiglie in caso di accettazione della riforma: secondo il sondaggio recentemente realizzato dall’istituto GFS, è stato infatti il potenziale impatto sul portafogli a far pendere l’ago della bilancia verso il NO.
Quali soluzioni? No alle eco-tasse, sì alle nazionalizzazioni!
Questi elementi confermano l’analisi che il Partito Comunista aveva formulato nel motivare la sua opposizione alla revisione della legge, considerata un fardello eccessivo (e controproducente) per le classi popolari e per le regioni periferiche. Un’analisi che purtroppo anche parte della sinistra «alternativa» (anche in Ticino) aveva tentennato a fare sua, rimanendo «a metà del guado» e rinunciando dunque ad indicare un’alternativa al compromesso liberale sancito a Berna dal fronte rosso-verde. Quel fronte che ora tenta di correre (almeno parzialmente) ai ripari, affrettandosi a segnalare – come fa il PSS – che questo rifiuto va inteso come «un segnale che i grandi inquinatori devono venir ritenuti più responsabili». Un approccio comunque più responsabile di quello adottato dai Verdi, che parlano catastroficamente di «crisi della democrazia» e non fanno che distanziarsi ulteriormente dalle classi popolari.
Responsabilità (benché tardiva) che emerge anche dalle proposte avanzate dalla socialdemocrazia all’indomani del voto: oltre ad un’iniziativa popolare per penalizzare gli investimenti fossili della piazza finanziaria (responsabile di un quantitativo di emissioni pari ad oltre 20 volte quello prodotto a livello domestico), il capogruppo del PSS Roger Nordmann ha infatti annunciato che occorre anche «un massiccio programma d’investimento nella svolta energetica, segnatamente nei settori delle infrastrutture pubbliche, dei trasporti pubblici e delle energie rinnovabili».
Si tratta precisamente di quanto da noi auspicato, ma non basta. Occorre mettere ora sul tavolo il vero nodo del problema ambientale: l’assetto capitalistico della nostra economia, che impedisce strutturalmente una transizione ecologica rapida, ma anche equa e socialmente accettabile. Per fare fronte in modo efficace alla questione climatica, è più che mai necessario prevedere un deciso intervento dello Stato sui diversi fronti interessati: vanno abbandonate immediatamente le politiche privatistiche degli ultimi decenni (che continuano a dettare la linea in vari ambiti, come quello energetico, per cui è prevista una politica di liberalizzazione assolutamente controproducente) e vanno invece (ri)costituiti dei monopoli pubblici che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi sulla base di una accurata pianificazione pubblica. Il settore energetico, quello dei trasporti e delle comunicazioni, quello bancario ma in prospettiva anche quello industriale devono veder tornare lo Stato a dettare ritmi e prospettive di sviluppo, non più solo con sussidi ed incentivi, ma con un intervento diretto attraverso l’azione di grandi compagnie pubbliche da (ri)costituire ed ampliare al più presto (per maggiori dettagli in merito, si rinvia alla risoluzione approvata dal Comitato Centrale del PC lo scorso 7 agosto).
Solo un’adeguata politica di nazionalizzazioni potrà infatti assicurare la definizione di obiettivi razionali e confacenti alle necessità attuali, garantendo al contempo lo sviluppo delle regioni periferiche (e dunque la stessa coesione del paese), così come la crescita dell’occupazione in settori qualificati e caratterizzati da condizioni di lavoro dignitose.
Riorientare il conflitto sociale: l’esempio della sovranità alimentare
Potrà sembrare un programma di difficile applicazione, ma esso costituisce a nostro avviso l’unica via per orientare in modo progressivo il conflitto sociale attualmente stravolto nella sua natura di classe. Invece di alimentare il conflitto città-campagna o quello diplomati-ignoranti come amano fare taluni saccenti commentatori nostrani, la sinistra di classe deve tornare a riferirsi, a rappresentare e a riunire quelle parti di società che vengono quotidianamente colpite dal grande capitale e dalle sue mire globaliste. La sovranità alimentare promossa dal Partito Comunista (e approvata nell’indifferenza generale proprio quel fatidico 13 giugno) è esemplare in questo senso: avvicinando contadini e consumatori, coalizzandoli contro l’industria agro-alimentare e la grande distribuzione invece di contrapporli gli uni agli altri (come facevano le iniziative anti-pesticidi), questo principio costituzionale è riuscito a riscuotere un largo consenso (con il 62% di sì) che può essere ora capitalizzato per proposte concrete e sempre più avanzate.
È dunque forse ora di capire che la forza sociale per ottenere dei cambiamenti progressivi (in materia ambientale, ma non solo) non si trova nelle riflessioni esistenziali sull’identità sociale della sinistra o in posizioni equilibriste: la sintesi va invece ricercata nelle lotte sociali, nelle proposte concrete capaci di unire la popolazione e gli strati sfruttati della società invece di alimentarne le divisioni strumentali e funzionali al gioco del capitale.
Zeno Casella,
membro della Direzione del Partito Comunista