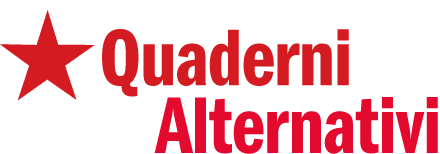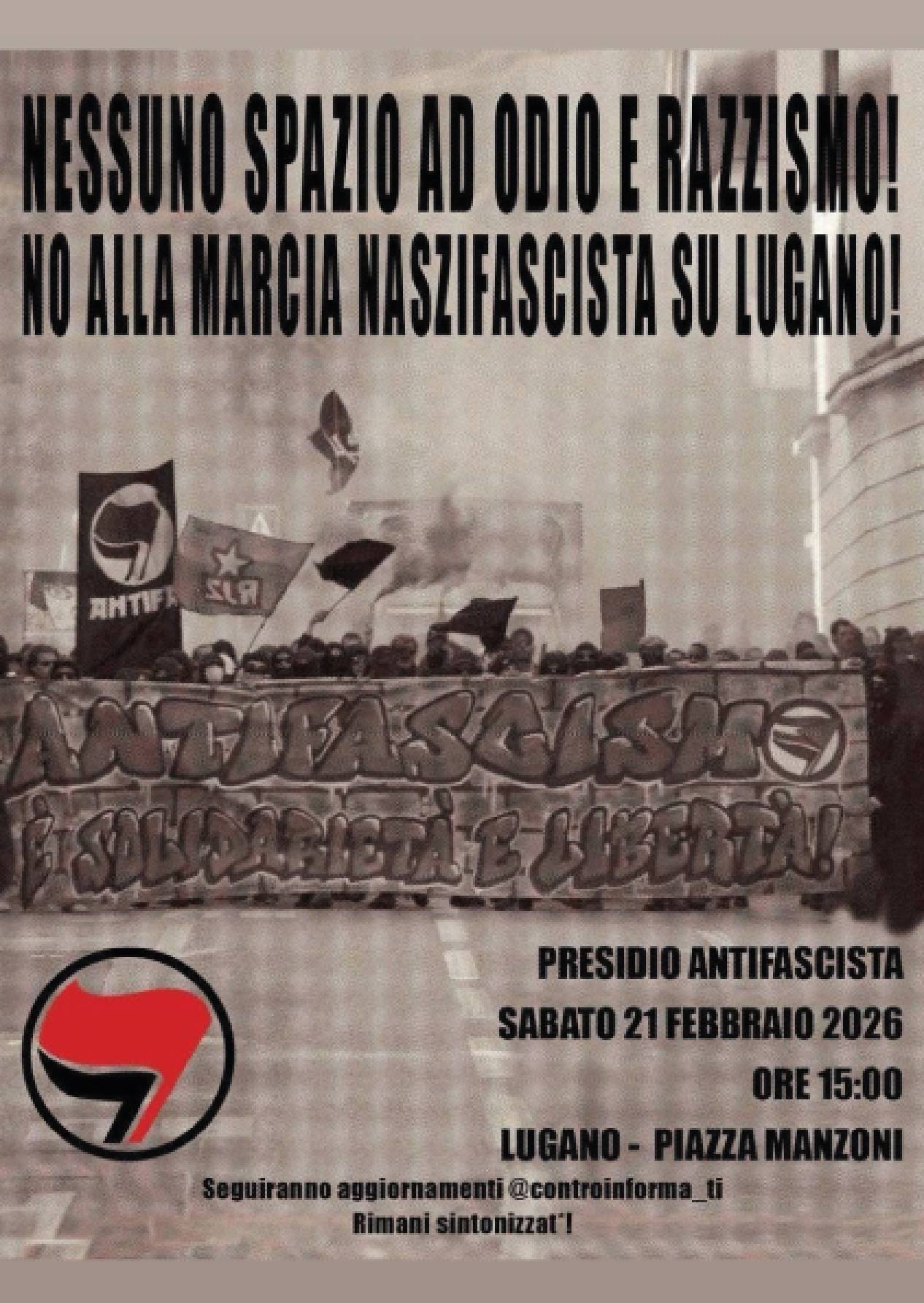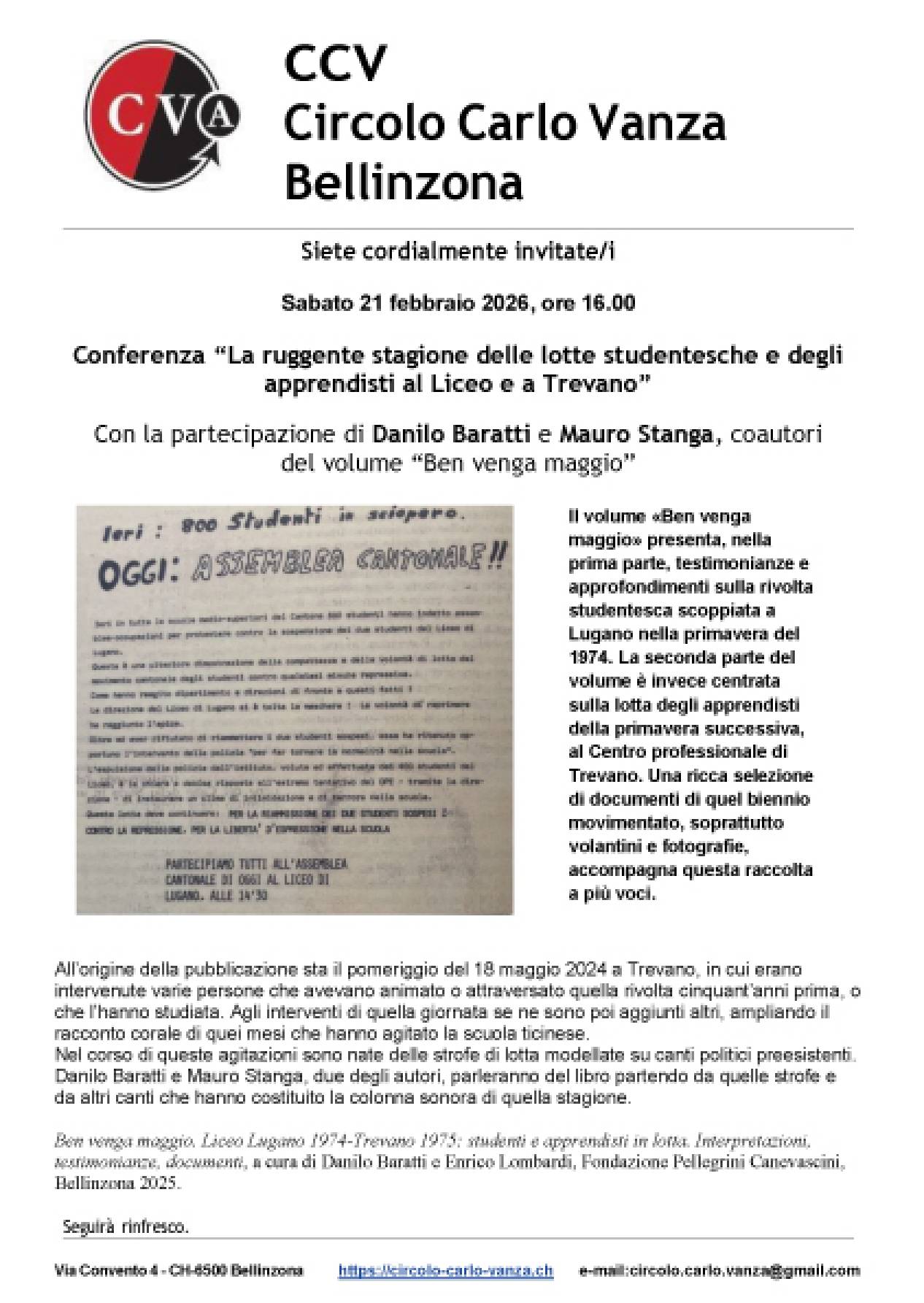Di fronte alla crisi del Venezuela, il subcontinente latinoamericano appare diviso in tre fazioni: un gruppo delle destre, alla quale si è associato il presidente cileno Gabriel Boric, che accusa apertamente il presidente venezuelano di aver rubato le elezioni presidenziali del 28 luglio; un gruppo guidato dai tre “giganti”, Brasile, Messico e Colombia, che esigono la pubblicazione degli atti, «disaggregati e verificabili» delle presidenziali prima di riconoscere un vincitore, e una minoranza, guidata da Cuba e dal Nicaragua, che riconosce il risultato “ufficiale” e considera Maduro come presidente rieletto per altri sei anni.
Come era da prevedere – per come si è arrivati alle urne e per come si sono svolte – le presidenziali venezuelane sono diventate un tema di politica latinoamericana: dal loro risultato dipendono non solo il futuro del Venezuela, ma anche i rapporti di forza politici dell’intero subcontinente. Per questa ragione, fin dalla vigilia delle elezioni, sia l’opposizione venezuelana, riunita nella Plataforma unitaria democrática (Pud), sia i loro sponsor internazionali – tra i quali i maggiori mass media internazionali – avevano assicurato che solo con una gigantesca frode elettorale il presidente Nicolás Maduro – candidato del “chavismo”, un fronte di forze attorno al Partido socialista unido de Venezuela, Psuv – avrebbe potuto vincere. Da parte loro, i dirigenti del Pud avevano dichiarato che in caso di vittoria di Maduro non avrebbero riconosciuto come valide le elezioni.
Una “profezia” si è (auto) verificata quando il Cosiglio nazionale elettorale (CNE) dopo aver raccolto il 90% dei voti ha dichiarato vincitore Maduro con il 51,95% di fronte al 43,18% del candidato dell’opposizione, Edmundo González. L’opposizione ha risposto di essere in possesso dell’80% dei voti espressi in più di 24.000 seggi (su un totale di poco più di 30.000 seggi) che dimostrano come González sia il «vero vincitore» con più del 70% dei voti espressi. Gli “atti” pubblicati in rete dall’organizzazione Sumate (che fa parte del Pud) si riferiscono però alle copie del voto, che non hanno valore perché possono essere falsificate. Come hanno accusato alcuni esperti che le hanno verificate (la piattaforma Cubadebate ha pubblicato una serie di prove delle falsificazioni di tali atti).
Per Stati Uniti, gran parte dei paesi dell’Ue e per la destra latinoamericana però non vi sono dubbi: i dati forniti dall’opposizione sono «credibili» e consacrano González come il nuovo presidente del Venezuela. E Maduro e il “regime chavista” sono autori di un vero e proprio golpe elettorale per mantenersi al potere, con l’appoggio dei militari e delle forze di sicurezza riunite sotto il comando del ministro della Difesa, Vladimir Padrino.
La questione del controllo delle elezioni è un assunto di politica interna, ovvero di «sovranità nazionale» di fronte alle pesanti ingerenze esterne, soprattutto degli Usa, per cambiare il governo bolivariano. E «senza sovranità nazionale, non vi è una vera sovranità popolare». È questa la tesi del vertice bolivariano che si è rivolto al Tribunale superiore di giustizia (Tsj) come unica autorità – nazionale, appunto – che può verificare la correttezza delle elezioni. Per l’opposizione, il Tsj è «affiliato» e dipende dal potere chavista e dunque l’unica verità è quella rappresentata dalla «volontà popolare» espressa dagli atti dei voti in loro possesso.
Vi sono dunque le condizioni per uno sviluppo violento della crisi venezuelana che può portare anche a una guerra civile. La dura repressione delle prime manifestazioni dell’opposizione – con una ventina di morti e centinania di arresti – indica chiaramente che i margini di composizione politica della crisi sono assai ristretti. Per la prima volta in più di venti anni di governo bolivariano l’opposizione appare coesa attorno alla leadership di ultradestra di Corina Machado, mentre il vertice “chavista” appare diviso in frazioni che con sempre maggior difficoltà Maduro riesce a mediare, soprattutto mediante l’alleanza con i vertici militari. Il fatto che l’opposizione possa vantare la pubblicazione dell’80% degli atti elettorali dimostra che una parte della base chavista ha collaborato con loro, inviando un segnale di sfiducia a Maduro.
L’incubo del presidente brasiliano Lula è che uno sbocco violento della crisi venezuelana porti a un intervento esterno (con mercenari o diretto) per abbattere il governo bolivariano. Uno scenario che avrebbe «conseguenze drammatiche» per tutto il subcontinente latinoamericano, secondo il presidente colombiano Gustavo Petro. Da qui l’impegno dei due presidenti, per favorire una soluzione politica in Venezuela. La questione centrale però non è la pubblicazione degli atti elettorali – che sono noti e depositati presso il Tsj – ma riuscire a trovare un accordo politico tra vertice bolivariano e opposizione per un governo – come afferma Petro – di unità nazionale. O per ripetere le elezioni. Il presidente (fino al 1° ottobre) messicano López Obrador però non ha condiviso questa linea, affermando che bisogna lasciar tempo al Tsj venezuelano di valutare l’esito del voto.
La costituzione di un governo di unità nazionale o la ripetizione delle elezioni presidenziali – le due ipotesi avanzate da Lula e Petro – sono osteggiata sia da Maduro che da Corina Machado, che sempre più punta sul sostegno internazionale. La volontà della leader dell’opposizione di andare a uno scontro violento con il governo però non sembra, per ora, avere successo: la manifestazione di sabato 17 agosto indetta dal Pud in Venezuela – e in più di 300 citta nel mondo – ha avuto uno scarso esito a Caracas. Di conseguenza Machado punta sempre più su forti pressioni dall’esterno – soprattutto su Lula e Petro – per isolare completamente il governo di Maduro.
Si tratta comunque di un nodo gordiano politico che allunga un’ombra di violenza capace di investire tutto il subcontiente. Per questa ragione la crisi venezuelana è diventata anche - e soprattutto - una questione di politica interna dei paesi latinoamericani. La destra si è schierata – con il sostegno degli Usa – e chiede ai governi progressisti di esprimersi sugli esiti delle presidenziali venezuelane come prova o meno delle loro garanzie democratiche. Schierarsi con Maduro, insomma, significa appoggiare una «dittatura». Rivendicare la presidenza a González sarebbe invece una garanzia di rispetto della democrazia e dei diritti umani.
È un tema che divide il progressismo latinoamericano, come dimostra la scelta netta espressa dal presidente cileno, Boric. Ed è il tema centrale di un dibattito – democrazia formale o controllo nazionale e sovrano dei beni nazionali – il cui sviluppo vedremo nei prossimi mesi.
Chi rischia di essere stritolata in questa tenaglia è Cuba. Se cade il governo Maduro, è probabile che il prossimo attacco a fondo sarà contro il governo socialista cubano, che appare oggi in difficoltà come mai in precedenza. Gli sviluppi della crisi venezuelana avranno una eco nella campagna presidenziale negli Stati uniti. E naturalmente gli esiti di quest’ultima influiranno negli equilibri del subcontinente latinoamericano, dove il Pentagono ha già pronti piani di intervento.