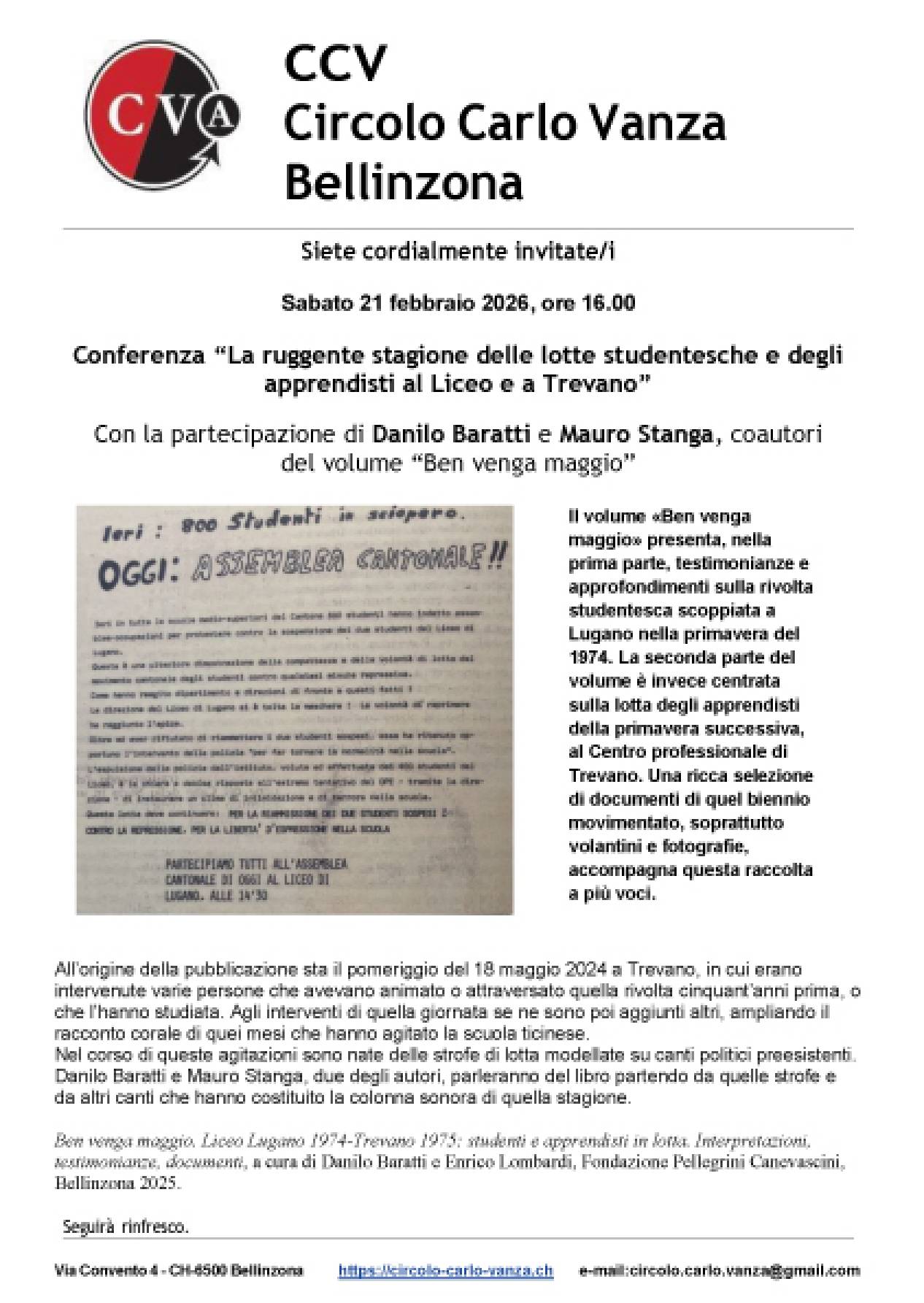Un catastrofico dibattito, uno scampato assassinio, il passo indietro del presidente e l’acclamazione della sua sostituta… in un paio di fatidiche settimane di luglio, si sono susseguiti frenetici i passaggi che hanno stravolto le presidenziali americane, rendendo ancora più singolari queste elezioni di storica portata.
Dopo aver tentato di sovvertire l’ordine democratico, rifiutando il verdetto delle urne e lanciando i propri sostenitori all’assalto del Parlamento nel 2020, Donald Trump, anziché languire in prigione, si ripresenta candidato alla presidenza del paese, un fatto che di per sé, indica il labile stato di salute della maggiore democrazia occidentale.
Il ritorno del presidente golpista, la cui figura ha continuato ad aleggiare sulla nazione, riporta il paese davanti al populismo demagogico ed autoritario che non ha saputo elaborare politicamente, né giuridicamente.
L’antipolitica trumpiana strumentalizza la retorica identitaria e sovranista, imperniata su rancore e xenofobia, che è cifra comune delle nuove destre globali. Esprime inoltre un capitalismo dinastico che considera la governance alla stregua di quelle speculazioni aziendali su cui il palazzinaro e bancarottiere ha costruito il proprio impero. Promette di allineare gli Stati uniti con lo stile e l’amoralità di leader come Netanyahu, Mohammed Bin Salman e Vladimir Putin, uomini che Trump stima ed ammira.
Dietro il suo opportunismo si muovono tuttavia pulsioni più antiche e profonde, da sempre presenti nella parabola nazionale. Sin dalla fondazione, l’esperimento democratico americano, caratterizzato da una congenita affinità all’illuminismo francese, ha avuto antitetiche componenti nel fondamentalismo avventista e nel fanatismo puritano delle sette religiose dei primi coloni.
Assieme agli interessi del capitale (ed ai peccati originari di genocidio e schiavismo) quella tradizione ha espresso aneliti reazionari che hanno prodotto una guerra civile, un secolo di apartheid razzista, abissali disuguaglianze, violenza diffusa e segregazione. La storia del progresso americano è stata quella del difficile superamento delle vocazioni autoritarie e reazionarie per muovere la nazione verso la “più perfetta unione” indicata da Lincoln e perseguita da Franklin Roosevelt.
Nell’ultimo mezzo secolo quel progresso è stato misurato dal movimento dei diritti civili, ad esempio di donne ed afroamericani, ed un’evoluzione “culturale che ha portato al superamento, per esempio, dell’anticomuniste viscerale e liberticida del maccartismo, verso una società più inclusiva.
L’America più retrograda e violenta, che, con tutto il suo bagaglio di intransigenze e dogma religioso (l’ossessione con la famiglia tradizionale, ad esempio, o coi ruoli di genere) ha ora trovato espressione nel trumpismo, mira ad azzerare l’ultimo mezzo secolo di progresso e riportare il paese ad una “grandezza antica” che è codice per una restaurazione dell’ordine simbolico di privilegio bianco, quella che Kevin Roberts, direttore della Heritage Foundation, ha chiamato la “seconda rivoluzione americana” (“che rimarrà senza spargimento di sangue a meno che la sinistra non lo voglia.”)
Non a caso lo slogan che è echeggiato alla convention democratica di Chicago è stato “we won’t go back!” (“non torneremo indietro”.) Nell’era della identity politics, una dichiarazione di intenti ed una contrapposizione chiara fra una vecchia concezione di America dottrinaria ed autoritaria e quella dinamica e multietnica delle nuove generazioni che Kamala Harris, donna di colore, assurta al successo come procuratrice, senatrice ed infine vicepresidente, così iconograficamente incarna.
Il modello trumpista, intanto, è qualcosa di più che semplice ipotesi. Si intravede nei “red states,” gli stati ad amministrazione repubblicana dove i confini vengono sigillati, i libri di scuola “diseducativi” vengono spediti al macero e le donne sono costrette ad espatriare per abortire. È una realtà concreta, cioè, un paese dove i figli (e le figlie) hanno già meno libertà dei nonni che le avevano duramente conquistate.
La minaccia di un movimento che ha già una volta assaltato il Congresso è implicita, ma una seconda amministrazione Trump promette di essere assai più draconiana della prima. Anche qui, non si tratta di semplici supposizioni. Il programma è contenuto in Project 2025, un documento programmatico stilato da un consorzio di strateghi conservatori, per appropriarsi più speditamente delle leve del potere. Si tratta di un prontuario per il consolidamento di una presidenza imperiale caldeggiato dai think tank estremisti che producono l’ideologia Maga.
Fra i passi specificamente citati: indulto per (gli 800 circa) condannati per l’insurrezione del 6 gennaio, abrogazione del ministero dell’istruzione, mobilitazione della guardia nazionale in stati “inadempienti”, deportazione di massa degli (11 milioni) di immigrati non autorizzati. Con l’eufemismo di “decostruzione dello stato amministrativo,” si propone infine la sostituzione del personale statale con un organico personalmente fedele al presidente.
È sempre più chiaro, dunque, che novembre rischia di essere uno spartiacque. Sul New York Times, Masha Gessen ha citato a questo riguardo il sociologo ungherese Balint Magura e la sua teoria sugli “autocratica breakthroughs,” cioè i punti di svolta nei quali i regimi democratici imboccano la via dell’autoritarismo. Vale la pena ricordare quanto spesso questo avvenga inizialmente con una presa di potere elettorale. Sembra di certo saperlo Donald Trump che a giugno ha detto ad un gruppo di elettori evangelici: “Vi chiedo un ultimo sforzo, dopodiché non sarà più necessario votare…”
Oggi il partito è interamente sotto il controllo della Trump Family che di fatto lo dirige dalla reggia di Mar A Lago. Il dato è misurabile nella carica di tesoriera del RNC (republican national committee) affidata alla nuora, Lara Trump, che ha trasformato il partito in banca di famiglia. Ma anche nella visibilità dei figli Eric e Don Jr. sui circuiti dei talk e dei convegni, nei social e nella campagna. Degli affari globali del genero Jared Kushner (marito di Ivanka Trump), finanziati dagli “amici” sauditi abbiamo già avuto modo di scrivere su queste pagine.
“Possiamo tutti immaginare un Donald Trump senza residue sponde,” ha detto Kamala Harris alla convention di Chicago e di fatto ogni futura costrizione costituzionale è stata preventivamente rimossa con l’immunità presidenziale decretata dalla Corte Suprema la cui super maggioranza conservatrice è stata assicurata dalle nomine dello stesso Trump.
Il sistema di pesi e contrappesi – il bilanciamento di poteri istituzionali – è in pratica già pregiudicato. E la Corte suprema plasmata da Trump potrebbe avere un ruolo decisivo in queste elezioni, se dovesse venire chiamata (come avvenne nel 2000) per dirimere contenziosi sul voto. A questo proposito i repubblicani hanno già preannunciato una replica delle tattiche destabilizzanti di quattro anni fa.
Tutto questo c’è in gioco nelle prossime presidenziali che rischiano – ancora una volta – di essere “le più importanti di sempre.”
Che il narcisismo incoerente di Donald Trump sia ancora in grado di sedurre metà dell’elettorato americano, deve considerarsi una misura non di mera insoddisfazione politica ma di squilibrio psichico di una società che sembra aver esaurito una forza propulsiva coerente. Senza scontare, anche in questo caso, i grandi interessi economici che si agitano nelle retrovie.
Già qualche mese fa avevamo anticipato su queste pagine l’emergere di fazioni reazionarie in seno al polo industriale delle nuove tecnologie. Da allora la destra di Silicon Valley è uscita allo scoperto con l’esplicito sostegno a Trump di Elon Musk, prototipo di neo capitalista ultraliberista con a disposizione una intera piattaforma per amplificare la complottistica che segna la crisi “epistemica” del nostro tempo. Musk ed altri come Peter Thiel, sponsor di politici di estrema destra (compreso JD Vance, candidato a vice di Trump), rappresentano una nuova pericolosa generazione di oligarchi dalle idee suprematiste, socialmente “darwiniste” e fanaticamente meritocratiche, nonché disposti a tutto per proteggere il monopolio che ha prodotto le loro favolose fortune. (Non è casuale che lo slittamento a destra di Silicon Valley coincida con le prime azioni antitrust intentate dal governo Biden contro giganti del settore, comprese Google ed Amazon).
Di fronte a questo schieramento, fino a poche settimane fa, le forze democratiche sembravano inesorabilmente soverchiate e soprattutto demotivate dal loro anziano candidato. Da allora, la sostituzione di Joe Biden con Kamala Harris ha prodotto uno stato di euforia e motivazione non viste dai primi anni Obama e reso plausibile una vittoria della prima presidente donna della storia.
La convention di Chicago è stata l’espressione sapientemente coreografata del nuovo ottimismo democratico e della narrazione di inclusione su cui per ora si fonda, un grande spettacolo che ha cristallizzato l’entusiasmo ritrovato, al di là di ogni specifico programma politico, e proiettato un’immagine “presidenziale” della Harris.
Fra i maggiorenti del partito intervenuti, nessuno meglio degli Obama (e dei due soprattutto Michelle) ha saputo sintetizzare la contrapposizione fra le due Americhe, fondamentalmente incompatibili, che si affronteranno a novembre.
Ne è stato casuale affidare a loro questa narrazione, dato che, con un elettorato spaccato a metà, l’esito finale dipenderà dalla motivazione e dall’affluenza soprattutto di giovani, di minoranze e di donne, in altre parole dalla capacità della squadra di Kamala Harris di ricomporre gli elementi di quelle “Obama coalitions” su sui sono stati predicati tutti i recenti successi democratici.
I sondaggi dicono che la maggioranza del voto popolare è decisamente a portata della Harris. Ma nel complicato sistema intermediato americano, è il collegio elettorale ad esprimere il vincitore. Ed in questo sistema arcano, assicurandosi una manciata di stati chiave, Trump potrebbe nuovamente vincere pur ottenendo la minoranza dei voti totali.
Per evitare la sorte che otto anni fa toccò ad Hillary Clinton, la campagna di Kamala Harris dovrà dunque essere impeccabile soprattutto in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina Georgia, Nevada ed Arizona, dove poche decine di migliaia di preferenze promettono di decidere il futuro dell’esperimento americano.