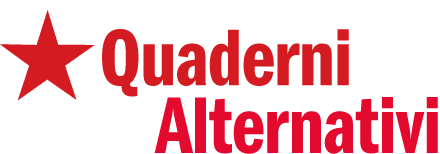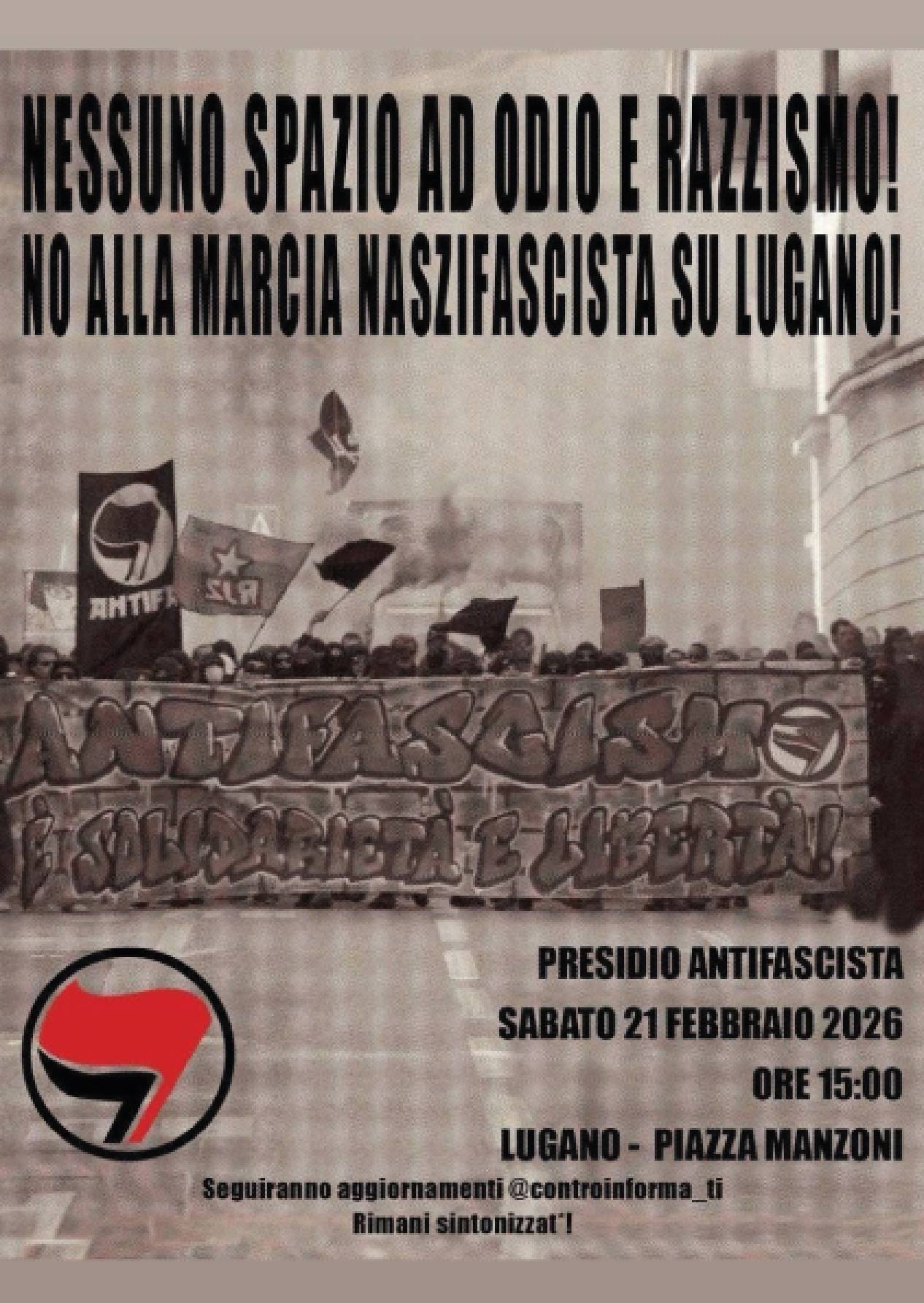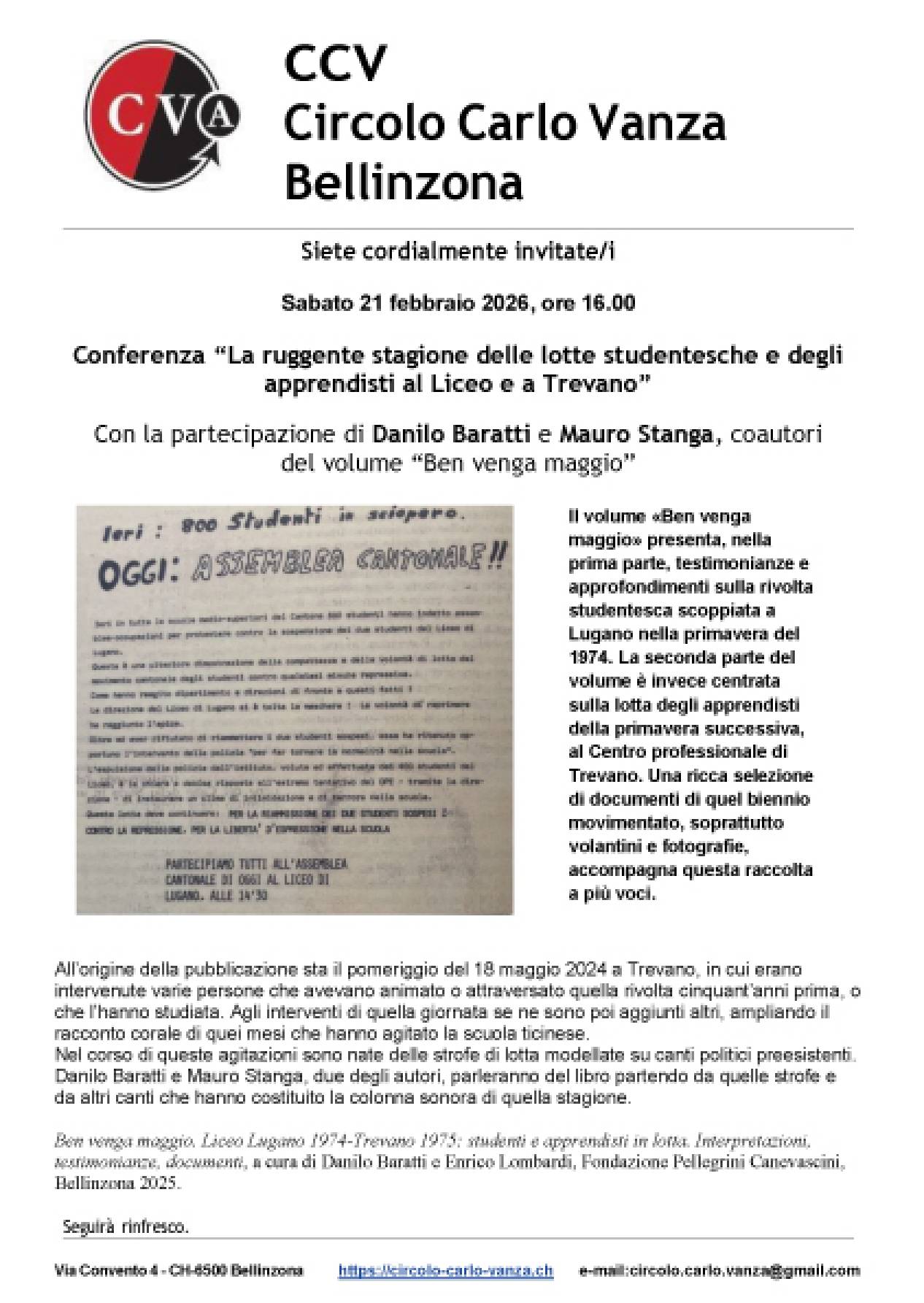Un anno fa, a seguito di una mia visita lampo di 36 ore a Shanghai, avevo scritto in questi Quaderni (Trenta ore a Shanghai Q45, 2023) un articolo sull’atmosfera cupa e di chiusura verso l’esterno che avevo trovato in questa metropoli, che aveva particolarmente sofferto i quasi due anni di chiusura totale a seguito del Covid.
Questo ambiente mi aveva parecchio impressionato anche perché normalmente Shanghai è di gran lunga la più vivace delle metropoli cinesi. Sono tornato nel maggio scorso per un viaggio di due settimane che mi ha portato in sette delle metropoli cinesi, visitando una decina dei principali centri oncologici e di ricerca. Sono stato naturalmente a Pechino e a Shanghai, ma ho fatto migliaia di chilometri, soprattutto con i treni superveloci, attraversando la Cina da Nord, Harbin, capitale della Manciuria, sino a Sud-Ovest, soprattutto a Chongqing, da noi quasi sconosciuta, ma che con i suoi 34 milioni di abitanti è probabilmente la città più popolosa del mondo.
Una prima impressione: mentre durante i miei viaggi prima dell’epidemia vedevo dappertutto grattacieli sorgere come funghi, ora, a seguito della nota crisi dei conglomerati edilizi, di costruzioni se ne vedono ben poche. Al massimo nelle città si migliorano le strade o si scavano nuove linee di metrò.

 Il cielo blu sopra Shanghai
Il cielo blu sopra Shanghai
In generale però prevalgono le impressioni positive. Solo un anno fa, ottenere un visto richiedeva lunghe e noiose pratiche burocratiche, ora, anche per rilanciare il turismo, per tutta una serie di paesi occidentali (tra cui la Svizzera) se il soggiorno non supera le due settimane, non c’è più bisogno di alcun visto. Anche in questi aspetti, che potrebbero sembrare secondari, i cinesi dimostrano il loro ben noto pragmatismo. Appena un problema viene messo a fuoco, si cerca una soluzione. Durante il viaggio, ho avuto diversi giorni di bel tempo, sempre salutati da uno splendido cielo blu. E sì che da noi prevale invece tuttora l’opinione che l’inquinamento atmosferico in Cina sia terribile. Appena arrivato a Pechino, sono stato ospite a cena, con alcuni oncologi cinesi, dell’Ambasciatore svizzero Burri, che 25 anni fa era stato nella stessa ambasciata come segretario. Lui stesso mi ha confermato che un quarto di secolo dopo la situazione ambientale è grandemente migliorata, anche grazie agli enormi investimenti che il Governo cinese ha fatto e sta facendo. Attraversando la Cina in treno si vedono difatti distese chilometriche di fotovoltaici, tutte le motociclette sono elettriche, nelle metropoli circa due terzi delle automobili (riconoscibili dal colore della loro targa) sono a trazione elettrica. A questo proposito Lorenzo Lamperti, corrispondente del Manifesto da Taipei (Taiwan), riferisce (14 luglio 2024) gli ultimi dati pubblicati dal report del Global Energy Monitor: la Cina avrebbe in costruzione circa 340 GW di energia eolica e solare, gli Stati Uniti invece solo 40. I dati si riferiscono però solo ai parchi solari con la capacità di almeno 20 MW, non comprendono parchi solari su piccola scala che rappresentano il 40% della capacità solare cinese. La Cina dovrebbe raggiungere i 1200 GW di capacità eolica e solare entro la fine del 2024, sei anni prima dell’obiettivo che era stato fissato per il 2030.
 Ottimismo e frenesia
Ottimismo e frenesia
L’atmosfera cupa di un anno fa è come scomparsa, quasi dappertutto ho ritrovato una buona dose di ottimismo. Soprattutto tra i ricercatori mi ha sorpreso quasi una certa frenesia nel voler recuperare i due anni persi con la paralisi creata dal Covid. E lo Stato sta investendo sempre più massicciamente sia nel settore sanitario che soprattutto nella ricerca. Per quanto riguarda gli ospedali, in questi quasi 25 anni durante i quali (salvo il periodo Covid) mi sono recato quasi annualmente in Cina, ho visto un cambiamento enorme. Dopo l’ondata brutale di privatizzazioni avvenute anche in questo settore dopo il lancio nel 1978 delle riforme economiche di Deng Xiaoping, nel nuovo millennio a poco a poco i vari stabilimenti sono stati viepiù rinazionalizzati, ma soprattutto la copertura delle spese dei trattamenti anche più costosi viene sempre più assunta dal welfare statale. L’investimento in tutti i settori della ricerca, a partire dall’intelligenza artificiale e dalla biotecnologia, è impressionante. Mentre nel passato però ad approfittarne erano state soprattutto le zone costiere (Tianjin, Shanghai, Fuzhou, Shenzhen), ora mi è parso di capire che si stia investendo massicciamente soprattutto nella zona montagnosa limitata da Chongqing e Chengdu (zona che tra poco conterà 200 milioni di abitanti). Sottovoce mi è stato detto (e mi pare molto comprensibile) che se ci fosse una nuova guerra mondiale, questa parte della Cina sarebbe più facilmente difendibile che non le zone costiere. Per cui si sta investendo soprattutto lì.

 Putin, amico fin dove?
Putin, amico fin dove?
Se c’è un rinnovato ottimismo, ho ritrovato però anche alcune grosse preoccupazioni per la situazione geopolitica. Arrivati a Harbin, siamo stati bloccati per una buona mezzora ad un chilometro del nostro albergo: stavano facendo le prove delle misure di sicurezza, per l’arrivo la settimana seguente di Putin. Ufficialmente l’amicizia russa-cinese viene sottolineata a ogni piè sospinto. Ma leggendo tra le righe nei quotidiani in inglese del PCC o almeno legati al Partito (Global Times, China Daily) si notano una serie di critiche di fronte all’inefficienza del sistema economico russo rispettivamente di “buoni consigli” di come il settore andrebbe ristrutturato. E secondo me, l’amicizia sempre più plateale di Putin con la Corea del Nord (che gode di pochissima simpatia nell’opinione pubblica cinese) sta irritando non poco il Governo di Pechino. Quasi tutti coloro con cui ho discusso di questi temi mi hanno espresso la loro preoccupazione sull’atteggiamento aggressivo di Washington nei confronti della Cina e come questo possa sfociare in un devastante conflitto armato. Mi è parso molto evidente anche che Pechino punti sempre di più a diventare il leader del Sud globale, come dimostrato anche dalla sua posizione sia sulla guerra ucraina che sul genocidio in corso a Gaza. Interessante a questo proposito mi è parsa una evidente rivalutazione del pensiero di Chou En-Lai, il mitico primo ministro cinese che durante un lungo periodo di tempo era stato uno dei personaggi fondamentali del Movimento dei paesi non allineati dopo la conferenza di Bandung del 1955, che aveva avuto quale visione principale quella di evitare una nuova guerra mondiale tra i due blocchi. Durante il viaggio avevo notato come in tutte le librerie degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie si ritrovassero, tradotte in inglese, diverse sue opere. E non poteva essere un caso. A conferma di ciò il giorno dopo il deprimente e a tratti delirante dibattito elettorale tra Biden e Trump, il presidente Xi Jinping ha rilanciato le visioni di geopolitica del Governo cinese, riprendendo quasi letteralmente i principi enunciati a suo tempo da Chou En-Lai. Difronte all’imbarbarimento della politica interna ed estera di Washington, Pechino sta giocando con notevole successo la carta della potenza mondiale ragionevole. C’è da sperare che sia una carta vincente.
PS: Questo articolo l’ho dettato di getto al mio rientro dal viaggio in Cina. Rileggendone le conclusioni a fine luglio, non posso esimermi dal sottolineare come quanto abbiamo visto succedere contemporaneamente in quei giorni di luglio a Pechino ed a Washington dimostri perfettamente in immagini quanto dicevo a parole nella mia conclusione. Negli stessi giorni difatti a Pechino il Ministro degli esteri cinese riceveva prima i rappresentanti di Al Fatah, di Hamas e di tutti i gruppi minoritari palestinesi per discutere del futuro dei Territori Occupati e di Gaza e in seguito incontrava poi a lungo con il Ministro degli esteri ucraino Kuleba per capire i margini di compromesso che ci possono essere per un processo di pace in Ucraina. Contemporaneamente al criminale di guerra Netanyahu il Congresso americano regalava più di cinquantina di standing ovations durante un intervento che definire delirante è ancora essere troppo gentile. Il tema centrale di questo delirio era nientepopodimeno che la lotta tra “la civiltà e la barbarie” (!). In proposito si veda la recensione del libro di Enzo Traverso “Gaza davanti alla storia”.
PS 2: A proposito di barbarie... In quelle stesse ore la 401ª brigata israeliana faceva saltare in aria una enorme cisterna d’acqua a Gaza, che forniva 3.000 metri cubi d’acqua al giorno agli sfollati di Rafah. I morti per sete a Gaza non si contano ormai più.