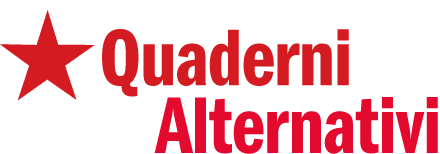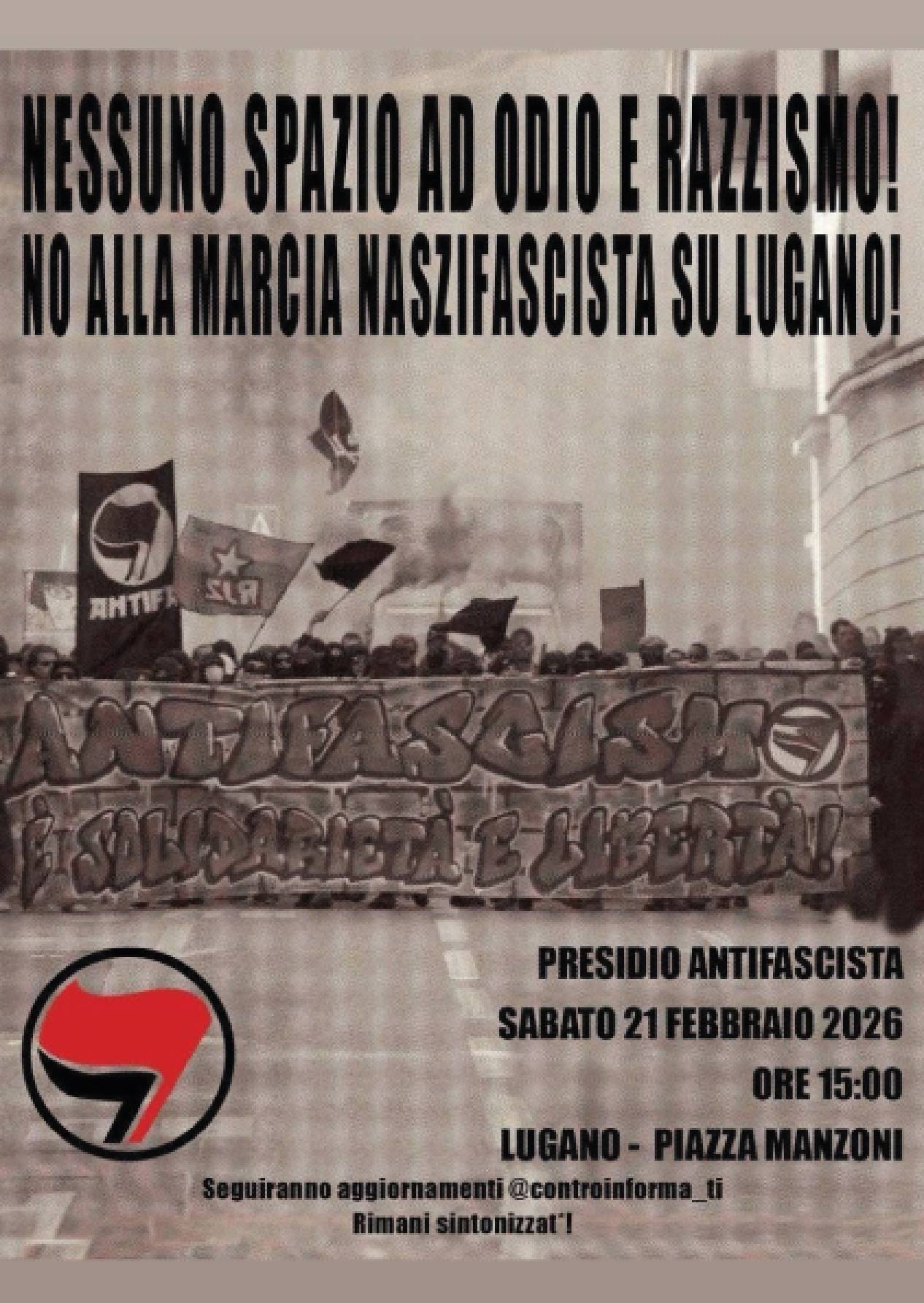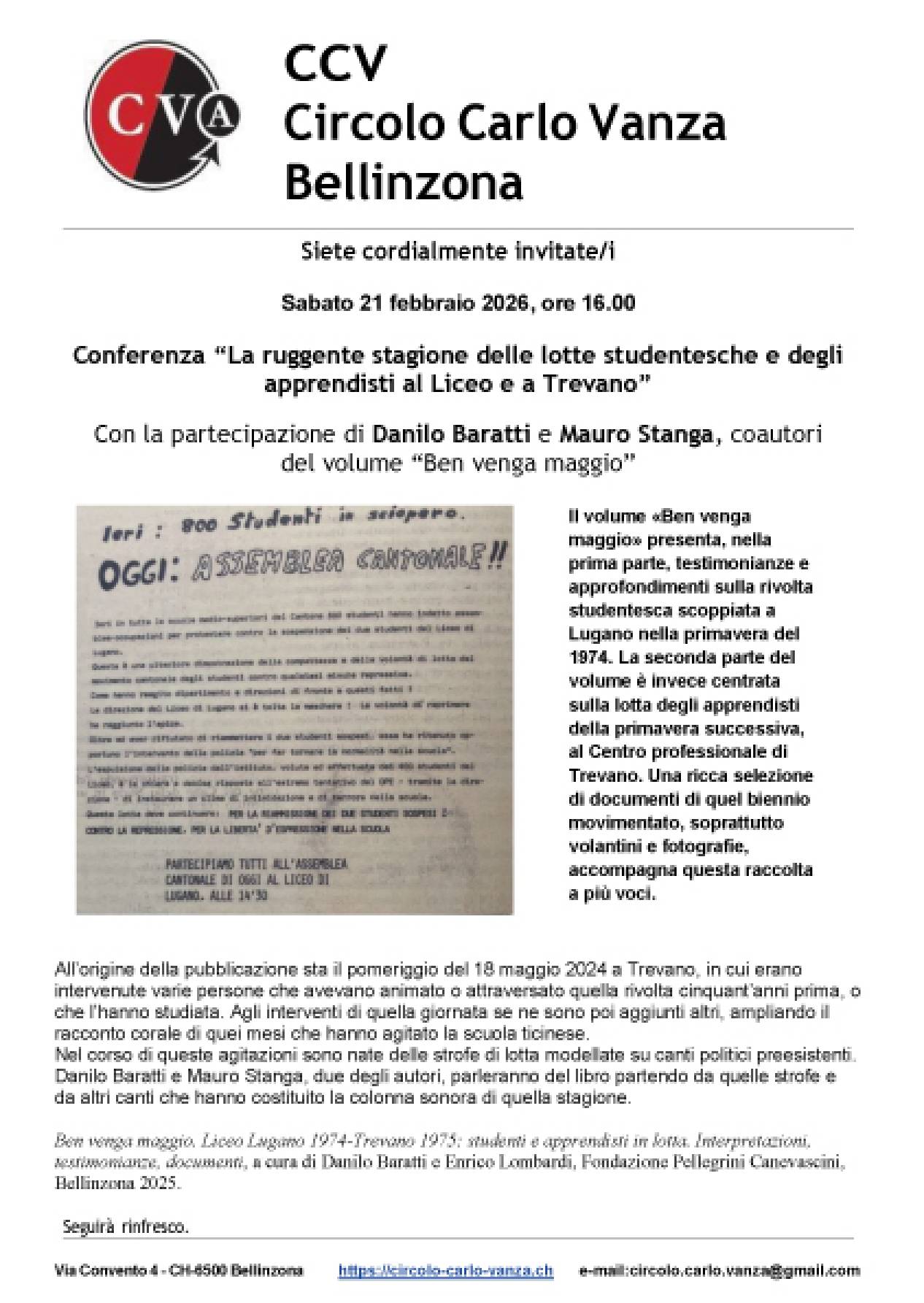L’arresto a Gerusalemme, giovedì 18 aprile, della professoressa palestinese Nadera Shalhoub-Kevorkian non è avvenuto in un vuoto. Tra le più note criminologhe e sociologhe palestinesi con cittadinanza israeliana, docente della Hebrew University, era stata già sospesa dall’ateneo per aver chiesto il cessate il fuoco a Gaza, fatto appello all’abolizione del sionismo e accusato le autorità di aver ingigantito i crimini di Hamas del 7 ottobre per giustificare a posteriori il massacro di Gaza.
Ora la docente è accusata di incitamento e rischia anni di galera. La fattispecie di reato, puntellata dopo l’inizio dell’offensiva israeliana “Spade di ferro”, negli ultimi mesi è stata il piede di porco con cui il governo israeliano ha scardinato una realtà di privilegio che si credeva inscalfibile: la repressione interna e il silenziamento delle voci critiche non sono più solo strumento contro i palestinesi. È una delle sorprese che si sono trovati di fronte artisti, attivisti e intellettuali ebrei israeliani: lo stato di polizia non è più a senso unico. Perché, prima di Shalhoub-Kevorkian, agli arresti era finito anche il professore Meir Baruchin: docente di storia alle superiori, era stato arrestato a novembre e detenuto in isolamento nel famigerato carcere gerusalemita del Moscobiyeh, il luogo in cui vengono trascinati i prigionieri palestinesi, qui sottoposti per giorni, a volte settimane, ai più brutali interrogatori.
Molti altri quelli che hanno perso il lavoro o sono stati sospesi per aver criticato le pratiche genocidiarie del governo e dell’esercito a Gaza. Decine anche i fermati durante le minute e fulminee manifestazioni di protesta per il cessate il fuoco. E tanti quelli minacciati di violenza, come il regista Yuval Abraham: dopo il premio ricevuto a Berlino con il palestinese Basel Adra e le parole spese per la questione palestinese, è stato accusato di antisemitismo (sic) e la sua famiglia è stata costretta a lasciare la propria casa per le minacce ricevute.
Le voci critiche sono una piccola minoranza, eppure va repressa. Dalle autorità e dal resto della società che di frequente si palesa alle piccole iniziative di protesta ad Haifa, Tel Aviv, Giaffa aggredendo i manifestanti, sputandogli addosso e minacciandoli di morte e di stupro. Dopotutto la polizia non si fa troppi problemi neppure ad aggredire le più consistenti marce dei familiari degli ostaggi e di decine di migliaia di israeliani che chiedono un accordo di scambio con Hamas, per far tornare a casa i 136 ostaggi ancora a Gaza (sarebbero almeno una trentina i morti in cattività), e che gridano al premier Netanyahu di dimettersi per palese incapacità e chiara responsabilità nel fallimento della sicurezza che è stato il 7 ottobre.
Manca un pezzo, però, un necessario pezzo nell’analisi che la società israeliana dà degli ultimi sei mesi: niente è iniziato il 7 ottobre e niente finirà con il prosieguo cieco dell’occupazione militare e dell’oppressione strutturale del popolo palestinese. Su quel fronte, però, non è cambiato nulla, se non in peggio. A oggi, nonostante le immagini in diretta di crimini di guerra e pratiche genocidiarie, secondo i più recenti sondaggi condotti da quotidiani israeliani oltre l’80 percento degli ebrei del paese ritiene l’offensiva militare l’unico strumento possibile per la capitolazione di Hamas.
Dopo mesi di evaporazione delle proteste che avevano accompagnato il 2023, milioni in piazza per fermare la riforma della giustizia, con il nuovo anno i sit-in sono ripresi e si sono gonfiati nei numeri e nella rabbia: a Tel Aviv, Gerusalemme, Cesarea. Ma, come ha spiegato bene su Al Jazeera lo scorso 20 aprile Mohamad Elmasry, docente al Doha Institute for Graduate Studies, la maggior parte dei manifestanti non è contro la guerra, la maggior parte dei manifestanti pensa, al contrario, che l’esercito israeliano non stia esercitando abbastanza forza a Gaza.
«Le critiche sono rivolte a Benyamin Netanyahu, più che al governo nel suo insieme. Il fatto che la guerra vada avanti da sei mesi suggerisce che le proteste non abbiano avuto un grande impatto sul primo ministro – continua Elmasry – Penso che Netanyahu stia politicamente vincendo con l’estensione della guerra. E quello che è successo negli Stati uniti oggi (il voto del Congresso che ha riconosciuto un mega pacchetto di aiuti militari da 26 miliardi di dollari a Tel Aviv, ndr) gli garantirà più munizioni, figurate e letterali».
E poi c’è chi la guerra la chiede senza remore né fraintendimenti. È la destra estrema, quella che negli ultimi decenni ha scalato le istituzioni, ponendo in posizioni di potere esponenti del movimento dei coloni e del kahanismo fascista e razzista. Assume forme diverse e si garantisce una diversa visibilità. C’è quella apertamente violenta che dentro Israele forma ronde armate di cittadini per la caccia all’arabo e che in Cisgiordania dà fuoco alle case palestinesi, aggredisce i contadini, sradica gli ulivi e che in pochi mesi ha costretto decine di piccole comunità a scappare dalle proprie terre perché la violenza è troppa e insopportabile. È la stessa che ai valichi tra Israele e Gaza ha bloccato per giorni, e continua a farlo, gli sparuti camion di aiuti umanitari in ingresso perché i palestinesi «vanno presi per fame, solo con la fame si arrenderanno».
E poi c’è quella apparentemente meno violenta nella pratica, ma feroce nelle dichiarazioni politiche. Quella che nelle piazze e alle urne parla di annessione, di colonizzazione e di pulizia etnica. «Le nostre idee sono diventate mainstream», ci diceva un signore sulla 60ina lo scorso febbraio durante una manifestazione in notturna di fronte alla Knesset. Lì, decine di migliaia di persone dopo una marcia di cinque giorni chiedevano a gran voce la cancellazione di Gaza. Lo facevano con naturalezza donne, ragazzini, famiglie, anziane coppie, laici e ultraortodossi mentre dal palco suonavano musica pop e a terra distribuivano zucchero filato e caramelle.
In mezzo a questa schiacciante maggioranza sta anche una significativa porzione di chi, fino al 6 ottobre, si diceva parte del blocco della sinistra sionista e del mondo, sempre più asfittico, del pacifismo israeliano. «Ci siamo svegliati – è l’espressione più utilizzata – Abbiamo capito che con i palestinesi non ci potrà mai essere pace né convivenza». We woke up, una giravolta semantica rispetto al significato che da anni descrive – al contrario – il “risveglio” politico di gruppi subalterni, di presa di coscienza delle reali condizioni di diseguaglianza nelle cosiddette democrazie liberali.
Lo ha spiegato bene, lo scorso 2 aprile su Foreign Policy, la giornalista e analista Mairav Zonszein: «Incolpare Netanyahu ha eclissato il fatto che, quando si discute di politiche israeliane a Gaza in particolare e sui palestinesi in generale, la maggior parte degli israeliani è ampiamente allineata con Netanyahu. Con un ampio margine, sostengono l’attuale campagna militare e l’obiettivo del governo di distruggere Hamas qualsiasi sia il prezzo umano per i palestinesi nella Striscia. Le migliaia di israeliani che di nuovo marciano nelle strade non stanno manifestando contro la guerra (…) Non stanno protestando per l’uccisione di un numero senza precedenti di palestinesi o per le restrizioni agli aiuti umanitari che hanno condotto alla carestia. E di certo non invocano la necessità di porre fine all’occupazione militare. Stanno protestando per il rifiuto di Netanyahu di dimettersi».
Ad alimentare negli animi la rabbia e la voglia di vendetta (questa la parola usata con inquietante frequenza da alti esponenti del governo Netanyahu) è la narrazione pressoché unica dell’offensiva militare che permea ogni spazio pubblico e mediatico: da sei mesi la stampa partecipa attivamente allo sforzo bellico, eliminando dal quadro le pratiche militari a Gaza (quelle che il 26 gennaio scorso la Corte internazionale di Giustizia ha definito «genocidio plausibile») e i loro disumani effetti sui civili palestinesi, ignorando i pogrom dei coloni in Cisgiordania, rimandando a ritmo continuo le immagini dell’attacco di Hamas del 7 ottobre che ha provocato 1.100 morti, amplificando la paura per un accerchiamento regionale e l’isolamento internazionale, garantendo spazio agli appelli alla pulizia etnica di Gaza candidamente espressi da ministri e vertici militari.
Anche questo non avviene in un vuoto. Per decenni il più longevo primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha lavorato a instillare nella società ebreo-israeliana un concetto chiave: l’occupazione militare non va risolta, va gestita. Ha funzionato: la dottrina Netanyahu ha pervaso il paese, spostato brutalmente a destra l’opinione pubblica e cancellato dal panorama la questione palestinese. L’ha fatta dimenticare. Quanto avviene da decenni al di là dei due muri che tengono prigioniere Gaza e Cisgiordania era diventato invisibile, inesistente: la società israeliana, che ha sempre evitato di percepirsi come soggetto colonizzatore, come agente della colonizzazione, ha finito per assuefarsi a tale natura, senza più doverla neppure negare ma semplicemente rimuovendola.
Netanyahu ha dimostrato al suo paese e al mondo che lo stato di Israele non ha mai avuto un piano B per la questione palestinese: dal 1948 a oggi (e prima, nei decenni di strutturazione del movimento sionista e dell’arrivo in Palestina, con il silenzioso avvio della colonizzazione del paese) è sempre esistito solo un piano A, l’annessione di più territorio possibile, la massimizzazione della popolazione palestinese in spazi sempre più piccoli e rigidamente controllati e la negazione permanente e non negoziabile di una statualità palestinese indipendente.