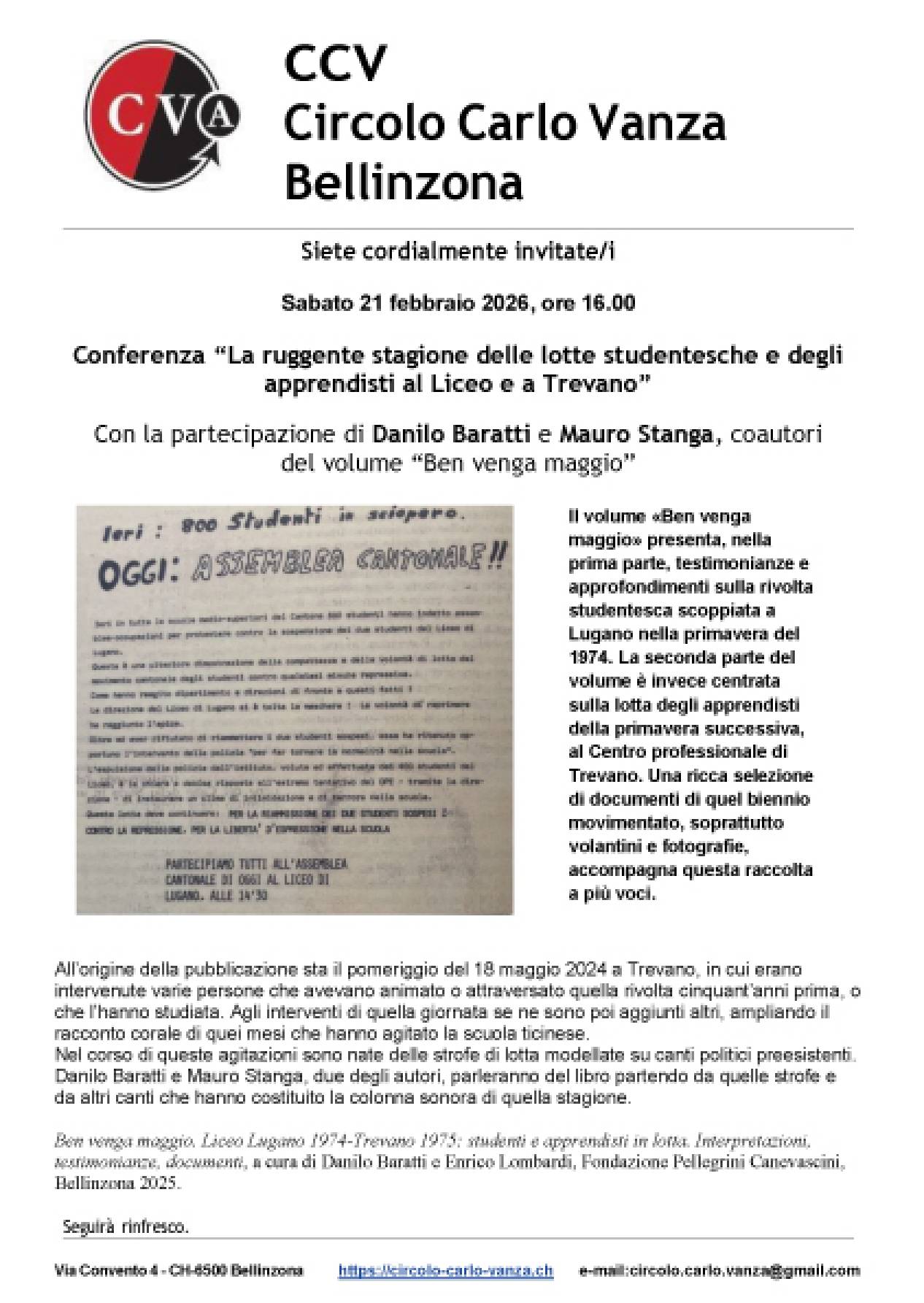La guerra di Israele contro Hezbollah non è ancora sfociata nell’invasione di terra che i vertici dello Stato ebraico avevano annunciato.
I bombardamenti su Beirut e sulle altre città libanesi continuano senza sosta ma Tel Aviv ribadisce che non si tratta di una guerra «contro i cittadini del Libano». Al contempo Netanyahu e i suoi generali minacciano che chiunque si frapporrà tra i soldati israeliani ed Hezbollah sarà considerato alla stregua di un nemico. E il monito non è rivolto solo al precario governo del Paese dei Cedri ma, soprattutto, alle Nazioni Unite e ai caschi blu dell’Unifil. Per «bonificare il sud del Libano», come dichiarano di voler fare i vertici israeliani, la forza di interposizione dell’Onu che è presente in quell’area dal Duemila è un ostacolo troppo grande. Si è aperta così una nuova fase dello scontro tra il governo di Bibi e la comunità internazionale, il cui esito influenzerà i rapporti di forza in Medioriente per i prossimi anni soprattutto ora che a Washington è stato eletto Donald Trump.
Partiamo da una considerazione: tra Libano e Israele non esiste un vero e proprio confine. Dopo il ritiro israeliano del 2000 il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha votato la Risoluzione 1701 che istituiva la cosiddetta «Linea Blu», ovvero una zona cuscinetto tra il territorio controllato da Beirut e quello di Tel Aviv, presidiata dalla Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (nota con l’acronimo
inglese Unifil). Il contingente più importante all’interno di tale missione è quello italiano, con oltre 1200 soldati della Brigata Sassari su un totale di 10400 uomini provenienti da 24 Paesi. Per anni il comando della missione è stato affidato a ufficiali di Roma, ora il capo è il maggiore generale spagnolo Aroldo Lázaro Sáenz ma il portavoce ufficiale e gran parte dei vertici organizzativi restano italiani. L’Unifil ha regole d’ingaggio molto chiare che si limitano al monitoraggio della zona loro assegnata e, in tempi di pace, ad azioni congiunte con le forze libanesi. Se i Caschi blu sono diventati un problema per Israele è per due motivi fondamentali: da un lato la Risoluzione 1701 gli assegna il controllo dell’area dalla quale partono i razzi di Hezbollah contro le città israeliane, che l’esercito dello Stato Ebraico vuole trasformare in un’estesa zona cuscinetto sotto il proprio controllo, dall’altro le basi della missione si trovano proprio lungo le direttrici che le truppe di Tel Aviv potrebbero usare per avanzare.
«Ricordiamo all’Idf e a tutti gli attori l’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite e di rispettare in ogni momento l’inviolabilità dei locali dell’Onu. Qualsiasi attacco deliberato contro le forze di pace è una grave violazione del diritto umanitario internazionale». Ha scritto il portavoce di Unifil, Andrea Tenenti, dopo i primi attacchi israeliani alle ba- si della missione il 10 ottobre. Poche ore dopo l’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon, si è limitato a ribadire che «la nostra raccomandazione è che l’Unifil si sposti di 5 km a nord per evitare pericoli». La frase successiva di Danon è risuonata come una minaccia, anche per i caschi blu: «Israele non ha alcun desiderio di stare in Libano, ma farà ciò che è necessario per costringere Hezbollah ad allontanarsi dal suo confine settentrionale in modo che 70.000 residenti possano tornare alle loro case» nel nord dello Stato ebraico. Netanyahu, Gantz e il portavoce delle forze armate Hagari hanno più volte rilasciato dichiarazioni simili, riassumibili con la formula: «non siamo noi che vogliamo far del male ai Caschi blu, ma se non ve ne andate è scontato che ci saranno problemi». Durante i primi attacchi le reazioni internazionali sono state molto dure, dalla Spagna che ha espresso «ferma condanna» e ha ribadito che «Israele ha il dovere di proteggere le forze di mantenimento della pace dell’Onu», a Dublino che si è detta «profondamente preoccupata» fino al ministro della Difesa italiano Crosetto che ha bollato come «inaccettabili» le azioni israeliane e ha tuonato che «l’Italia e l’Onu non prendono ordini da Israele».
Mai, dal 7 ottobre 2023, si erano viste prese di posizione così nette contro le azioni israeliane, neanche di fronte agli attacchi più sanguinari nella Striscia o ai bombardamenti più devastanti su Beirut. Tuttavia, gli attacchi sui peacekeepers e le basi di Unifil sono continuati. La scorsa settimana, secondo il portavoce della missione, un convoglio di caschi blu appena arrivati in Libano stava passando nei pressi del check-point Awali quando è stato raggiunto da alcuni droni israeliani. Cinque militari sono stati leggermente feriti insieme a 3 soldati libanesi. Tre persone, probabilmente civili, sono morte. Si è trattato del ventesimo attacco subito dall’Unifil dall’inizio dei bombardamenti israeliani sul Libano, ma è importante sottolineare che stavolta i droni israeliani hanno colpito in una zona che dovrebbe essere fuori dalle mire dell’esercito di Tel Aviv, molto più a nord di quel fiume Litani indicato spesso come obiettivo di Netanyahu.
Awali si trova nell’entroterra all’altezza di Sidone, ben oltre il Litani e la città di Tiro. Se davvero Israele ha intenzione di estendere la zona cuscinetto fino al fiume che passa per Awali ci troveremmo di fronte all’occupazione di quasi un terzo del territorio attuale di Beirut. Anche se non conosciamo nel dettaglio i piani del gabinetto di guerra dello Stato ebraico, sappiamo che i generali di Bibi non si accontentano più di una zona cuscinetto di 5 km, com’era fino alla scorsa estate. Con ogni probabilità le forze di terra israeliane intendono ricacciare indietro i miliziani di Hezbollah di almeno 40 km. C’è da scommettere sul fatto che nei piani di Tel Aviv il quartier generale di Unifil a Naqoura, sulla costa mediterranea tra l’attuale «linea blu» e Tiro, sia uno degli ostacoli principali. Non si può iniziare un’avanzata in forze con il rischio che i militari occidentali vengano feriti o uccisi. È vero che Netanyahu ha dimostrato chiaramente di disprezzare le istituzioni internazionali, definendo apertamente l’Onu una «palude anti-semita» durante il suo discorso all’ultima Assemblea generale lo scorso settembre, ma alienarsi definitivamente le simpatie dei principali alleati (nonché fornitori di armi) di Israele non è una decisione che si può prendere con leggerezza. Da questa considerazione nascono gli attacchi all’Unifil, sempre più vicini e sempre meno dimostrativi: si tratta di avvertimenti, nella speranza che il pericolo costringa il Consiglio di Sicurezza a far indietreggiare il contingente. Speranza finora del tutto disattesa. Netanyahu sa che è il suo momento: l’opera di ridefinizione degli equilibri e dei confini del Medioriente è ormai stata avviata e non può fermarsi senza aver raggiunto dei risultati chiari. L’elezione di Trump è stata percepita come una sorta di ulteriore conferma di impunità. Il tycoon ha più volte dichiarato il suo appoggio incondizionato a Israele e si è spinto fino a minacciare bombardamenti su
Teheran. Il disimpegno in Ucraina promesso dal neo-eletto presidente degli Usa non ha un riscontro simile in Medioriente. Gli Accordi di Abramo promossi dalla prima amministrazione Trump nel 2020 ne sono la prova ulteriore.
Al momento ci sono 4 divisioni israeliane a ridosso della Linea blu e la maggior parte degli analisti si chiede cosa stiano aspettando i generali. In molti ricordano che l’invasione di terra del 2006 fu un disastro per lo stato ebraico, che dopo appena 34 giorni e centinaia di feriti decise di interrompere le operazioni e ritirarsi dal Libano. Hezbollah la rivendicò come una vittoria e i vertici militari israeliani furono sommersi di critiche. In seguito i servizi segreti ebraici hanno studiato e spiato il «Partito di Dio» per anni. Fino al settembre del 2024 quando sono iniziati i bombardamenti sul territorio libanese, l’attentato simultaneo dei cercapersone, l’uccisione del leader storico Nasrallah e dei suoi luogotenenti. «Stavolta» si legge dovunque, «Israele ha imparato la lezione e non sottovaluterà Hezbollah». Del resto una vittoria, seppur parziale, Tel Aviv l’ha già ottenuta: decapitare i vertici dell’organizzazione e seminare il panico tra i miliziani. In qualsiasi area controllata dal Partito di Dio ora regna la paranoia. Gli stranieri, giornalisti inclusi, sono visti come possibili spie. Non ci si fida neanche più degli amici e ogni bombardamento che rade al suolo un palazzo di Beirut o di Baalbek accentua questo clima di confusione e sospetto. Molti capi, politici e militari, sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani e riorganizzare la linea di comando mentre i caccia e i droni nemici sorvolano costantemente le città è molto complesso.
Tuttavia, Hezbollah non è finita e gli scontri lungo la Linea Blu ne sono la prova. In questi due mesi circa di operazioni sporadiche via terra Israele si è limitato alle cosiddette «manovre esplorative», ovvero l’invio di piccole squadre di corpi speciali con obiettivi specifici. I militari israeliani non hanno mai trovato la strada libera e hanno subito alcune perdite. Se questa strategia sia volta a far uscire allo scoperto il nemico per colpirlo con l’artiglieria oppure sia un modo per setacciare il campo prima dell’arrivo del grosso delle truppe per ora non è chiaro. Ciò che è evidente è che la situazione non resterà così a lungo. Netanyahu non può rivendicare il contesto attuale come una vittoria, al netto dell’eliminazione dei capi di Hezbollah. I residenti ebraici dell’Alta Galilea non sono ancora potuti rientrare nelle proprie case a causa dei razzi che il Partito di Dio quotidianamente lancia sul nord di Israele. L’invasione, al momento, appare inevitabile e non è da escludere che il governo israeliano decida di entrare in azione prima dell’insediamento ufficiale di Trump a gennaio.