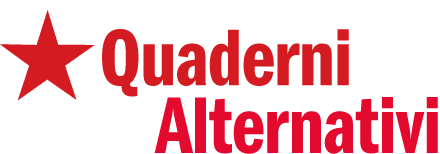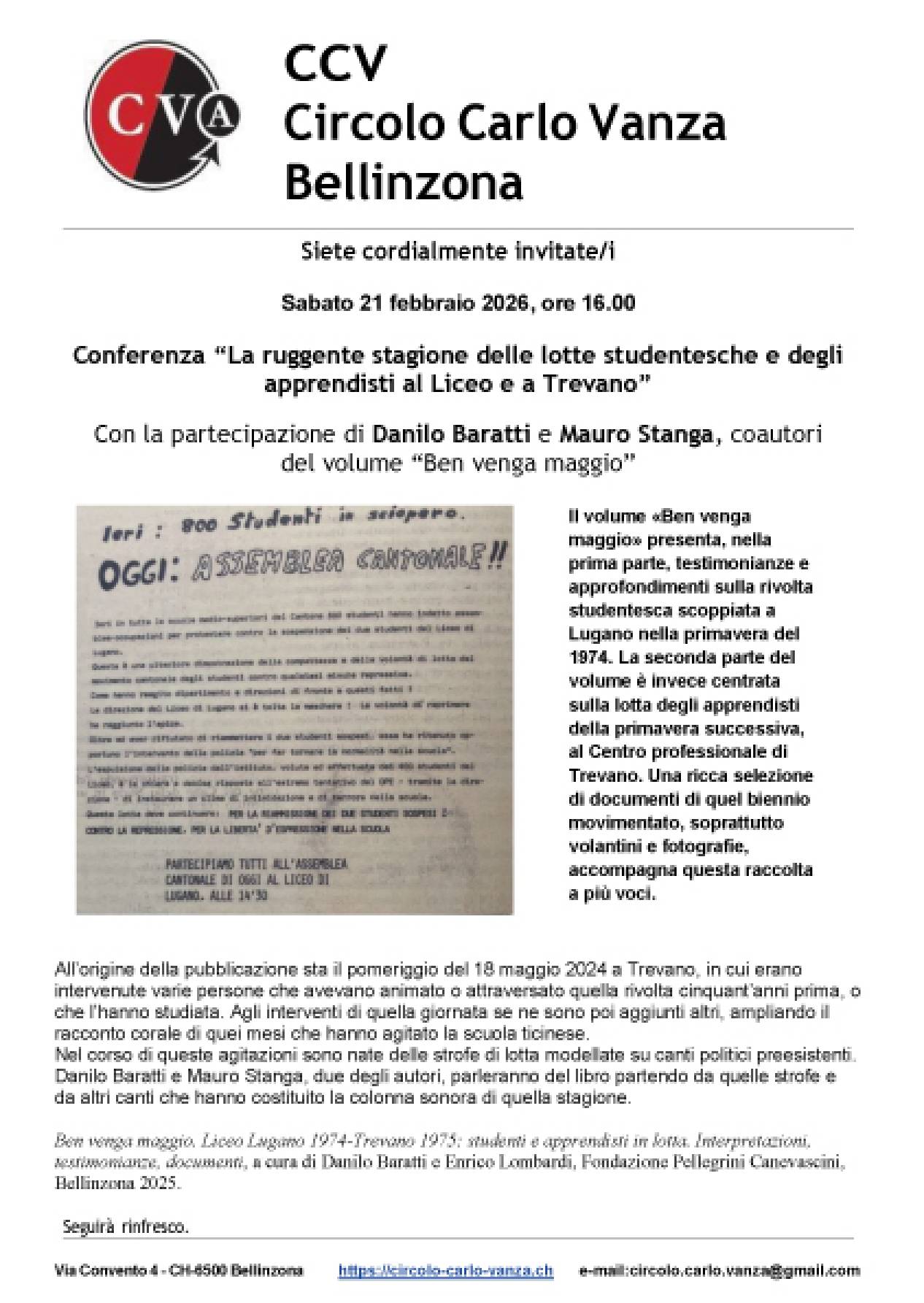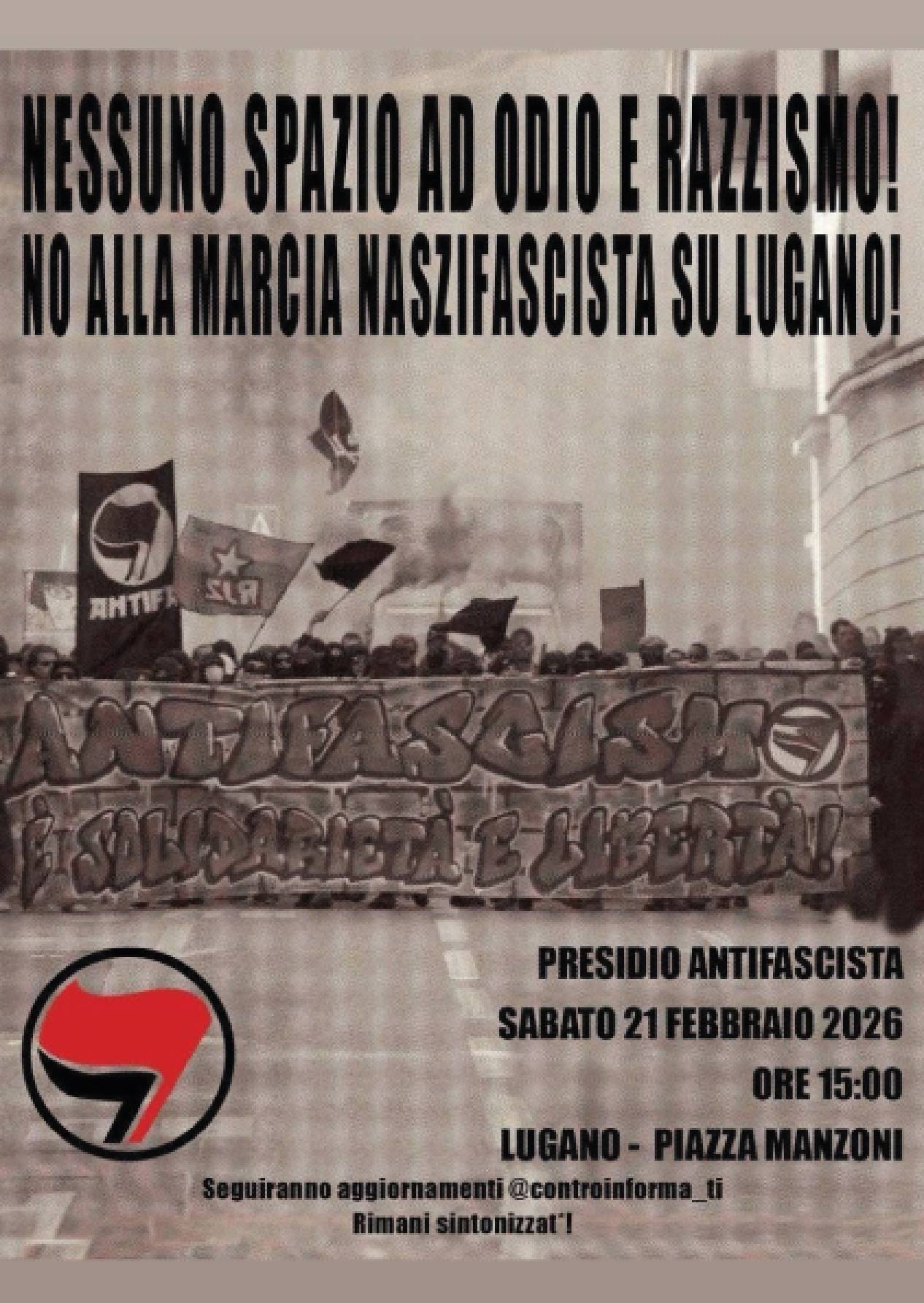È quanto si è verificato nei giorni scorsi, quando la tormenta ciclonica Rafael – del tutto fuori stagine – si è sovrapposto alla tormenta – questa iperannunciata – delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il cui esito a favore di Donald Trump fa presagire quattro anni terribili per l’isola.
È stato Trump infatti, nella sua prima presidenza dal 2016 al 2020, a rendere ancora più stretto e implacabile il blocco economico, finanziario e commerciale contro Cuba. Al corpo della legge Helms-Burton ha aggiunto più di 200 misure ostili, tra le quali quanto più simile vi era a un blocco navale dell’isola per impedire il rifornimento di petrolio.
Se per il subcontinente latinoamericano l’elezione di Trump significa un deciso appoggio alle destre locali – alla celebrazione della vittoria del repubblicano in Florida era presente il figlio dell’ex presidente brasiliano Bolsonaro – se per il Centramerica e per il Caribe si annuncia la tempesta della politica antimmigrazione di Trump e soprattutto i tagli alle rimesse che per vari stati centroamericani sono una necessità vitale, per Cuba si intravvede una possibile tragedia.
La situazione che attraversa l’isola è infatti assai più grave – molti commentatori la definiscono la più grave di sempre – rispetto a otto anni fa. La crisi che attraversa Cuba è di natura macroeconomica – alto debito estero, circa 30 miliardi di dollari, riserve monetarie estremamente ridotte, – poco più di 600 milioni di dollari, importazione dei principali prodotti alimentari, con un costo vicino ai 2 miliardi di dollari all’anno, e di più del 60% del petrolio necessario. Ma anche la produzione di beni industriali e di servizi è in calo e l’inflazione è stabilmente a due cifre, come dimostrano i dati diffusi dall’Onei (Istat locale), il dollaro si cambia nel mercato parallelo a più di 300 pesos. Nell’ultima riunione, la scorsa primavera, l’ANPP, il parlamento unicamerale che esprime il Poder popular, ha approvato un deficit fiscale del 118% per quest’anno.
Le ripercussioni di questa crisi sulla società sono tremende. L’economista Tamarys Bahamonde ha di recente riconosciuto che lo stipendio dei lavoratori del settore statale (quello medio è attorno ai 5000 pesos, poco più di 15 euro al cambio parallelo) non permette più di arrivare alla fine del mese al singolo lavoratore, ancor meno dunque all’intera famiglia. Nelle scorse settimane poi è entrato in profonda crisi il sistema nazionale di produzione di elettricità, ormai obsoleto e assai dispendioso, con la conseguenza di un black out totale dell’isola per 72 ore.
“Somos un país en crisis, dolido y que duele”, ha commentato lo storico Fabio Fernández. Che la situazione di Cuba faccia soffrire lo dimostra la dolorosa quotidianità della popolazione. Ormai la libreta, il pacchetto di beni a prezzi sussidiati, non serve se non per una decina di giorni (nei mesi scorsi il pane fornito dalla libreta è stato portato da 100 a 80 grammi per mancanza di farina), i prezzi dei generi alimentari forniti dai privati (Mypimes in generale) sono troppo alti per il cubano de a pie, le medicine scarseggiano in modo doloroso, il trasporto pubblico è in forte crisi mentre quello privato è caro (anche con le tariffe imposte dallo Stato), scuola e sanità in declino.
Drammatica è la situazione di gran parte dei pensionati, ovvero di chi ha contribuito negli anni produttivi della loro vita a far sì che la Rivoluzione resistesse nell’isola. Oggi con la loro pensione media non possono comprare nemmeno un cartone di uova.
I segnali più evidenti di questa profonda sofferenza sono l’emigrazione, soprattutto dei giovani, e il basso tasso delle nascite. Le stime del noto demografo Juan Carlos Albizu-Campos – “indipendente”, ovvero vicino all’opposizione, ma assai stimato – afferma che i cubani emigrati negli ultimi due-tre anni sono almeno 1,8 milioni. E che, dunque, la popolazione di Cuba è scesa parecchio sotto i dieci milioni (ultimo censimento dava la cifra di 11,2 milioni di abitanti nell’isola).
Dobbiamo dunque riconoscere, seppur con dolore, che l’economia cubana ha perso la capacità di crescere e di assicurare – come chiedevano le riforme del 2011 proposte da Raúl Castro – un socialismo “prospero e sostenibile”. Una situazione causata molto dall’embargo USA, ma anche da errori di programmazione economica da parte del governo. Eppure una via di uscita, basata sulla storica resilienza dell’isola, vi è, sostiene sempre lo storico Fernández, però “ripensando a quello che intendiamo per socialismo nelle condizioni specifiche di Cuba”. Ovvero, la necessità di riforme strutturali, indicate da anni da economisti come Omar Overleny e che qui sarebbe troppo lungo elencare. Però il socialismo cubano deve basarsi su tre colonne portanti: mantenere la sovranità del paese (principale obiettivo dell’embargo USA), conservare la giustizia sociale, trovare il modo di uscire dalla grave crisi economica.
Quest’ultimo punto, con la presidenza di Trump, si prospetta assai problematico. L’unica possibilità che si intravvede è quella di rinforzare i legami con i paesi rimasti amici, Russia e Cina – soprattutto la prima. Non si tratta però di un ritorno al passato – che peraltro ben pochi vogliono. Il mondo è cambiato e nelle offerte del presidente russo Vladimir Putin vi è ben poco di ideologico e molto di geopolitico. Però la mediazione di Putin, nel recente vertice di Kazan, è stata fondamentale perché Cuba fosse accettata come membro associato del BRICS, il gruppo che si sta attrezzando per un sistema proprio di monete e di SWIFT e con una propria banca di investimenti.
Questo status potrebbe offrire a Cuba l’accesso a meccanismi di cooperazione e commercio in uno dei blocchi più influenti del mondo. Si tratta comunque per l’isola di un obiettivo importante per il suo inserimento in un ambito multilaterale, che smentisce le voci di isolamento internazionale diffuse dall’opposizione. Soprattutto l’associazione ai BRICS permetterà all’isola di diversificare le relazioni commerciali e politiche e cercare di trovare mercati per i prodotti cubani in paesi che meno sono coinvolti dalle intimidazioni dell’embargo USA. Inoltre potrebbe essere una opportunità di commerciare con l’uso di altre monete, fatto importante per uno Stato che subisce la proibizione (da parte degli USA) dell’uso del dollaro. Insomma, è una porta che si apre, anche se gli effetti non si vedranno in tempi brevi. Però è necessario – come ha affermato anche la Cina – attuare riforme di struttura “per la modernizzazione del socialismo” cubano.
Questa sorte di paracadute fornito dal blocco BRICS a Cuba nei confronti dell’imperialismo USA, non è stato però concesso al Venezuela, altro paese soggetto a spietate sanzioni di Washington. È stato il Brasile del presidente Lula a porre un veto che ha ferito lo schieramento progressista latinoamericano. La diplomazia brasiliana ha affermato che il presidente venezuelano Maduro non ha rispettato gli impegni presi – riguardo alla pubblicazione degli atti delle ultime elezioni presidenziali, in pratica uno sgarro che ha minato la credibilità internazionale di Lula in un momento assai delicato delle relazioni internazionali. Ma proprio l’elezione di Trump e la minaccia di una politica di aperto – e violento – sostegno nordamericano alle destre più reazionarie (Bolsonaro in Brasile e Milei in Argentina soprattutto) dovrebbe far riflettere il presidente brasiliano e recuperare una relazione costruttiva col Venezuela.