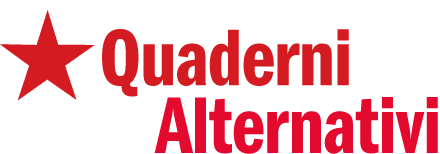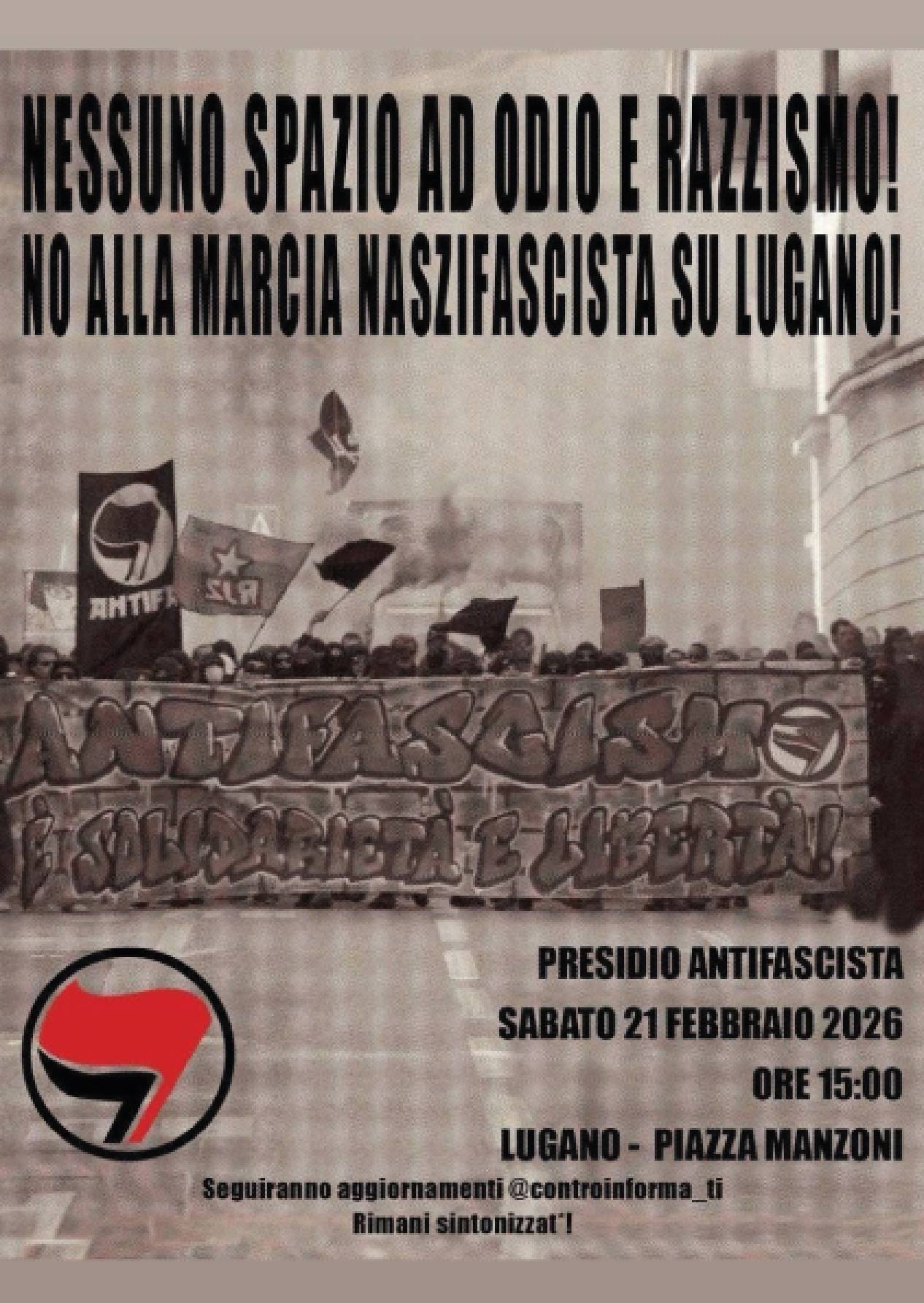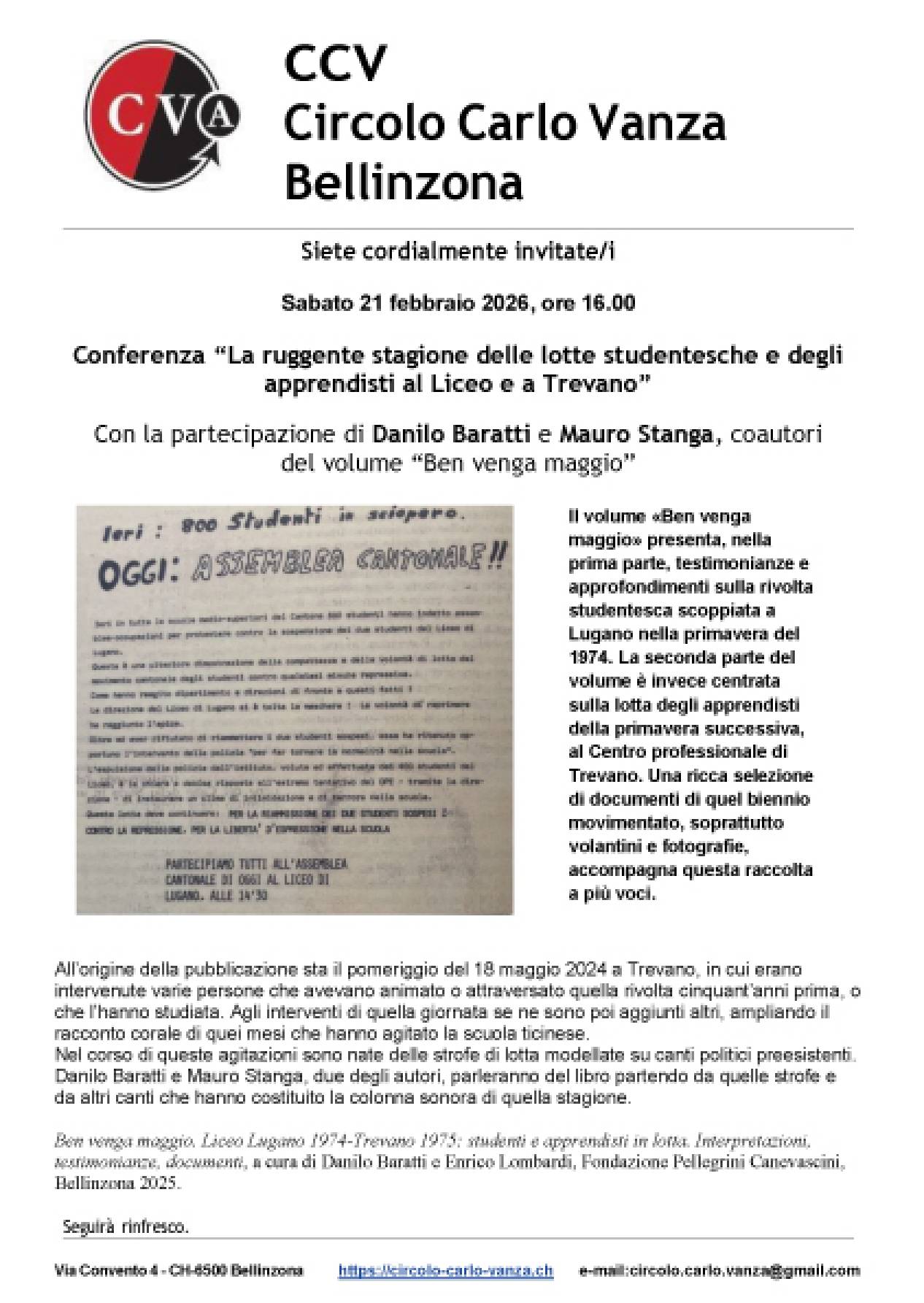Nel comunicato stampa del 30.9.2024 la Commissione Federale della Migrazione riferisce:
In alcuni casi (i bambini e i ragazzi richiedenti asilo) vivono in strutture collettive periferiche, condividendo la stessa stanza con l’intera famiglia e non dispongono di uno spazio in cui ritirarsi. Spesso vengono scolarizzati all’interno di queste stesse strutture, il che rende loro ancora più difficile stabilire contatti sociali. L’isolamento, la mancanza di prospettive e la sensazione d’impotenza pregiudicano il loro sviluppo psicosociale e la loro salute mentale.
L’articolo di Manuele Bertoli, presidente della CFM, apparso su La Regione del 14.10.24, apre il varco di cui abbiamo bisogno per riportare avanti la nostra esigenza di scolarizzare nella scuola pubblica i minori che per ora rimangono dietro i muri di strutture completamente inadeguate al loro benessere fisico e psichico.
Molto giustamente Bertoli ricorda che in passato la nostra storia ha già conosciuto pagine oscure riguardanti scelte politiche disastrose nei confronti dell’infanzia… (delle quali) ci siamo giustamente rammaricati, riconoscendo che le cose avrebbero dovuto andare in maniera diversa e che i diritti dei bambini avrebbero dovuto venire prima di tutto, prima delle considerazioni politiche o economiche.
L’esclusione delle persone che vivono ai margini della società del benessere è una politica che continua ad essere praticata senza scrupoli di coscienza nel nostro paese. L’indifferenza con la quale viene accolta ancora oggi è per lo meno stupefacente: persino nel Mendrisiotto la maggioranza dei cittadini non sa che a Pasture c’è un Centro Federale per richiedenti asilo nel quale vengono negati ai bambini il diritto e la possibilità di frequentare la scuola dell’obbligo in un istituto scolastico pubblico.
Le motivazioni politiche per giustificare queste misure contrarie ai diritti umani e ai diritti dei bambini sono scandalosamente simili a quelle invocate, sempre a distanza di 50 anni, dai nostri ineffabili presidenti della Confederazione:
- Nel 1987 si è scusato Alphons Egli per le discriminazioni subite dagli Jenisch;
- Nel 1995 si è scusato Kaspar Villiger per il timbro “J” che comportava il respingimento degli ebrei alle nostre frontiere;
- Nel 2010 delle scuse sono state espresse da Eveline Widmer-Schlumpf per i collocamenti dei bambini che provenivano da famiglie povere o erano figli illegittimi, perché la situazione familiare era precaria oppure perché i ragazzi erano considerati «difficili», scomodi o ribelli.
- Simonetta Sommaruga ha ribadito nel 2013 «Non possiamo continuare a far finta di niente perché è quello che stiamo facendo da troppo tempo… [...] Ecco perché auspico che questo giorno sia anche un manifesto della volontà di tenere gli occhi aperti e di impedire che la realtà venga rimossa o dimenticata… Dal profondo del cuore vi chiedo, a nome del Governo Svizzero, sinceramente scusa per la sofferenza che vi è stata inflitta.»
- Nel 2018, anche i nostri politici Manuele Bertoli e Walter Gianora hanno presentato le scuse ufficiali alle vittime, affermando che «è compito di una società civile percorrere il cammino verso la verità, evitando di cadere in un facile oblio… affinché le leggi decise dalla politica siano in futuro sempre uno strumento di giustizia».
Anche noi ci scuseremo solo fra cinquant’anni con i bambini e i ragazzi del Centro Federale di Pasture per aver reso invisibili le loro vite e aver negato loro la possibilità di sperare in un futuro possibile e di essere riconosciuti dai loro coetanei? Bertoli dice che i bambini… non meritano di subire le conseguenze di questa politica restrittiva e delle decisioni degli adulti, e aggiunge: Questa situazione va riconosciuta e radicalmente modificata ora, senza attendere tra qualche decennio un’ammissione tardiva di inadeguatezza, magari con annesse scuse e un po’ di soldi.
Salutiamo le parole del nostro ex-ministro del DECS per contrastare l’indifferenza che ci porta a rendere invisibili le presenze. Vogliamo sperare che in tempi brevissimi tutti i minori del CFA di Pasture in età scolastica possano frequentare delle classi di accoglienza nelle nostre scuole per garantirci che una piccola parte dell’infanzia che risiede in Svizzera non meriti trattamenti al di sotto degli standard minimi di civiltà.
Speranza è una parola che può respirare solo se riusciamo a riscoprire il valore delle storie che ognuno porta con sé e a fare in modo che le storie vengano conosciute e riconosciute. Far uscire le storie dallo stagno dell’indifferenza è una necessità per alimentare una società in cui dalla cura e dalla curiosità reciproca possano nascere Cura, Calore, Accoglienza, Mutualità, Solidarietà, Conforto.