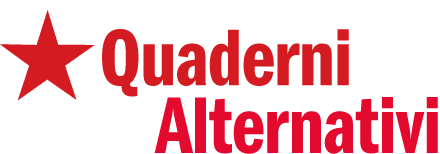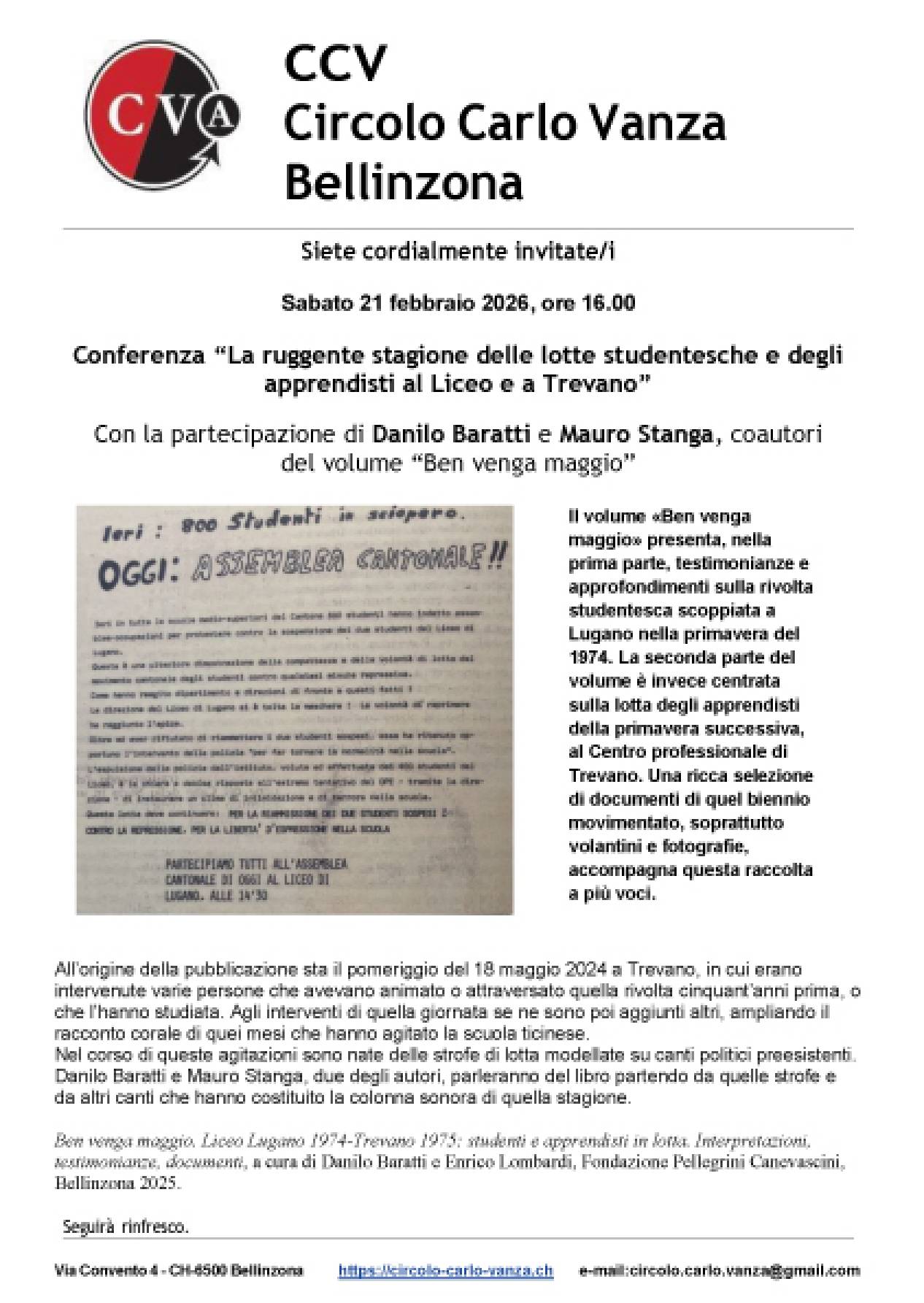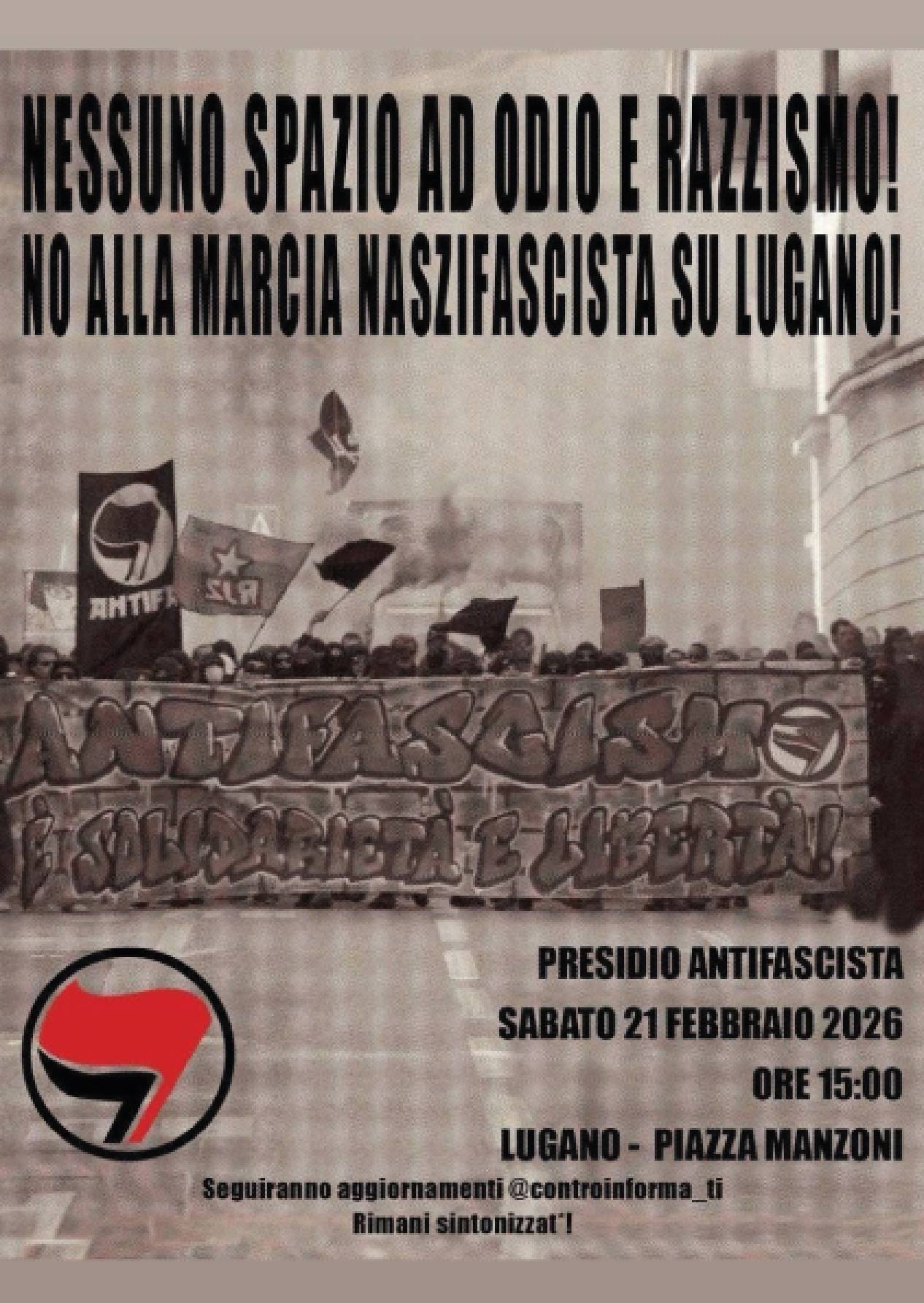La scoperta nel 1939 della fissione di nuclei di uranio bombardati con neutroni, con una notevole produzione di energia e la diffusione di nuovi neutroni, fece apparire a molti l’incredibile possibilità di una reazione a catena con grande potenziale esplosivo e una grande produzione di energia.
Come ha ben mostrato il film Oppenheimer, la guerra iniziata di lì a poco indusse gli Stati Uniti a un incredibile sforzo per produrre la bomba che sarebbe poi esplosa nel 1945 a Hiroshima e a Nagasaki. Enrico Fermi era riuscito nel 1942 a realizzare una reazione controllata: il primo reattore nucleare.
La storia dell’energia nucleare è stata fin dall’inizio caratterizzata da uno stretto legame tra uso militare e uso pacifico. Anche la Svizzera, come molti altri paesi, non voleva restare senza la nuova arma e avviò negli anni 60 la costruzione di un proprio reattore a Lucens (VD). Ma nel 1969 un incidente con la fusione di alcuni elementi e la fuoriuscita di materiale radioattivo mise fine ai sogni elvetici di diventare una potenza nucleare: la caverna in cui era stato costruito il reattore fu sigillata. E si passò a comprare e istallare modelli commerciali statunitensi a scopi pacifici.
Già allora la giustificazione per un’impresa così rischiosa era la ventilata difficoltà di approvvigionamento: nel marzo del 1964 articoli della NZZ, citando il difficile inverno 1962/63 e la difficoltà di realizzare nuovi impianti idroelettrici, proponevano come soluzione l’energia nucleare. Tra il 1969 (Beznau 1) e il 1984 sono state costruite cinque centrali nucleari (di cui una, Mühleberg, è stata dismessa nel 2019: costi previsti, circa tre miliardi di franchi). La altre, tra le più longeve al mondo, resteranno in funzione finché la sicurezza sarà garantita!
Le proteste popolari e il grave incidente di Chernobyl nel 1986 misero fine ai progetti di espansione nucleare. Ma nel 2011, in una votazione consultiva, la cittadinanza del Canton Berna accettò di stretta misura la proposta di una nuova centrale nucleare. Il gravissimo incidente di Fukushima, un mese dopo, bloccò definitivamente le prospettive di nuove centrali. Nel 2017 la legge sull’energia nucleare, approvata in votazione popolare, decretava la proibizione di costruire nuove centrali.
La situazione di compromesso qui descritta (solo le vecchie centrali possono continuare a funzionare) non è però accettabile! La sicurezza, controllata dall’autorità di sorveglianza IFSN/ENSI, non è soddisfacente: si tratta di modelli tra i più vecchi al mondo ancora in funzione che non corrispondono agli standard di sicurezza attuali: il loro funzionamento prolungato comporta un rischio sproporzionato per la popolazione.
La gestione delle scorie radioattive prodotte non ha trovato una soluzione. «Attualmente le scorie sono depositate in condizioni di piena sicurezza in capannoni in superficie, situati presso le centrali nucleari e in due depositi intermedi centrali nel Cantone Argovia. Perché non costituiscano più un pericolo per le persone e l’ambiente, queste scorie devono essere conservate per decine di millenni o, a seconda della loro categoria, addirittura per un milione di anni (UFE).» Millenni! Ma mille anni fa il mondo era completamente diverso, la Svizzera non esisteva ancora, per dire… La NAGRA ha deciso di realizzare un deposito di scorie radioattive in strati geologici «stabili», nel Canton Zurigo. Entrata in funzione prevista fra 30 anni!
In questa fase, in attesa che il continuo progresso delle energie rinnovabili raggiunga gli obiettivi previsti per il 2050, un gruppo legato ai partiti di centro-destra e alla lobby nucleare ha lanciato l’iniziativa «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)». Nel testo non si parla di energia nucleare, ma, rifacendosi alla paventata carenza energetica, si dichiara che «sono ammissibili tutti i tipi di produzione di energia elettrica rispettosi del clima.» L’iniziativa è finanziata dalla «Fondazione per un approvvigionamento elettrico sicuro», una sottofondazione della «Fondation des fondateurs». È sostenuta dal multimilionario Daniel S. Aegerter, cofondatore di «Energy for humanity», una lobby per la promozione dell’energia nucleare in Svizzera e nel mondo.
Il Consiglio federale ha purtroppo subito dichiarato che, come contro-progetto, intende stralciare dalla Legge federale sull’energia nucleare il divieto di costruire nuove centrali. Un segnale preoccupante, considerato che fino alla discussione e alla votazione sull’iniziativa passeranno ancora molti anni.
- Nuove centrali nucleari non contribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento e agli obiettivi della strategia energetica 2050, perché arriveranno sicuramente troppo tardi (ci vorranno almeno 20 anni per la loro entrata in funzione), sono ancora molto pericolose e troppo costose (nessuna azienda se la sente di affrontare questi investimenti, senza un importante aiuto statale!)
- I problemi che da anni vengono criticati (stoccaggio definitivo delle scorie, pericolosità del funzionamento, dipendenza dall’estero per il combustibile nucleare) non sono stati risolti.
- Il dibattito sul rilancio dell’energia nucleare sta disturbando in modo massiccio la rapida espansione delle energie rinnovabili, di cui c’è urgente bisogno; minacciando anche di distogliere investimenti da queste ultime.
- Il Consiglio federale ignora la volontà popolare: 7 anni fa, la Svizzera ha deciso di eliminare gradualmente l’energia nucleare con il 58% di voti favorevoli.
Al mondo ci sono più di 400 centrali nucleari; negli ultimi 20 anni 107 sono state dismesse e 100 nuove sono entrate in funzione. Anche se molte centrali sono in costruzione (quasi 60: in Cina, India, Turchia, Egitto ecc.) e progettate, non si può parlare di un aumento del loro numero. In Francia, per esempio, dove sono previste da 6 a 9 nuovi centrali, il governo ha dovuto nazionalizzare «Energie de France» che si era indebitata per 64 miliardi di euro per gestire il suo parco nucleare. Ciononostante nel 2022 la metà delle centrali francesi era fuori uso! La costruzione di Flamanville3 è durata 12 anni più del previsto con un superamento di spesa di 10 miliardi di euro. In Finlandia la costruzione di una centrale decisa nel 2015 è terminata nel 2023 con costi passati da 3 a 11 miliardi di euro. In Inghilterra una nuova centrale decisa nel 2012 (in collaborazione con industrie francesi e cinesi) entrerà in funzione verso il 2030, con costi di quasi 60 miliardi di euro.
E quando si parla di costi di costruzione, non sono compresi i costi per la dimissione e per i premi assicurativi, di fatto assunti dallo Stato.
La centrali in costruzione appartengono alla terza generazione di centrali nucleari che dovrebbe garantire maggiore sicurezza ed efficienza. Si parla però molto delle future centrali di quarta generazione. Tra i vantaggi: scorie che restano radioattive «solo» per secoli, sfruttamento fino a 100 volte maggiore del combustibile nucleare, maggiore scelta di combustibili, possibilità di «bruciare» scorie, maggiore sicurezza.
Uno dei rischi più importanti deriva dall’uso in ceti modelli di sodio liquido a 800 gradi: il sodio al contatto con l’aria esplode! In generale i critici mettono in guardia dal rischio di errori umani nell’implementazione di nuove tecnologie. Questi progetti sono interessanti, ma per ora esistono solo centrali sperimentali ed è quindi difficile prevedere i tempi della loro commercializzazione.
Un argomento spesso usato per sostenere l’energia nucleare, oltre al sempre citato approvvigionamento sicuro, è ora quello del suo basso impatto nella produzione di CO2. A differenza di una centrale a carbone o a gas, il funzionamento di una centrale nucleare non produce CO2, ma i processi di estrazione e raffinazione del minerale di uranio, la produzione del combustibile per i reattori e la costruzione della centrale richiedono tutti grandi quantità di energia che, se realizzati con energie fossili, producono quantità di CO2/kWh confrontabili con quelle delle tecnologie rinnovabili.
La lobby nucleare e il suo abile rappresentante in Consiglio federale, Albert Rösti, parlano volentieri delle difficoltà della strategia energetica 2050: i suoi ritardi, le opposizioni di ambientalisti ai suoi progetti, i suoi obiettivi ambiziosi. Si tratta evidentemente di profezie che si autorealizzano: la strategia energetica 2050 segue il suo corso e i suoi obiettivi sono realistici, pur esigendo investimenti notevoli. E l’obiettivo non è l’autarchia energetica svizzera, ma la garanzia dell’approvvigionamento con i nostri partner europei.
Per i motivi già citati, invece di lanciarsi in improbabili futuri nucleari, è oggi importante garantire il successo della strategia energetica 2050, basata sulle fonti rinnovabili di energia.