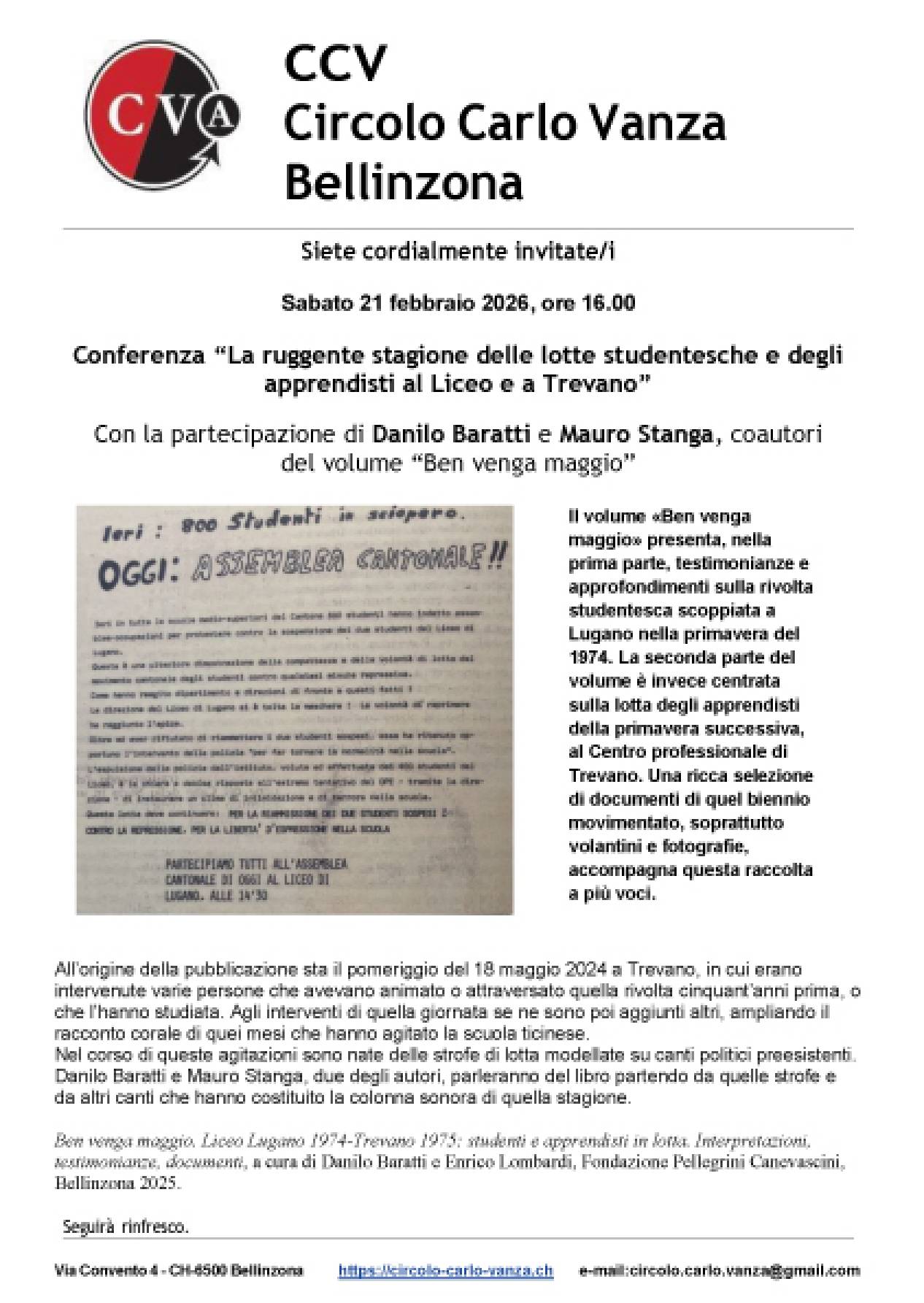Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati uniti e Mustafa Barghouti, uno degli esponenti più noti e stimati della società civile palestinese, non ha voglia di spiegare, ancora una volta, perché per lui e la sua gente il risultato delle elezioni americane è irrilevante. Accetta con riluttanza.
«Per noi non è una questione di Biden e Trump, piuttosto è un problema generale, direi storico, di rapporto con gli Stati Uniti e con la politica di Washington in Medio Oriente» afferma «dopo gli Accordi di Oslo del 1993 (tra Israele e l’Olp, ndr) considerati da più parti, con troppa enfasi a mio avviso, come la fase più favorevole per la nascita di uno Stato palestinese, gli Usa si sono limitati a fare dichiarazioni senza mai agire concretamente per mettere fine all’ occupazione israeliana e realizzare le nostre legittime aspirazioni, messe nero su bianco da innumerevoli risoluzioni dell’Onu. Sono passati decenni e l’atteggiamento degli Stati uniti non è mai cambiato con qualsiasi Amministrazione, democratica o repubblicana. Gli Usa stanno con Israele sempre e comunque. Lo abbiamo visto chiaramente quest’ultimo anno. L’Amministrazione Biden non ha mosso un passo vero per fermare l’attacco israeliano a Gaza. Anzi, ha continuato a rifornire Israele di armi e bombe che hanno ucciso decine di migliaia di palestinesi».
Non sono la rabbia e la frustrazione a condizionare queste dichiarazioni di Mustafa Barghouti. La sua, dice, è la lucida constatazione della realtà internazionale e locale con cui i palestinesi si confrontano da decenni. «Il problema è l’Occidente nel suo insieme non Trump – prosegue –, con lui le cose, forse o sicuramente, peggioreranno ulteriormente, ma se dal voto fosse uscita vincitrice la democratica Kamala Harris per noi le cose sarebbero andate meglio? Non credo. Avremmo ascoltato qualche dichiarazione ipocrita in più di solidarietà ai civili di Gaza sotto le bombe, peraltro americane, e nella sostanza non sarebbe cambiato nulla». Gli altri governi occidentali, aggiunge l’esponente palestinese, non sono migliori. «Fanno uso sempre di un doppio standard. Se un bambino israeliano viene ucciso, è una cosa orribile e sono d’accordo. Ma quando migliaia di bambini palestinesi sono massacrati da Israele, questa cosa è giudicata normale e legittima. Un palestinese che lotta per la sua libertà è accusato di essere un terrorista; invece, quando (il premier israeliano) Netanyahu uccide 17.000 bambini e più di 11.000 donne e distrugge l’80% delle case a Gaza, nessuno dice che Netanyahu è un terrorista».
Le opinioni di Mustafa Barghouti sono condivise da milioni di palestinesi, stanchi delle promesse non mantenute americani ed europei e, per questo motivo, disinteressati all’esito delle presidenziali Usa. Tuttavia, questa ostentazione di indifferenza verso il prossimo ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, maschera l’inquietudine che nei Territori palestinesi occupati caratterizza l’attesa per l’inizio del nuovo mandato del tycoon. «Le soluzioni a spese dei palestinesi o il sostegno militare infinito a Israele non saranno altro che un catalizzatore per futuri scontri», ha previsto Sabri Saidam, un membro di spicco di Fatah – il partito su cui si regge l’Autorità Nazionale Palestinese – uno dei rari esponenti palestinesi legati al presidente Abu Mazen che in questa fase ammettono liberamente che con Trump le cose andranno decisamente peggio, o almeno questo dicono la storia recente e le dichiarazioni del nuovo inquilino della Casa Bianca.
Il fatto che Benyamin Netanyahu sia stato uno dei primi a congratularsi con Trump – «Congratulazioni per il più grande ritorno della storia!... È un ritorno storico che renderà più forti le relazioni tra Stati uniti e Israele», ha twittato il primo ministro il 6 novembre alle prime ore del mattino – e i festeggiamenti di gran parte degli israeliani, sono un indicatore fondamentale per capire quanto la destra israeliana al potere sia convinta di poter ottenere da Trump di più rispetto a quanto ha già avuto dall’Amministrazione Biden. Il ricordo degli israeliani va al primo mandato (2016-2020) di Trump, quando Netanyahu definì il presidente Usa «il miglior amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca». Il tycoon americano si guadagnò l’applauso degli israeliani facendo uscire gli Usa dall’accordo sul nucleare iraniano a cui Israele si opponeva e ottenendo la normalizzazione tra lo Stato ebraico e quattro paesi arabi ora conosciuta come gli Accordi di Abramo. Inoltre, riconobbe Gerusalemme come capitale di Israele e il Golan siriano occupato come parte del territorio dello Stato ebraico e affermò la «legalità» della colonizzazione della Cisgiordania palestinese. Il primo mandato di Donald Trump è stato «esemplare» per quanto riguarda Israele, ha ricordato qualche giorno fa Michael Oren, ex ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. «La speranza è che torni a quelle politiche», ha aggiunto. Se Israele collaborasse con Trump, auspica Oren, potrebbe raggiungere risultati enormi. La strada appare spianata per Netanyahu che lavora alla negazione dei diritti dei palestinesi e al ridimensionamento delle ambizioni e del ruolo dell’Iran nella regione, anche con una guerra distruttiva. E Trump può aiutarlo.
Non tutto però potrebbe filare liscio come il premier israeliano si aspetta. Netanyahu non vuole la fine a breve termine dei conflitti (Gaza e Libano) e ciò si scontra, in apparenza, con l’affermazione di Trump di essere in grado di ottenere un cessate il fuoco subito in Medio Oriente. In realtà nessuno ha compreso bene cosa Trump intenda per fine della guerra, anche perché ha esortato Netanyahu «a finire il lavoro» a Gaza. È probabile che non si riferisca alla conclusione completa delle operazioni militari israeliane, ma solo alla chiusura dell’offensiva principale in corso dall’ottobre 2023 lasciando ampio spazio di manovra ad incursioni improvvise nella Striscia, come quelle che Israele già compie in Cisgiordania.
Secondo l’analista Arnaud Peyronnet, ricercatore della Mediterranean Foundation for Strategic Studies, non ci sono dubbi: Trump come avvenuto nel primo mandato darà un forte contributo all’annullamento della questione palestinese. Nulla fa pensare il contrario e la presunta imprevedibilità del tycoon è più una invenzione dei media che una realtà. La cerchia ristretta intorno al nuovo presidente, peraltro, è cambiata poco rispetto a qualche anno fa. Il gruppo include il genero di Trump, Jared Kushner che vede la zona costiera di Gaza come una risorsa per il turismo immobiliare, e David Friedman ex ambasciatore a Tel Aviv: entrambi sono due accaniti sostenitori della colonizzazione israeliana e «se necessario» del «trasferimento» (deportazione) della popolazione palestinese.
Vari opinionisti si aspettano che Trump dia priorità a un accordo trilaterale tra Washington, Riyadh e Tel Aviv, con l’obiettivo di stabilire legami diplomatici tra Arabia Saudita e Israele, una prospettiva che sembrava prossima al completamento prima del 7 ottobre 2023. «Una fantasia totale ora», secondo Nader Hashemi, poiché dopo un anno di bombardamenti a tappeto di Gaza e alla luce dei sentimenti che attraversano la loro opinione pubblica i sauditi chiedono in cambio della normalizzazione la creazione di uno Stato palestinese. Non è marginale il lungo silenzio del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman (MbS), di fatto già alla guida del regno, che poco più di un anno fa appariva disposto ad avviare rapporti alla luce del sole con Israele (dietro le quinte le due parti collaborano da anni). Fonti giornalistiche arabe sostengono che MbS avrebbe detto lo scorso agosto a una delegazione americana che in questa fase delicata per i palestinesi, Gaza e tutto il Medio Oriente, la normalizzazione con Tel Aviv metterebbe a rischio la sua stessa vita. Ha aggiunto che abbandonasse l’Iniziativa araba del 2002 (promossa proprio dai sauditi, propone la pace definitiva con Israele in cambio del suo ritiro dai territori palestinesi e arabi che ha occupato nel 1967) per allacciare rapporti ufficiali con Israele, il suo paese subirebbe un pesante contraccolpo. Secondo il portale Axios, la monarchia Saud preme ora sull’Amministrazione Usa uscente per firmare l’intesa bilaterale di sicurezza prima dell’ingresso di Trump alla Casa Bianca, in modo da non essere costretta ad accettare la normalizzazione dei rapporti con Israele.
Gli Accordi di Abramo sono giudicati morti da molti, nel migliore dei casi resteranno congelati per diversi anni. Anche se i conflitti in corso si fermassero domani, difficilmente uno Stato arabo potrebbe decidere di abbracciare Netanyahu e unirsi al campo della normalizzazione in tempi brevi. Trump con ogni probabilità farà generose promesse ai sauditi e altri paesi arabi, ma senza un impegno serio degli Usa per una vera indipendenza palestinese e la fine dell’occupazione israeliana non raggiungerà lo scopo. La preoccupazione più concreta in casa palestinese è legata a ciò che Trump farà se non avrà modo di dare nuova linfa agli Accordi di Abramo e portare Netanyahu a stringere la mano di altri leader arabi. Dopo aver donato a Israele il riconoscimento americano della sovranità (non riconosciuta dal resto del mondo) su tutta Gerusalemme e il Golan siriano, Trump non ha molti altri regali per gli alleati israeliani. «Il rischio più concreto è il via libera della nuova Amministrazione Usa all’annessione a Israele della Cisgiordania», dice l’analista palestinese Hamada Jaber, di Ramallah. «Si tratta di un obiettivo storico della destra israeliana» aggiunge Jaber «a sostenerla non sono più solo le forze politiche ultranazionaliste e il movimento dei coloni. Questo progetto ha ora l’appoggio di larghi settori dell’opinione pubblica israeliana e le forze politiche di centrosinistra potrebbero non ostacolarlo. Se così fosse, la fine della soluzione a Due Stati (Israele e Palestina, ndr) sarebbe ufficiale e l’apartheid palestinese conclamato».
Di fronte a questo pericolo, i palestinesi sotto occupazione continuano a vivere la crisi politica interna più profonda della loro storia, con la frattura tra Fatah e il movimento islamico Hamas che non è prossima a chiudersi nonostante la distruzione di Gaza da parte di Israele e decine di migliaia di morti palestinesi. «E non si chiuderà» prevede il commentatore Jahad Harb. «Fatah e Hamas – spiega – si sono incontrati in Cina e poi in Egitto dando l’impressione di volersi riconciliare. Ma le cose stanno diversamente. Fatah non intende condividere il governo in Cisgiordania perché sa che aprirebbe la stanza dei bottoni ad Hamas. Gli islamisti da parte loro accetteranno un governo di consenso nazionale con Fatah a Gaza solo se saranno sicuri di poter ancora esercitare il controllo di fatto su tutta la Striscia».