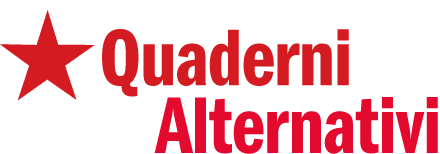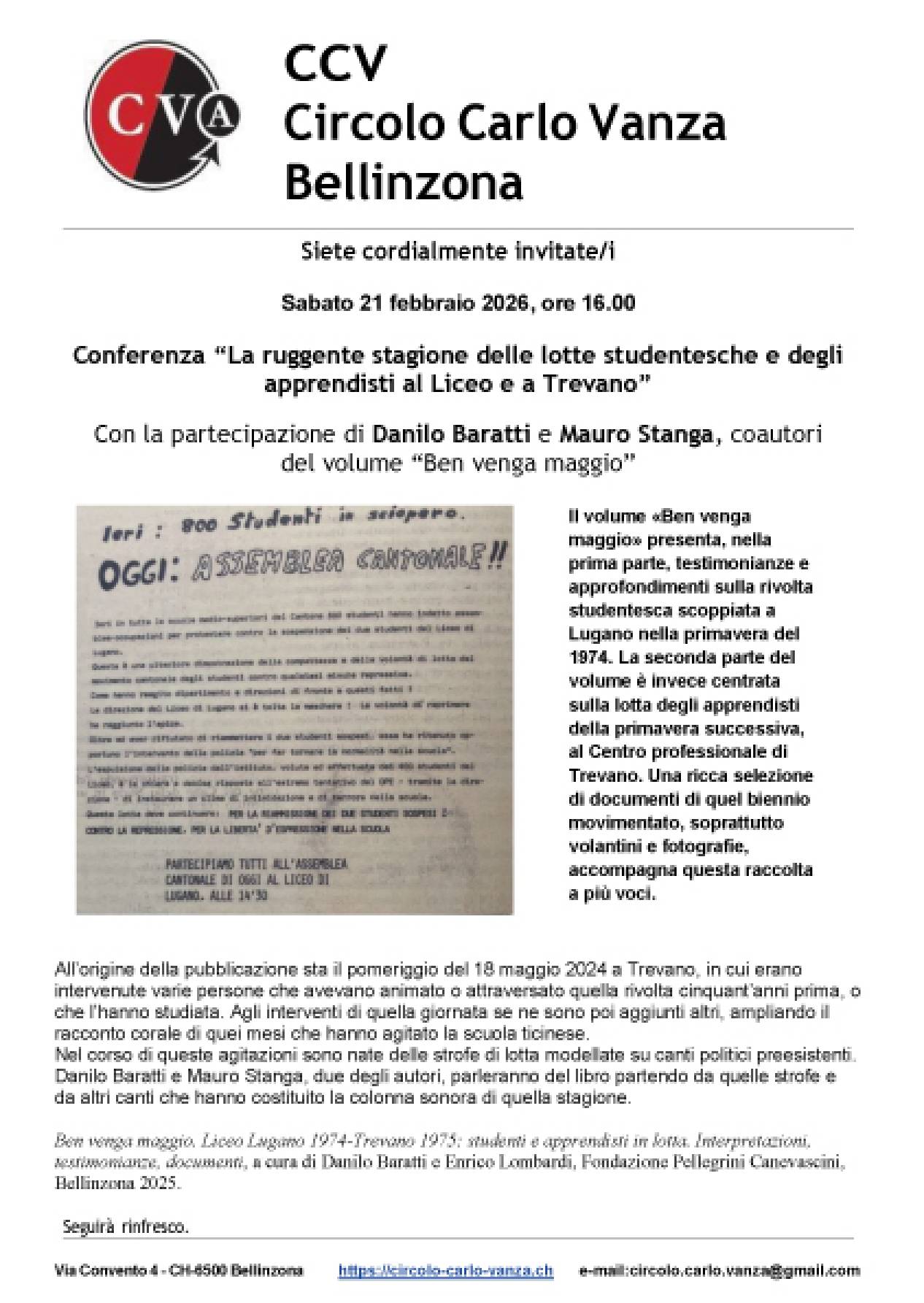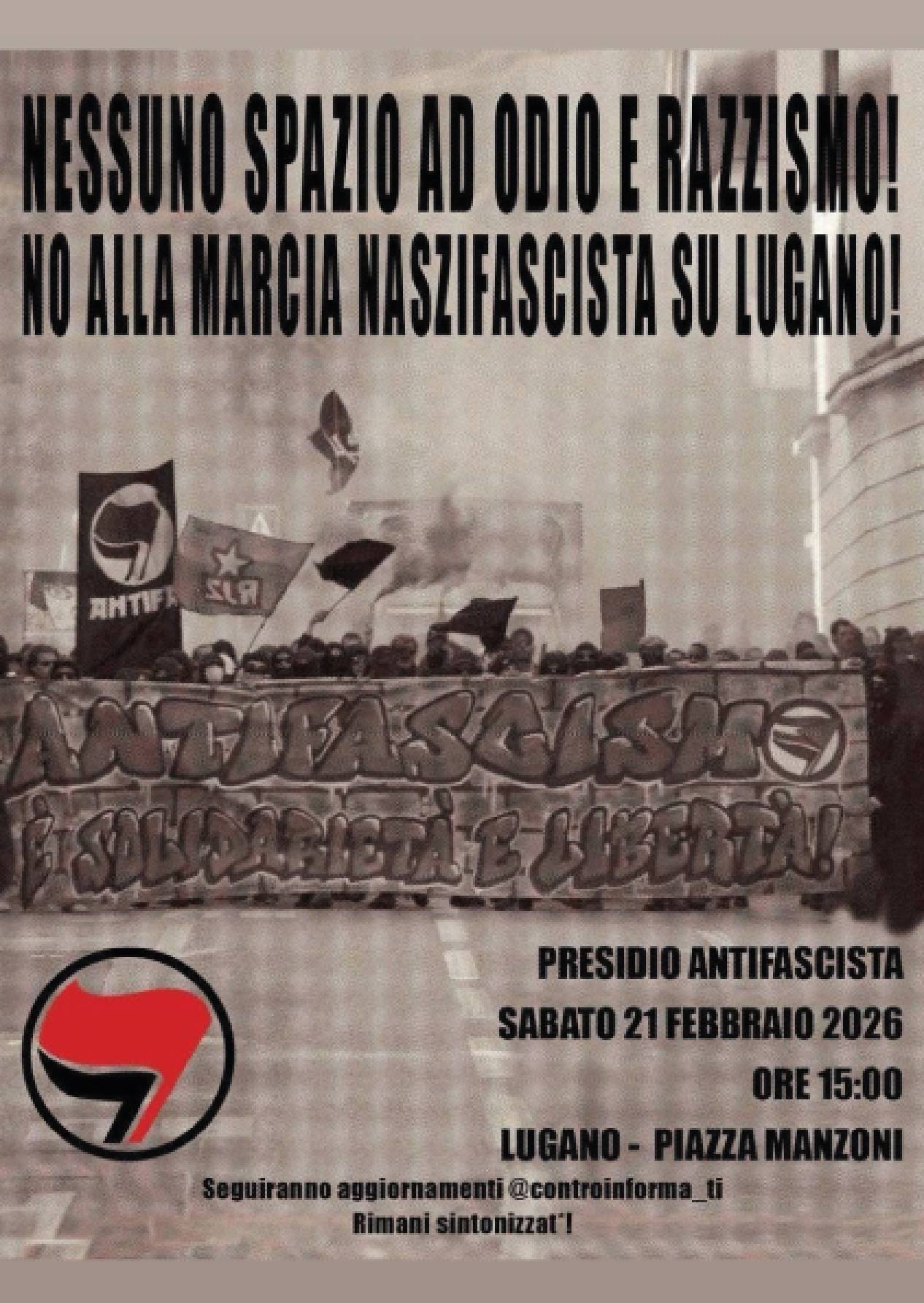«Ho tre figli, il più grande ha 17 anni, il più piccolo dieci. Ogni tanto mi fermo a pensare a quando li ho portati al mare l’ultima volta. Non c’è un’ultima volta perché non ce n’è stata mai una prima». Issam Abu Ziad usa il mare per spiegare cosa significa essere privati della libertà. Lo fanno tanti palestinesi chiusi in Cisgiordania: li stupisce ancora che un popolo nato lungo il Mediterraneo non possa bagnarcisi i piedi dentro.
Abu Ziad continua a parlare anche quando l’elettricità se ne va, i blackout sono sempre più frequenti. La luce si spegne nell’ufficio che ospita da quasi cento anni la Camera di Commercio di Nablus. Ci mostra una placca commemorativa, sopra è riprodotto il primo contratto di affitto dell’associazione di cui è a capo: aprile 1927.
Fuori Nablus finge una vita normale, ma non ci riesce. In città vecchia molti negozi hanno le saracinesche abbassate, il mercato che da secoli è recettore del fascio di nervi che corre tra la comunità e le campagne è poco affollato. Si scorge la paura negli sguardi sospettosi dei cittadini di Nablus: da quasi due anni agenti sotto copertura israeliani, i musta’ribeen, militari che si fingono arabi, entrano in città in pieno giorno, perquisiscono, arrestano, uccidono. Cercano i combattenti dei gruppi armati risorti in una comunità nota per la sua secolare resistenza all’occupazione coloniale israeliana. Accanto ai poster dei martiri della seconda Intifada, sui muri ne sono apparsi di nuovi, freschi. Tutti ragazzi.
Nablus è una città chiusa. L’esercito israeliano ha eretto nuovi checkpoint tutto intorno, non c’è modo di accedere senza passare da un posto di blocco. Ci si impiegano delle ore, ecco perché Nablus è semi vuota. Non è l’unica comunità a subire una simile escalation: dal 7 ottobre 2023 sono sorti nuovi checkpoint, e nuove barriere che hanno spezzettato la Cisgiordania in frammenti ancora più piccoli di quelli di prima. E poi c’è la violenza militare: poche ore dopo l’entrata in vigore della tregua a Gaza, il 19 gennaio scorso, Israele ha intensificato l’offensiva in West Bank, con l’operazione “Muro di ferro” contro le comunità a nord, Jenin, Tulkarem, Tubas che ha provocato già 40mila sfollati. Dal 7 ottobre 2023 sono quasi mille i palestinesi uccisi in Cisgiordania (di cui almeno 81 bambini), 7mila i feriti, oltre 14mila gli arrestati.
«La situazione è peggiorata dal 2021, il 7 ottobre l’ha solo aggravata – spiega Abu Ziad – Prima registravamo 120mila ingressi al giorno, lavoratori e commercianti dai villaggi vicini ma anche visitatori dalla Palestina ’48 (l’attuale stato di Israele, ndr). Nablus è famosa per i suoi negozi, i ristoranti, per la produzione artigianale, il sapone, la falegnameria, i dolci. Ora siamo fortunati se ne arrivano 20mila. E poi ci sono i lavoratori di Nablus che avevano un permesso per entrare in Israele: erano 35mila, il permesso non ce l’ha più nessuno».
Nablus si è impoverita. Alla crisi economica si uniscono le incursioni pressoché quotidiane dell’esercito. Dopo il tramonto non si esce di casa. «La città vecchia è cambiata, la gente non si fida più di nessuno», ci dice Sana’a Al Ataba. È una delle responsabili dello Women’s Studies Center. Lo ha co-fondato nel 1989. Esponente della sinistra palestinese, femminista, anni di studio passati in Unione Sovietica, ride quando racconta dei cinque shekel di dote che accettò dalla famiglia del fidanzato per sposarlo. Cinque shekel, un euro: il suo modo di sfidare la tradizione.
«La condizione delle donne peggiora con l’oppressione più di quella degli uomini. – spiega – Per le donne è spesso più difficile muoversi tra la campagna e la città, perdono il lavoro più facilmente, devono prendersi cura delle famiglie con i servizi in costante calo. Nei piccoli villaggi non ci sono cliniche e arrivare in città è spesso impossibile, senza mezzi e con le chiusure continue».
Ci si ferma prima di entrare a Nablus, per improvvisare mercati contadini a cielo aperto. Lungo la strada che conduce verso nord, al mattino i marciapiedi sono pieni di tavoli di plastica e baracchine che spariranno qualche ora dopo. C’è chi vende pomodori, cetrioli, erbe, chi cassette di uova e cubetti di formaggio di capra avvolti nella pellicola. Un signore prova a vendere un asinello.
A sud la situazione non è migliore. Hebron è da decenni una delle città simbolo della pervasività dell’occupazione coloniale. I coloni sono nel suo cuore, nella città vecchia, protetti da migliaia di soldati. E la città vecchia, anche questa cuore pulsante dell’economia locale, è un luogo fantasma. Dopo il 7 ottobre Hebron è stata posta sotto coprifuoco totale, «24 ore al giorno per i primi dieci giorni, poi ci hanno concesso di uscire un’ora al mattino e una alla sera». Hisham Sharabati è uno dei più noti attivisti della città e ricercatore per l’ong palestinese Al Haq.
«I soldati sono più nervosi e violenti del solito, aggrediscono i giovani, li arrestano. I pattugliamenti sono quotidiani. La zona della città vecchia sotto il controllo israeliano è off limits per chiunque non sia residente. Quest’anno non sono nemmeno riusciti a raccogliere le ulive nel quartiere di Tel Rumeida, eppure ce ne sono così tanti».
Sharabati prova a elencare i tanti volti che l’occupazione assume, le punizioni collettive, le chiusure, il divieto a spostarsi, gli arresti di massa. E le violenze dei coloni, del tutto sdoganate con l’entrata in carica – un anno prima dell’attacco di Hamas – del governo di ultradestra guidato ancora una volta dal premier Netanyahu. Un governo che opera ormai in simbiosi con il movimento dei coloni, presenti nei ministeri e ai vertici dell’esercito.
A sud di Hebron, nella zona di Masafer Yatta, le violenze hanno un obiettivo chiarissimo, «l’espulsione delle comunità palestinesi e l’assunzione del controllo delle loro terre – continua Sharabati – Israele vuole rendere ufficiale l’annessione di pezzi della Cisgiordania a Israele e lo sta facendo in parlamento: in prima lettura sono state approvate leggi che rivendicano la sovranità israeliana sulle terre da Hebron a Masafer Yatta, ponendole sotto il governatorato di Beer Sheva».
Come accade da 77 anni, in Palestina l’occupazione coloniale opera attraverso l’incontro tra violenza e burocrazia, forza militare e potere legislativo. Il governo attuale procede a tappe forzate, in attesa della benedizione ufficiale di Donald Trump. Lo fa in due modi: da una parte le confische record di terre (nel solo 2024 ha dichiarato terre di stato un numero di ettari in Cisgiordania più alto dei 25 anni precedenti messi insieme), l’ampliamento delle colonie esistenti, la creazione di nuovi insediamenti e la costruzione, rapidissima, di infrastrutture stradali che stanno isolando intere comunità palestinesi; dall’altra con la ridefinizione dei poteri, dal militare al civile.
Non è un elemento marginale: Tel Aviv sta via via trasferendo le competenze sulla Cisgiordania occupata dall’esercito ai ministeri. Significa cancellare del tutto la divisione tra territorio occupato e stato di Israele: i ministri gestiranno la West Bank come gestiscono Haifa o Ashkelon, con stesse norme, stesse previsioni di budget, stessi finanziamenti.
«Inizialmente l’idea era di trasferire l’autorità sulle colonie al ministero delle finanze, guidato da Bezalel Smotrich – ci spiega Ari Remez, coordinatore delle comunicazioni dell’associazione Adalah, il Legal Center for Arab Minority Rights in Israel – Poi hanno creato un dipartimento nel ministero della difesa. Adesso, dopo il voto negli Stati uniti, l’idea è smantellare l’autorità attuale, che è militare, e trasferire le competenze civili dell’esercito ai ministeri civili. Se i ministeri gestiscono direttamente le colonie, l’annessione è realtà».
L’annessione di fatto esiste già. Lo ha riconosciuto nel luglio scorso la Corte internazionale di Giustizia in una decisione storica che, definendo l’occupazione israeliana illegale, un’annessione de facto e un regime di apartheid, ne ha ordinato lo smantellamento entro un anno. Alla base di una tale decisione sta un dato innegabile: nei decenni Israele ha assunto misure dirette al controllo permanente del territorio palestinese.
«L’annessione non è iniziata con questo governo – continua Remez – Quello che c’è di nuovo è la cancellazione delle norme e degli enti che prima permettevano di distinguere tra territorio dello stato e territorio dei coloni. Di due reti normative ne resta una sola. Molto dipenderà da come si comporterà la nuova amministrazione Trump, che intende riprendere in mano gli Accordi di Abramo sulla base della nuova realtà sul terreno. Il governo israeliano aspettava da mesi il ritorno di Trump per finalizzare un piano lungo almeno trent’anni. Dalle elezioni statunitensi di novembre 2024, Smotrich ha per due volte, pubblicamente, rivendicato come obiettivo la sovranità israeliana su quella che chiamano Giudea e Samaria, ovvero la Cisgiordania».
Se negli ultimi 16 mesi ultradestra e coloni hanno fatto appello alla ricolonizzazione di Gaza attraverso la pulizia etnica dei palestinesi, la Striscia non è il vero obiettivo. Lo è la Cisgiordania. In entrambi le enclavi si procede con l’espulsione forzata dei palestinesi e la massimizzazione della popolazione occupata in spazi sempre più piccoli. È il manuale del colonialismo d’insediamento, controllare la terra e sostituire la popolazione indigena con quella desiderata.
In Cisgiordania l’intenzione dichiarata, e già in parte messa in pratica, è creare corridoi di terre tra il deserto del Naqab e Hebron a sud, tra la Galilea e l’area intorno Jenin a nord, tra Gerusalemme occupata e la Giordania al centro. «Se Tel Aviv riuscirà nel suo obiettivo, eliminare le differenze normative tra Israele e Cisgiordania, realizzerà un nuovo ’48: l’assunzione istituzionalizzata di controllo su nuove parti della Palestina storica – conclude Remez – Ci troviamo di fronte a un momento storico, tanto quanto fu il 1948: una ridefinizione della realtà e un’ideologia messianica a gestire il passaggio».
Chiara Cruciati
vice-direttrice de Il Manifesto