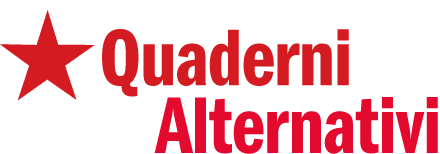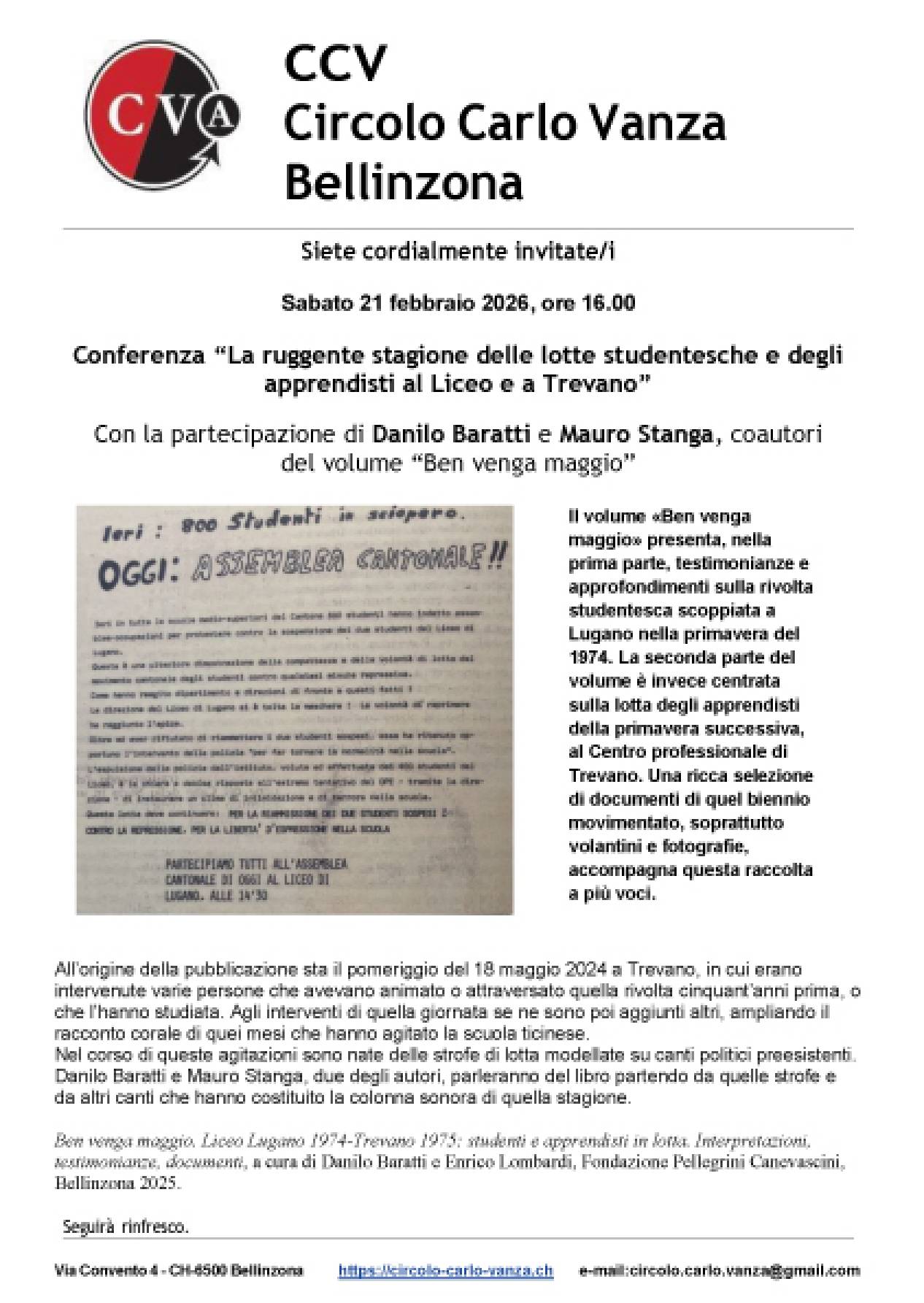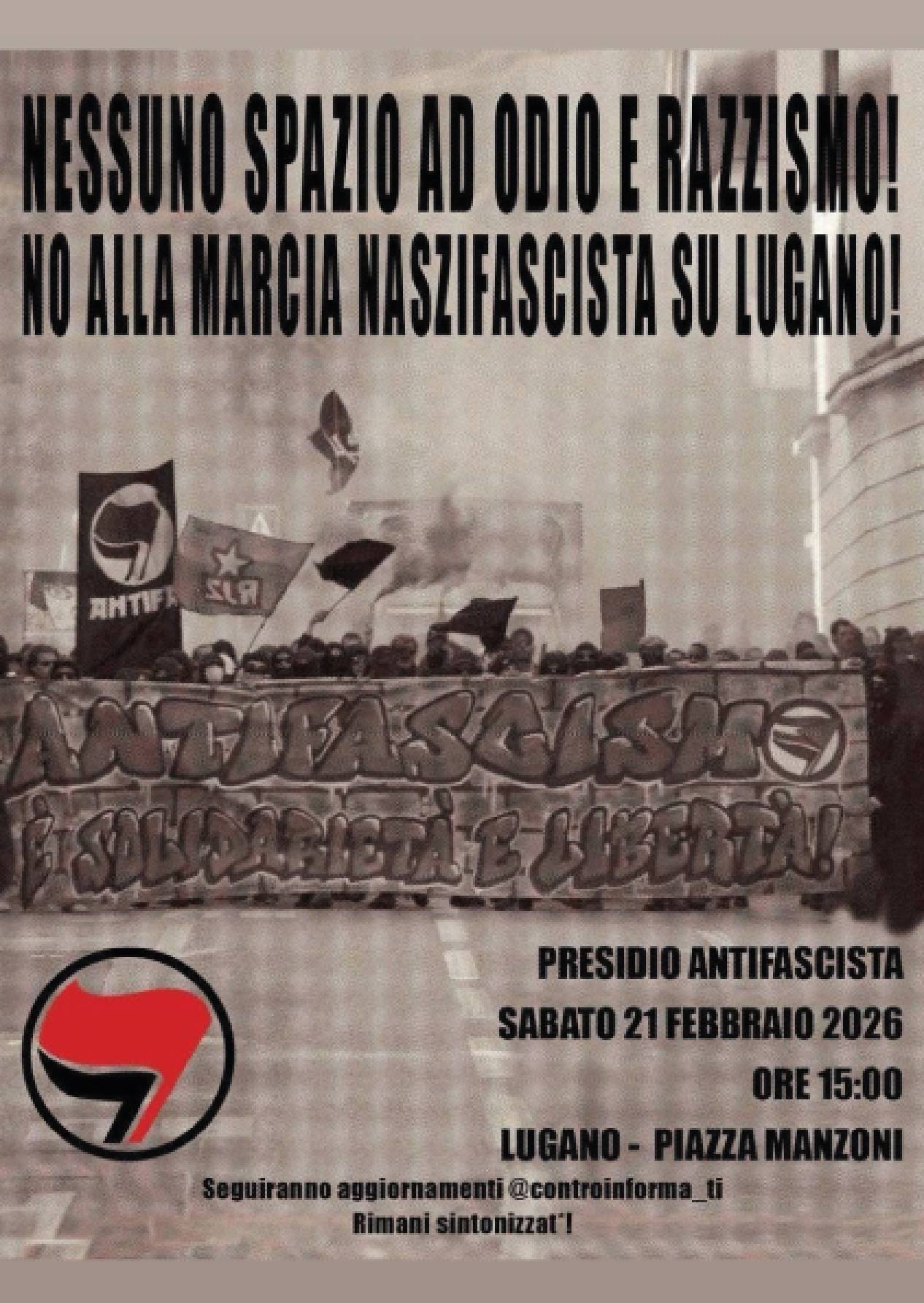La violenza contro le donne in contesti di conflitto assume molteplici forme, con minacce che provengono non solo dall’esterno, ma anche dall’ambito familiare. Lo stupro, storicamente utilizzato come arma di guerra per destabilizzare, terrorizzare e distruggere comunità durante i conflitti, è solo una delle atrocità a cui sono esposte le donne. Perché, in contesti poco stabili, non è raro che le donne (soprattutto le giovanissime) siano ancora più soggette a rapimenti, tratta e sfruttamento sessuale. In situazioni di guerra, dove i fattori di rischio si amplificano e le misure di prevenzione e protezione risultano assenti o inadeguate, si registra anche un aumento dei matrimoni forzati e della violenza domestica. Violenza ostetrica, misure sanitarie inadeguate o completamente assenti e stigma sociali si abbattono inoltre sulle donne come una mannaia, peggiorando contesti già difficili di per sé.
Le donne in guerra soffrono quindi due volte: come vittime di un conflitto che non risparmia nessuno e in ragione del loro sesso, in quanto sono spesso ridotte a trofei di conquista o bersagli di violenza di genere. Africa, Europa, America, Medio Oriente, Sudest asiatico: in nessun luogo al mondo una donna è in salvo quando si tratta di utilizzare il suo corpo come ulteriore metodo di rappresaglia, per umiliare, terrorizzare e annichilire.
Nel 1994, durante il genocidio in Ruanda, la violenza di genere, in particolare gli stupri, è stata usata come arma sistematica contro le donne. Le stime indicano che decine di migliaia di donne sono state vittime di violenze sessuali, spesso perpetrate con l’intento di umiliarle e distruggere il tessuto sociale del gruppo etnico perseguitato. Molte di queste violenze sono state pianificate e hanno coinvolto milizie, forze armate e civili, spesso incoraggiati da una propaganda mirata a disumanizzare le donne. Situazioni di “schiavitù sessuale”, dove le donne venivano tenute prigioniere e assoggettate ai voleri di uno o più miliziani durante tutta la durata del massacro, e anche oltre, erano all’ordine del giorno.
In Palestina, in quasi 80 anni di conflitto, le violenze sessuali e di genere nei confronti delle donne è una pratica usuale, divenuta una terribile “normalità” per coloro che vivono nei territori occupati. Basti pensare – circoscrivendo la temporalità al solo post 7 ottobre – che centinaia di donne palestinesi sono state arrestate in Israele, e nelle carceri hanno subito gravi violenze e abusi sessuali. Nel frattempo, si stima che oltre 50’000 donne a Gaza fossero incinte all’inizio della guerra: molte hanno subito aborti spontanei, mentre altre hanno dato alla luce bambini nati morti. L’assenza di un’assistenza sanitaria adeguata ha costretto spesso le donne a partorire in condizioni precarie o a subire cesarei senza anestesia. Le mestruazioni sono state utilizzate come metodo di pressione durante gli interrogatori, vietando l’utilizzo dei bagni alle donne fintanto che queste non avessero firmato una confessione. In Palestina è stato messo in atto un attacco sistematico contro le donne, al fine di annichilire la loro forza travolgente, vero motore della resistenza. Eppure, la comunità internazionale è rimasta indifferente di fronte a questi abusi, in quanto le donne palestinesi hanno un valore relativo, rispetto al mostro che queste sofferenze le ha provocate.
Negli anni ’70, durante le dittature militari in Argentina e Cile, la violenza contro le donne è stata una componente sistematica della repressione, utilizzata come strumento per infliggere terrore, punire e degradare. Durante il regime della giunta militare argentina, migliaia di donne, militanti e attiviste, sono state vittime di violenza sessuale nei centri clandestini di detenzione. Le donne incinte venivano tenute vive sino al momento del parto, per poi essere eliminate e diventare parte integrante della folta schiera dei cosiddetti “desaparecidos”, mentre i figli dati in adozione a famiglie legate al regime, per farli crescere in un ambiente ritenuto consono al proseguimento della dittatura. Uccidere il presente e cancellare il futuro di queste donne era una delle strategie di maggiore successo del regime: ancora oggi, molti di questi figli non sanno di essere stati brutalmente sottratti alle loro famiglie di origine e cresciuti dagli stessi assassini (se non proprio la mano armata, coloro che la mano l’hanno armata) dei loro genitori. La dittatura di Augusto Pinochet in Cile ha seguito uno schema simile: fra il 1973 e il 1990, molte compagne e militanti sono state vittime di violenze sessuali e torture all’interno dei centri di detenzione segreti. Abusi, stupri sistematici e di gruppo, elettroshock sui genitali, minacce e rappresaglie sono stati metodi con cui il regime ha umiliato una generazione di fiere donne combattenti. In entrambi i contesti, la violenza di genere non è stato un effetto collaterale, ma una strategia deliberata di repressione. Non ha solo cercato di annientare le vittime, ma mirava anche a distruggere il tessuto sociale, sfruttando il controllo sui corpi delle donne come mezzo per infliggere paura e dominio.
In Kurdistan, la violenza contro le donne da parte dell’ISIS è stata sistematica e brutale: durante la loro avanzata in Iraq e Siria, in particolare dal 2014, l’ISIS ha preso di mira specificamente le donne Yazidi e curde, sottoponendole a stupri, schiavitù, tratta per fini sessuali e altri abusi. In particolare, i miliziani dell’ISIS hanno colpito le donne curde a causa del loro ruolo nelle unità combattenti, come le miliziane dell’YPJ, in quanto erano considerate un affronto alla propria ideologia patriarcale. Queste violenze fanno parte di una strategia più ampia per annientare queste comunità, con l’intento di distruggere la loro identità culturale e di lotta.
Ma non si tratta solo di Palestina, Kurdistan, Ruanda, Argentina o Cile: in tutto il mondo, laddove emerga un conflitto, questo verrà combattuto in prima istanza sul corpo delle donne. Perché la violenza di genere nei contesti di guerra non è un mero fenomeno accidentale, ma una strategia deliberata utilizzata per esercitare potere, intimidire le comunità e perpetuare disuguaglianze sistemiche. I corpi delle donne diventano un campo di battaglia simbolico e concreto, dove si consumano crimini che raramente trovano adeguata giustizia. E se non si tratta di violenza diretta e brutale, si trovano altri modi per strumentalizzare le donne e il loro corpo, violentandole anche nell’animo. Come in Afghanistan, nel 2001, quando, per giustificare una guerra imperialista, si sono spesi in proclami sulla necessità impellente di emancipare le donne dai talebani. Oggi, dopo 20 anni, le donne afghane vivono nelle medesime, se non peggiori, condizioni, nell’abulia di un mondo occidentale che si è dimenticato di loro nel momento stesso in cui l’obiettivo di invasione è stato raggiunto.
La lotta contro questa forma di violenza richiede un impegno collettivo: dalla documentazione dei crimini e dal sostegno alle sopravvissute, alla creazione di meccanismi internazionali efficaci per perseguire i responsabili. Solo riconoscendo il ruolo centrale che il genere svolge nei conflitti e affrontandone le radici possiamo sperare in un futuro in cui la guerra non sia più sinonimo di sofferenza e oppressione per le donne.