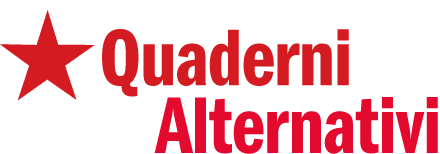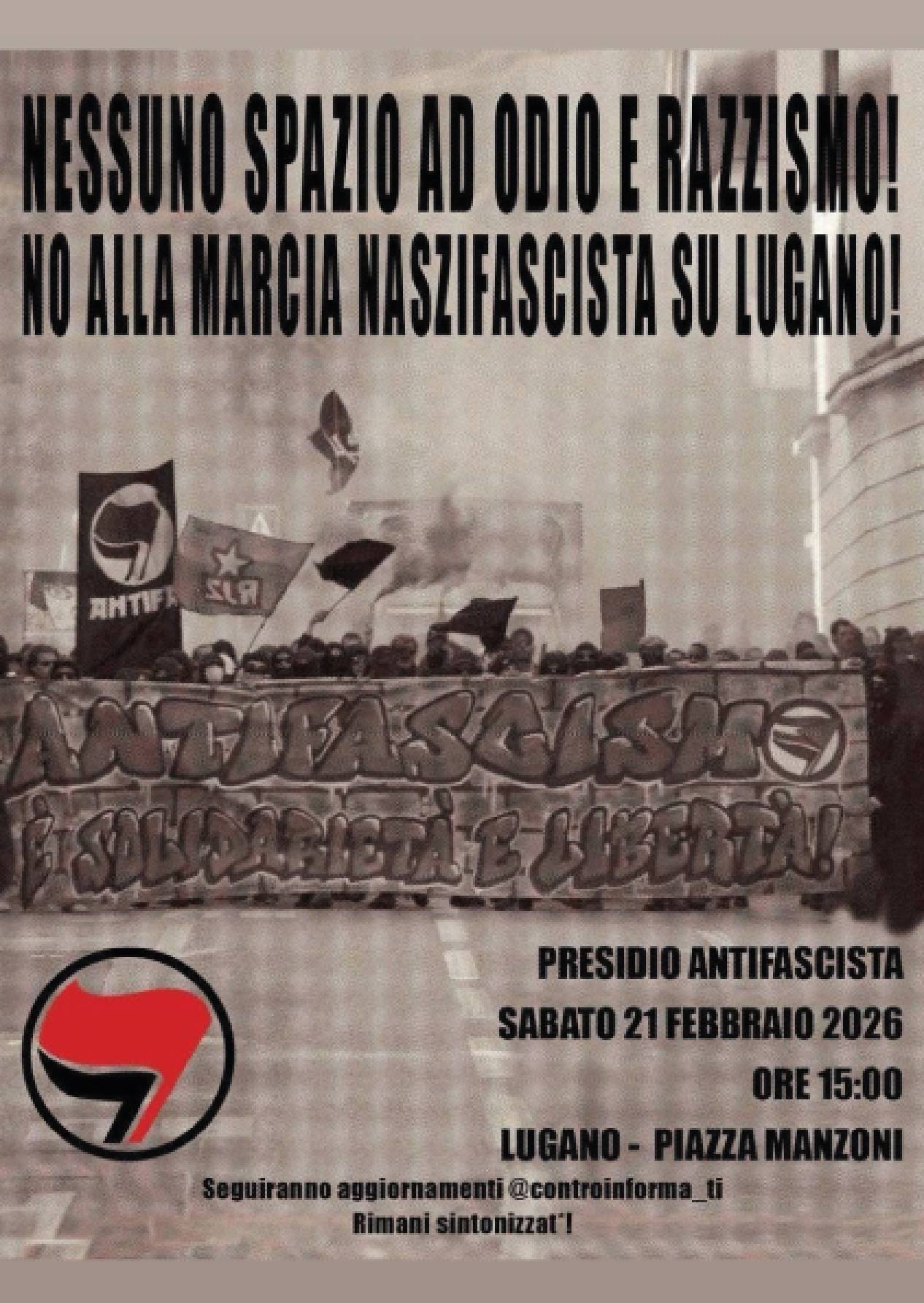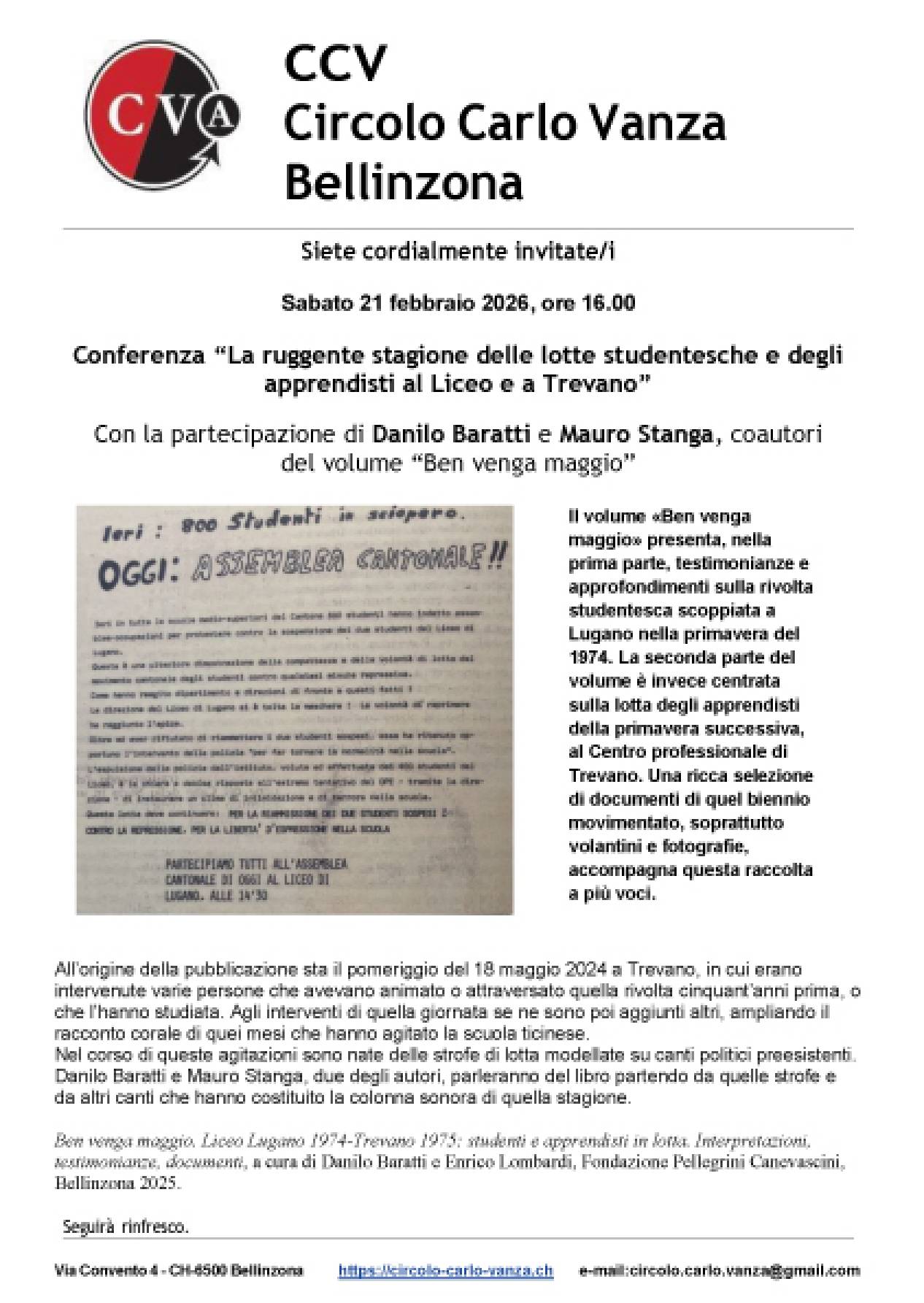Il primo marzo scorso il comunicato partito dalle montagne di Qandil ha risuonato in tutto il Kurdistan in pochi minuti. Dal rifugio inespugnabile sui monti del nord iracheno di cui il Partito dei Lavoratori del Kurdistan ha fatto il proprio quartier generale militare e politico dopo il ritiro dal territorio turco, oltre un decennio fa, il Pkk ha fatto eco al messaggio storico che il suo fondatore e presidente, Abdullah Ocalan, aveva affidato a una lettera pochi giorni prima, il 27 febbraio 2025. «Disarmiamo e sciogliamo il Pkk», ha scritto Ocalan. «Cessate il fuoco unilaterale», ha risposto il movimento.
Il passaggio storico di una lotta di liberazione lunga quasi cinquant’anni è giunto dopo mesi da un’altra apertura, anche quella a suo modo storica: Devlet Bahceli, leader del movimento ultranazionalista turco Mhp, partner di governo dell’Akp del presidente Erdogan, lo scorso ottobre aveva avviato una nuova inattesa fase del processo di pace tra Turchia e Pkk, invitando Ocalan a presentarsi in parlamento per porre fine alla lotta armata e a impegnarsi nel dialogo politico con Ankara.
A quelle dichiarazioni erano seguite tre visite all’isola-carcere di Imrali (dove Ocalan è detenuto da 26 anni) di una delegazione del partito Dem, la sinistra turca-curda erede dell’Hdp, vittima di una durissima campagna politica che ne ha decimato i vertici e svuotato le casse. Lì il Dem ha incontrato Ocalan, dopo anni di totale isolamento e preoccupante silenzio. Al partito Ocalan ha affidato il suo messaggio: «Convocate il vostro congresso e prendete una decisione; tutti i gruppi devono deporre le armi e il Pkk deve sciogliersi».
Alla soglia dei 76 anni ha così dato seguito a un percorso politico rivoluzionario, lo stesso che lo condusse nel 1984, a sei anni dalla sua nascita, a prendere le armi e che alla fine degli anni Novanta intravide nell’abbandono del nazionalismo l’indispensabile strumento di reale pacificazione democratica: da movimento nazionalista e socialista che sognava uno stato, il Pkk si è fatto fautore di un modello nuovo, il confederalismo democratico, rinunciando all’idea fallace dello stato-nazione come strumento di autodeterminazione. Un modello che si è fatto pratica nel campo profughi di Makhmour, in Iraq, embrione della democrazia diretta che esploderà dopo il 2011 in Rojava, il Kurdistan in Siria.
Il messaggio di Ocalan – seguito con apprensione, in diretta tv, da milioni di persone, con maxi schermi nelle grandi città curde disseminate in Medio Oriente, ad Amed, Van, Qamishlo, fino alla diaspora di Berlino – era rivolto a due interlocutori: il governo turco e il proprio partito. Al primo Ocalan ha passato la palla: ora siete voi a dover agire con riforme strutturali che riconoscano ai curdi pieni diritti e all’intera popolazione un’architettura istituzionale realmente democratica. Al secondo, un movimento che ha fatto della lotta armata uno dei mezzi di avanzamento pratico della propria teorizzazione politica, ha chiesto di evolversi ancora.
Il Pkk ha risposto a stretto giro, dicendosi pronto ad abbassare le armi e a convocare un congresso per discutere del proprio scioglimento. A patto, ha scritto il partito nel comunicato del primo marzo, che a guidare la nuova fase sia lo stesso Ocalan, da uomo libero. Palla di nuovo nel campo turco. Da Ankara sono giunte dichiarazioni, nessuna misura concreta. Il terreno è accidentato e sul processo di pace pesano i commissariamenti dei comuni curdi e gli arresti di massa che da anni, e con nuovo vigore negli ultimi mesi, hanno portato dietro le sbarre turche intellettuali, giornalisti, attivisti politici, co-sindaci, amministratori locali. Vero è che a partire dal messaggio di Ocalan la repressione pare attenuata.
Se è ancora difficile capire quali risultati concreti potrà ottenere il processo di pace in Turchia, ancora più controverso è il suo risvolto siriano. È evidente a tutti, analisti e forze politiche coinvolte, che quanto sta avvenendo tra Imrali e Ankara abbia effetti regionali ben al di là delle frontiere del paese nato dalle ceneri dell’impero ottomano. Sia perché i curdi sono trenta milioni, il più grande popolo senza Stato, sia perché si trovano divisi tra Turchia, Siria, Iraq e Iran. Quattro attori chiave per gli equilibri del Medio Oriente.
In Rojava, che in lingua kurmanjii significa «occidente», i curdi hanno dato corpo alla svolta teorica che Ocalan ha proposto dal carcere: dalla lotta per lo Stato nazione a quella per il confederalismo democratico. Ovvero una forma di organizzazione sociale basata su un’idea di democrazia radicale e inclusiva, che parte dalle assemblee di quartiere e coinvolge in maniera paritaria i diversi popoli, rifiutando separazioni etniche o religiose.
Iniziata nel 2012 mentre la rivolta contro il regime di Bashar al-Assad era diventata guerra civile, la rivoluzione confederale si è estesa a tutta la regione del nord-est siriano attraverso la resistenza contro lo Stato islamico. Intorno alle unità di autodifesa curde, le Ypg degli uomini e le Ypj delle donne, sono state create le Syrian democratic forces (Sdf), l’esercito che ha liberato e protetto la regione autonoma. Qui sono state scritte due costituzioni avanzatissime in termini di diritti politici, sociali e delle minoranze e l’autogoverno si è dato il nome di Daanes (Democratic Autonomous Administration of North and East Syria).
Da una base militare situata in questo territorio, appena due ore dopo la lettura del messaggio di Ocalan il comandante generale delle Sdf Mazloum Abdi, curdo alla guida di un esercito che è ormai a maggioranza araba, ha preso parte a una conferenza stampa in cui le domande dei giornalisti non potevano che concentrarsi sulla lettera di Apo.
Abdi ne ha dato una valutazione positiva: un’«occasione storica» per far avanzare la democrazia e la pace. Ha anche chiarito che l’appello a deporre le armi e sciogliersi non era rivolto alle Sdf ma solo al Pkk. Ad Ankara, però, sostengono che le Ypg/Ypj siano il braccio siriano della formazione politica fondata da Ocalan. Così meno di 24 ore dopo Omer Celik, portavoce del partito di Erdogan, ha alzato la posta: «Tutti gli elementi di gruppi terroristici in Iraq e Siria devono deporre le armi e sciogliersi. L’espressione “gruppo terroristico” riguarda anche le Ypg».
In Siria la Turchia, oltre al nuovo governo di Al Jolani, sostiene il coacervo di milizie islamiste riunite nel Syrian national Army (Sna) che dopo il cambio di regime a Damasco hanno sferrato un’offensiva a ovest della regione autonoma, provando a superare l’Eufrate e accerchiare Kobane. «Siamo curdi, ci considerano infedeli. Non accettano come viviamo, come ci vestiamo. O che io non mi copra il capo. Se prendono Kobane uccideranno me, mio marito e tutti i nostri figli», afferma Karo, una donna che incontriamo nell’ospedale di Raqqa. È insieme al marito e quattro bambini, il più grande ha una scheggia in testa. La bomba caduta dall’alto lo ha ferito sulla diga di Tishreen, che i civili stanno difendendo dagli attacchi aerei turchi presidiandola con i propri corpi. «La gente ha ribattezzato Tishreen diga della resistenza», dice Rojhelat Afrin, la comandante delle Ypj.
Per la Daanes la sfida principale resta la difficile integrazione nelle istituzioni statali della nuova Siria guidata dagli islamisti di Hay’at Tahrir al-Sham (Hts) agli ordini di Al Jolani. I paesi occidentali ne hanno rapidamente dimenticato il passato con Al Qaeda e l’estremismo religioso imposto nella regione di Idlib. Troppo grande è il loro interesse a riaprire le relazioni diplomatiche, dichiarare il paese sicuro e rimandarci quanti più rifugiati possibile. L’evoluzione in senso moderato del leader, però, resta tutta da verificare. A inizio marzo in risposta a un attacco militare nella regione costiera del paese, dove ci sono le città di Latakia e Tartus, da parte di ribelli legati al vecchio regime bathista è partito un massacro di vasta portata contro la minoranza alawita, cui apparteneva Assad. Sono stati ammazzati centinaia di civili. Alcune stime parlano di quasi duemila persone sebbene al momento non sia possibile confermare tali numeri.
Il ruolo di Hts resta da chiarire: secondo alcuni ha una responsabilità diretta nei massacri, secondo altri non è stato in grado di vigilare sulle sue componenti più estreme. Nei due giorni successivi, comunque, ha firmato accordi con la minoranza drusa e con le autorità del nord-est. Abdi e Jolani si sono stretti la mano davanti a un testo in otto punti che tra le altre cose prevede la rappresentanza politica per tutti i siriani, il riconoscimento della comunità curda e l’integrazione delle Sdf nelle istituzioni di sicurezza dello Stato siriano. Un punto, quest’ultimo, molto controverso e che andrà chiarito nella pratica. Damasco voleva un dissolvimento nell’esercito nazionale, le autorità del nord-est una partecipazione alle forze armate centrali con un comando autonomo su base regionale.
Che l’intesa sia stata raggiunta a pochi giorni dal messaggio di Ocalan non sembra casuale, visto che Ankara è il principale sponsor di Al Jolani. Bisognerà attendere per vedere i risvolti concreti e per capire quali pieghe prenderanno quelle decisioni. Basti pensare che tra i punti dell’accordo c’è quello sul cessate il fuoco in tutto il territorio nazionale. Il giorno dopo la firma, però, gli attacchi alla diga di Tishreen e al vicino ponte di Qarakozaq da parte delle milizie sostenute dalla Turchia sono andati avanti come se nulla fosse. Hanno anzi ripreso vigore.
La popolazione conosce bene l’importanza di quella diga, indispensabile infrastruttura civile e – suo malgrado – bastione militare: se cade Tishreen, cade Kobane. È anche per questo che il 26 gennaio 2025, in piazza Egit, migliaia e migliaia di persone si sono ritrovate a commemorare una vittoria epocale e a impegnarsi in una lotta che non è mai finita: a dieci anni dalla liberazione della città simbolo della battaglia all’Isis, la città da cui la rivoluzione ha contagiato l’intero nord-est siriano, una marea umana di donne, uomini, anziani, bambini, di divise militari e di abiti tradizionali, grida con una voce sola con le braccia rivolte al cielo: «Viva le Sdf, viva le Ypg, lunga vita a Kobane, lunga vita a Tishreen».
Chiara Cruciati e Giansandro Merli,
giornalisti de Il Manifesto