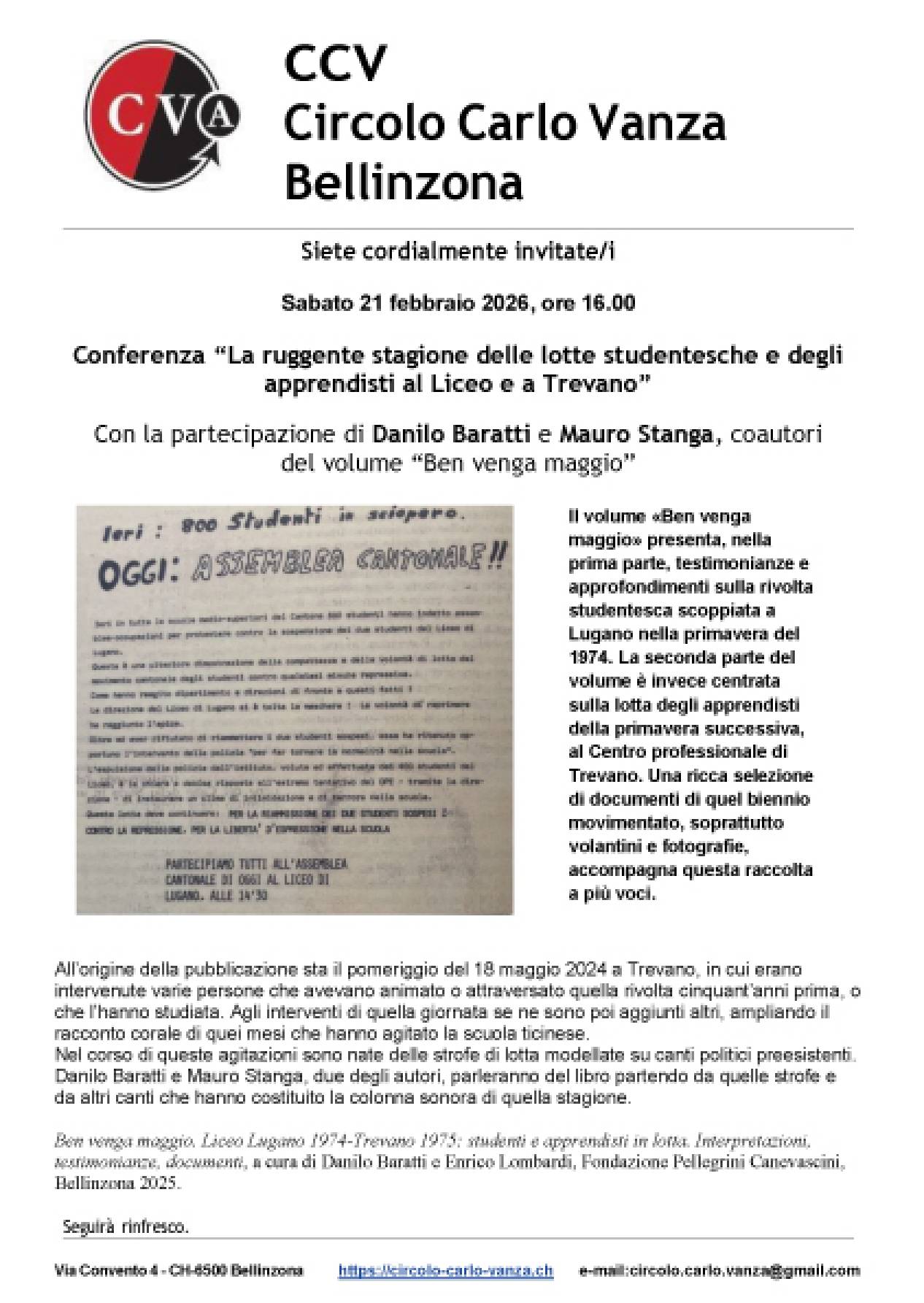Trump sta sconvolgendo il mondo con la sua guerra commerciale, che come ha scritto Piketty è l’espressione della crisi generale del dominio economico statunitense. Da lontano si ha quasi l’impressione che la Cina la stia prendendo con tanta tranquillità, contrariamente a tanti altri paesi. È anche la vostra impressione?
Al momento, la Cina si sente forte, più forte di quanto non si sentisse all’inizio di questa nuova guerra commerciale. A differenza dell’Unione Europea e della stragrande maggioranza degli altri Paesi, non ha avuto un approccio negoziale votato alla concessione, ma anzi ha adottato una linea dura con ritorsioni multiformi, sia tariffarie sia di altro genere. La prima tregua sui dazi siglata a maggio è arrivata senza mai mostrarsi deboli e senza nemmeno bisogno che entrasse in campo Xi Jinping, che si è concesso a una telefonata con Trump solo a giugno. Soprattutto, Pechino è convinta di aver trovato un’arma negoziale formidabile: le terre rare. Alleggerendo la stretta sulle spedizioni di questi materiali – cruciali per elettronica, tecnologia verde e difesa – ha ottenuto non solo il congelamento dei dazi, ma anche la rimozione di una serie di divieti all’export di software tecnologico. Certo, passare dall’armistizio a una vera pace sarà piuttosto complicato e i temi divisivi restano di difficile soluzione. Ma la Cina, almeno in questo momento, è convinta che mostrarsi forte e pronta a combattere abbia pagato.
Una delle armi che gli USA stanno usando, per bloccare l’avanzata tecnologica (soprattutto nel campo dell’Intelligenza Artificiale) della Cina, è quella dei microchip. A che punto è la Cina con il suo sviluppo indipendente? È ancora una vera arma nelle mani degli USA?
La Cina sta dimostrando di aver ridotto il divario. Da una parte, continua a fare leva sui rapporti con i colossi globali del settore. A partire dalla stessa Nvidia, che ha spinto per mesi per riottenere il via libera di vendita del suo chip H20 per l’intelligenza artificiale sul mercato cinese. Dall’altra, sta insistendo sul rafforzamento della produzione interna, soprattutto sul terreno meno glamour (ma geopoliticamente più accessibile) dei semiconduttori a nodo maturo. È in questa zona grigia dell’innovazione, dove i chip da 28, 45 o 65 nanometri regnano ancora sovrani per automobili, elettrodomestici, apparati militari e telecomunicazioni, che Pechino ha messo in piedi grandi investimenti in un modello ibrido che si fonda su una fitta rete di attori privati coordinati, incentivati e in alcuni casi guidati direttamente dallo Stato centrale o dai governi provinciali. Anche a questo è servita la campagna di rettificazione delle Big Tech degli scorsi anni, il cui scopo non era stroncare i colossi privati, quanto riorientarne l’azione su settori strategici come i chip. Certo, raggiungere l’agognata “autosufficienza tecnologica” resta complicato, ma la Cina sta dimostrando di voler ridurre l’esposizione a sanzioni o esclusioni dalle catene di approvvigionamento più avanzate.
Dopo momenti di debolezza negli ultimi anni (vedi crisi edilizia in particolare) si ha l’impressione che l’economia cinese abbia ripreso a crescere regolarmente. Quali sono le criticità che voi vedete in particolare?
Il problema che preoccupa maggiormente il Partito comunista cinese sono i consumi. Pechino sa che per resistere a una guerra commerciale di lungo periodo (o comunque a rendere più sicuro e impermeabile il suo sviluppo) ha bisogno di un mercato interno più forte, obiettivo lontano dal realizzarsi. Per provare a stimolare la spesa, il governo ha da poco lanciato un piano speciale sui consumi. Tra le misure, sussidi per le coppie per contrastare il calo demografico e una serie di misure per rafforzare il sostegno al credito, allentando le regole per i prestiti forniti dalle banche. Via poi a un ampio pacchetto di obbligazioni speciali per stabilizzare il settore immobiliare e sostenere la cosiddetta „politica vecchio per nuovo“, con sussidi elargiti per acquistare prodotti digitali o veicoli elettrici dei marchi nazionali. La crescita è ancora molto legata alle esportazioni, dunque alla „circolazione esterna“. Xi vorrebbe ribaltare l’assioma. Lo sta facendo gradualmente, ma le contingenze potrebbero imporre un intervento più deciso e politiche più proattive già nel breve termine.
Come commentato da Lorenzo (vedi RSI Informazione), oltre tre quarti degli investimenti mondiali nel settore delle energie rinnovabili avviene attualmente in Cina. Il paese raggiungerà gli obiettivi degli accordi di Parigi probabilmente prima delle scadenze previste. Contemporaneamente però la Cina investe ancora sempre nel carbone. Perché questa contraddizione?
Ci sono varie ragioni. La prima, più macro, è che il processo di industrializzazione è iniziato dopo quello dei Paesi occidentali e dunque rivendica il diritto di seguire i suoi tempi per una completa decarbonizzazione. La seconda, più contingente, è la preoccupazione sull’approvvigionamento creata dall’intreccio tra la grave crisi energetica del 2021 e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Risultato: l’espansione da record di eolico e solare non sta per ora soppiantando il carbone, ma si sta aggiungendo o sovrapponendo ai tradizionali combustibili fossili, su cui per una fase a cavallo della pandemia di Covid-19 si stava iniziando a intervenire in modo più drastico e immediato. Per quanto riguarda gli obiettivi sulle emissioni, la Cina non ha operato tanto una retromarcia, quanto uno stop-and-go che dovrebbe far toccare a breve il picco per poi scendere progressivamente. La priorità resta sempre la sicurezza energetica, che in futuro Pechino spera assomigli (anche qui) a un’autosufficienza.
Uno degli obiettivi della Cina, ma in generale di diversi paesi dei BRICS, è quello di usare sempre meno il dollaro quale moneta per gli scambi internazionali. L’impressione è però che i progressi in quest’ambito strategico siano molto lenti o addirittura inesistenti. Come giudicate la situazione?
I dazi potrebbero dare un nuovo impulso all’internazionalizzazione della moneta cinese. Già negli scorsi mesi, i pagamenti transfrontalieri in yuan sono cresciuti in maniera piuttosto decisa. Ad aprile, la Banca centrale ha annunciato un piano per l’internazionalizzazione dello yuan e del sistema di pagamento CIPS, su cui punta per smarcarsi dallo SWIFT. Obiettivo: promuovere l’utilizzo della sua moneta negli scambi coi Paesi partner e schermarsi dalle sanzioni. Non un tentativo di sostituzione “tout court”, quanto di erosione del dominio del dollaro per realizzare una sorta di duopolio in cui gli Usa avrebbero meno armi per colpire lo sviluppo cinese. Si tratta però di una proiezione funzionante soprattutto a livello bilaterale, più che multilaterale. Per intenderci: non è all’orizzonte una moneta comune dei BRICS, una piattaforma ancora ampiamente disarticolata e che anzi con il recente progressivo allargamento rischia di diventare anche parzialmente “ingovernabile”.
Dandola in parte vinta a Putin in Ucraina, Trump, oltre a risparmiare, probabilmente voleva rompere l’alleanza tra Russia e Cina. Quest’ultima si dimostra più solida del previsto, ciò che spiega forse gli scatti d’ira di Donald contro Putin?
Non so se davvero Trump pensasse di avvicinare Putin riuscendo a separarlo da Xi, ma a Pechino in pochi hanno temuto davvero questo scenario, quasi sempre relegato a una fantasia. Al di là della contingenza trumpiana, la Cina è convinta che la Russia sia cosciente dell’importanza della stabilità dei rapporti bilaterali, soprattutto a fronte di un’Europa sempre più lontana da Mosca e degli Stati Uniti che non sono in grado di garantire la tenuta di un ipotetico disgelo. In questi mesi, Pechino e Mosca hanno riaffermato la solidità dei propri rapporti. Xi è andato in Russia per la Giornata della Vittoria, Putin arriva a Pechino per l’80esimo anniversario della vittoria contro il Giappone. Certo, nonostante gli slogan (peraltro accantonati da tempo) l’amicizia tra i due Paesi ha dei limiti e sottotraccia si testano le rispettive aree di “influenza” come Asia centrale e penisola coreana. Ma per Xi la priorità resta la stabilità di Putin, considerato il garante della stabilità nei rapporti tra Cina e Russia. E, per Putin, Xi resta l’amico più importante da mettere alla bisogna in mostra.
Quali segnali arrivano sui rapporti tra Stati Uniti e Cina sui dossier non economici e legati alla sicurezza?
Siamo in una fase di attesa. Va però sottolineato che l’approccio di Trump è stato diversissimo rispetto a quello adottato all’inizio del suo primo mandato. Si prenda Taiwan, la questione più delicata. Nel 2016, subito dopo aver vinto le elezioni, ebbe una conversazione telefonica con l’allora presidente taiwanese Tsai Ing-wen: il primo colloquio ufficiale ai massimi vertici di Washington e Taipei dal 1979. Un episodio che ha innescato una serie di conseguenze ancora visibili sullo status quo tra le due sponde dello Stretto. Stavolta, ha negato un transito a New York all’attuale presidente taiwanese Lai Ching-te, che Pechino ritiene un “secessionista”. Il tutto mentre il Pentagono ha cancellato un summit sulla difesa con Taipei. Segnali inediti, che potrebbero lasciare intendere che Trump è disposto a negoziare anche su temi sin qui mai considerati trattabili. Resta comunque in agenda un aumento delle vendite di armi all’isola e le tensioni potrebbero tornare a crescere dopo il probabile summit autunnale fra Trump e Xi, un potenziale spartiacque dell’approccio americano (in un senso o nell’altro) ai temi più sensibili e strategici. Alla Cina comunque non dispiace l’incertezza venutasi a creare in questi mesi sulla stabilità delle alleanze degli Usa in Asia orientale, a partire da quella col Giappone.