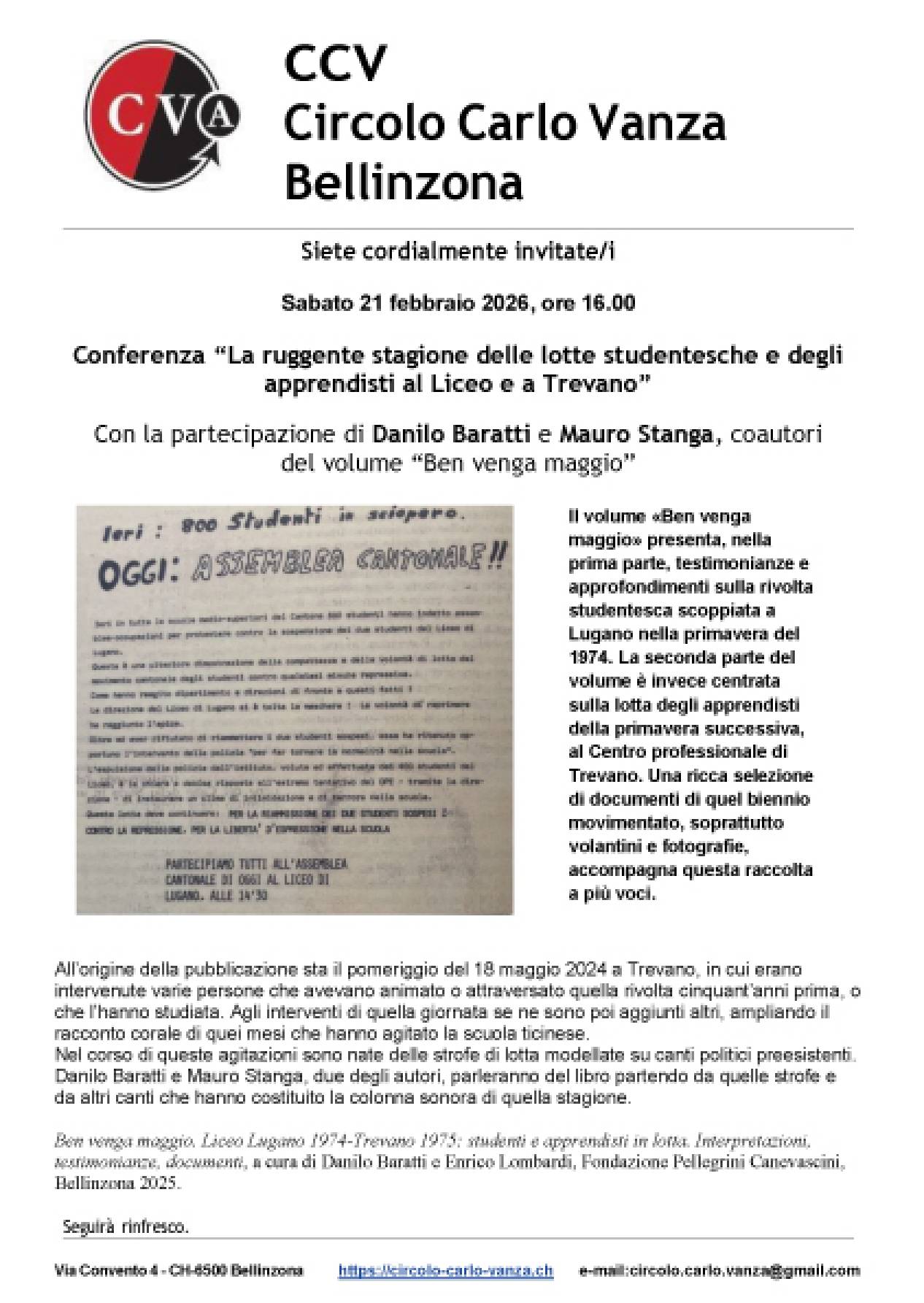Trentuno anni e tre mesi di prigionia prima di ritrovare la libertà: il 25 luglio scorso Veysi Aktas è ritornato nella sua città, Amed (Diyarbakir), nel sud-est turco a maggioranza curdo, accolto da una folla in festa. Era stato condannato a trent’anni nel 1994 con l’accusa di aver minacciato l’unità dello stato, uno dei “reati” più utilizzati dalla macchina repressiva turca per far sparire in una cella i propri avversari politici, veri e presunti.
In carcere, nell’isola-prigione di Imrali nel mar di Marmara, ha lasciato tanti compagni: Mehmet Sait Yildirim, Omer Hayri Konar, Cetin Arkas e Nasrullah Kuran. E il più noto di tutti: Abdullah Ocalan. Lo si vede, Aktas, seduto accanto al fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) nel video con cui i primi di luglio – per la prima volta dal suo arresto nel 1999 – il popolo ha potuto ascoltare la voce del leader.
Ad Amed, alla folla in festa, Aktas ha portato un altro messaggio di Ocalan: «Tramuteremo Imrali in un’isola di pace». Il rilascio di un prigioniero di lungo corso (che ha scontato quindici mesi in più del previsto) è apparso come uno dei flebili segnali di distensione che il governo turco ha lanciato in questi mesi di rinnovato processo di pace. Scarsi e deboli: di prigionieri politici ne sono stati liberati una manciata, casi isolati e sporadici, nessuna amnistia di massa.
Tra loro non c’è Mehmet Deniz Guzel, in carcere da 33 anni. Come Aktas, anche il suo rilascio è stato rinviato numerose volte, senza motivazione giuridica: detenzione prolungata di tre mesi in tre mesi.
Non è l’unico, sono decine i prigionieri curdi che hanno scontato la propria sentenza e restano dietro le sbarre, nonostante da mesi il parlamento e il governo turchi stiano discutendo di una riforma giudiziaria che dovrebbe permettere il rilascio di decine di migliaia di detenuti. Donne, malati, persone condannate a meno di cinque anni sarebbero i primi della lista di quella che Ankara tiene a precisare non è «un’amnistia». Da parte sua, il partito di sinistra Dem – il negoziatore tra Stato e PKK – insiste per la liberazione dei circa 10mila prigionieri politici nelle carceri disseminate in tutto il paese.
Quella dei detenuti curdi è una delle questioni-cuore del processo di pace tra Stato e PKK ripreso, un po’ a sorpresa, nell’ottobre 2024 dalle dichiarazioni del leader politico meno probabile, il capo del partito ultranazionalista Mhp, Devlet Bahceli, parte della coalizione di governo, braccio destro del presidente Erdogan e tra i più acerrimi nemici del diritto all’autodeterminazione del popolo curdo. Eppure è stato lui – su chiamata dello stesso Erdogan– ad aprire una fase inattesa con l’invito pubblico ad Abdullah Ocalan a tenere un discorso nella Grande Assemblea della repubblica di Turchia.
Da quell’appello è nata una valanga: alla delegazione messa in piedi dal Dem Party è stato consentito di visitare Ocalan più volte nella prigione di Imrali, fino alla fine di febbraio di quest’anno quando dall’isola i deputati sono usciti con un messaggio scritto del fondatore del PKK. Un terremoto: «Convocate il vostro congresso e prendete una decisione; tutti i gruppi devono deporre le armi e il PKK deve sciogliersi». E la valanga si è ingrossata.
A metà maggio il PKK ha tenuto il XII Congresso e ha confermato la decisione di Ocalan: pronti a sciogliere il partito e ad abbandonare la lotta armata, consci di aver raggiunto la propria missione storica. L’11 luglio quella decisione si è fatta azione, per quanto simbolica: trenta combattenti, uomini e donne, sono scesi dalle montagne irachene di Suleiyamaniya, guidati da Bese Hosak, la co-presidente del Kck (Unione delle Comunità del Kurdistan), la più alta in grado accanto allo storico leader Cemil Bayik e una delle principali artefici della svolta femminista del movimento.
Di fronte a centinaia di osservatori internazionali, ong, movimenti femministi, alle madri dei combattenti uccisi o scomparsi e soprattutto di fronte al nemico numero uno – i servizi segreti del Mit turco – hanno poggiato i kalashnikov in una grande vasca di alluminio e con una torcia li hanno dati alle fiamme. Il fumo nero che si è alzato, denso, dalla pira ha catturato e trascinato con sé il dolore e la tenacia di decine di milioni di persone, i sacrifici che un popolo intero – diviso e colonizzato – ha sopportato e sopporta per la propria libertà: famiglie smembrate, vite consegnate al movimento, carcere, sangue, oppressione. Li hanno raccontati le lacrime che scorrevano sulle guance delle madri e su quelle di attiviste storiche come Leyla Zana, in prima fila alla cerimonia, sulle spalle dieci anni di galera e il coraggio di aver pronunciato per la prima volta nella storia un discorso in curdo tra gli scanni del parlamento di Turchia.
Un fuoco di fine di un’era, di rinascita e di vita nuova, come insegna la tradizione curda e la sua resistenza, ma anche fiamme di “avvertimento”: quel rogo non è il primo di una lunga serie di consegna e distruzione delle armi, è un gesto minimo di buona volontà. La palla è ora nel campo turco. Un percorso, o la sua idea, esiste e passa per la formazione di una commissione parlamentare chiamata
a risolvere democraticamente la questione curda: disarmo, libertà per i prigionieri politici, amnistia per i combattenti ancora in montagna perché tornino a una vita piena e libera (diversa, forse, la situazione dei leader più alti in grado per cui si ipotizza l’esilio) e soprattutto riforme istituzionali, legali e sociali che avvino la Turchia intera sulla via della democratizzazione interna e che riconoscano alla comunità curda diritti pieni ed eguali.
Una forma la commissione ce l’ha già (60 deputati rappresentativi dei diversi partiti presenti in parlamento sulla base del peso elettorale) ma di dettagli sulle procedure non ne esistono ancora. Tanto meno esistono obiettivi chiari: la coalizione di governo sogna una commissione “spuntata”, che si occupi supervisionare il disarmo e poco più. Il PKK – e più in generale la comunità curda – vede nel disarmo il risultato di un processo di democratizzazione, così come le armi erano state il risultato dell’ingiustizia e non la sua causa: chiede un riconoscimento dell’identità curda, della sua cultura, della sua storia e della sua geografia, su un piano etico, morale, politico e sociale. Ovvero la piena partecipazione alla vita del paese, a partire dalla gestione delle municipalità del sud-est, il ritorno alla topografia curda, alla possibilità di ricevere un’educazione nella propria lingua e di poterla parlare, gridare e cantare in curdo nella sfera pubblica.
Il percorso è lungo e accidentato e non sono pochi coloro che, dentro e fuori il Kurdistan, danno voce ai propri timori. Dello Stato turco non ci si fida, non è la prima volta che un processo di pace termina in un’esplosione di violenza militare brutale e in una maggiore repressione. E Ocalan gode sì della fiducia del suo popolo, ma i dubbi non si spengono: abbandonare le armi è davvero la soluzione migliore?
Risposte univoche non ne esistono. Diverse fonti dentro il PKK riportano di un consenso ampio intorno alla decisione di Ocalan, a differenza di altre epoche storiche in cui i contrasti erano stati maggiori. Stavolta il partito sarebbe compatto perché quella decisione nasce da una consapevolezza, la stessa che ci è stata ribadita a margine della cerimonia nelle montagne irachene: la lotta armata, oggi, non permette più l’avanzata della causa curda. In un’epoca di guerre tecnologiche e droni, la guerriglia ha visto ristretto il proprio spazio di efficacia. È il senso del messaggio che Ocalan ha lanciato a febbraio, poi ripreso dal Congresso: il PKK ha esaurito la propria missione storica. Che è passata anche dalla lotta armata, lo strumento attraverso cui – soprattutto in Siria – il partito ha saputo far avanzare i processi politici e sociali, il paradigma del confederalismo democratico e una vera e propria rivoluzione.
Dopotutto, rispondono i più convinti agli scettici, il movimento è passato nella sua storia attraverso trasformazioni radicali ed è riuscito a uscirne sempre su un gradino più alto di realizzazione: movimento nato nel 1978 nell’alveo del marxismo-leninismo con l’obiettivo della statualità curda, ha abbracciato le armi contro lo Stato turco nel 1984 a due anni dalla prima azione armata (contro Israele, nel sud del Libano, accanto al Fronte popolare per la Liberazione della Palestina); per poi modificare la propria traiettoria verso l’abbandono del sogno dello stato-nazione e la creazione di un altro sogno, la democrazia diretta senza stato, una visione anti-gerarchica, municipalista e femminista che si è fatta concreta prima nel campo profughi di Makhmour in Iraq e poi in Rojava.
Il PKK ha scelto più volte l’opzione politica, senza timori ma con profonde ristrutturazioni di sé. E ha saputo cogliere i segnali, prima di tutto quelli che sono arrivati dopo il 2015 dalla base nel Kurdistan turco: piegata dalla durissima reazione militare turca che ha costretto i combattenti a lasciare il paese e rifugiarsi in Iraq, ha fatto avanzare le proprie istanze attraverso la politica e ha iniziato a vedere nel PKK un possibile ostacolo più che un punto di forza.
E poi ci sono i segnali più recenti lanciati in modo obliquo dallo Stato turco, frutto anche – ci spiegavano funzionari del partito a Suleiymaniya – dei nuovi equilibri (e squilibri) regionali sorti dopo il 7 ottobre 2023, il feroce genocidio in corso del popolo palestinese a Gaza e l’apertura da parte di Israele di un fronte dopo l’altro che hanno di fatto ridisegnato i rapporti di forza interni a molti paesi della regione. La Turchia non vi è indifferente, tanto più dopo tre lustri trascorsi a tentare di imporsi come potere egemone regionale, punto di riferimento politico e religioso, dalla Siria alla Libia.
Ankara non mette in discussione i rapporti con Tel Aviv ma prova a togliergli una delle carte che storicamente lo stato israeliano ha usato per destabilizzare i paesi vicini, ovvero le rivendicazioni delle comunità marginalizzate, dai drusi ai curdi. Su questo Ocalan è chiaro: nessun accordo con Israele ma avanti nel percorso di pacificazione del Kurdistan. Con un’arma più potente di un kalashnikov: la politica.
Chiara Cruciati,
vice-direttrice de Il Manifesto