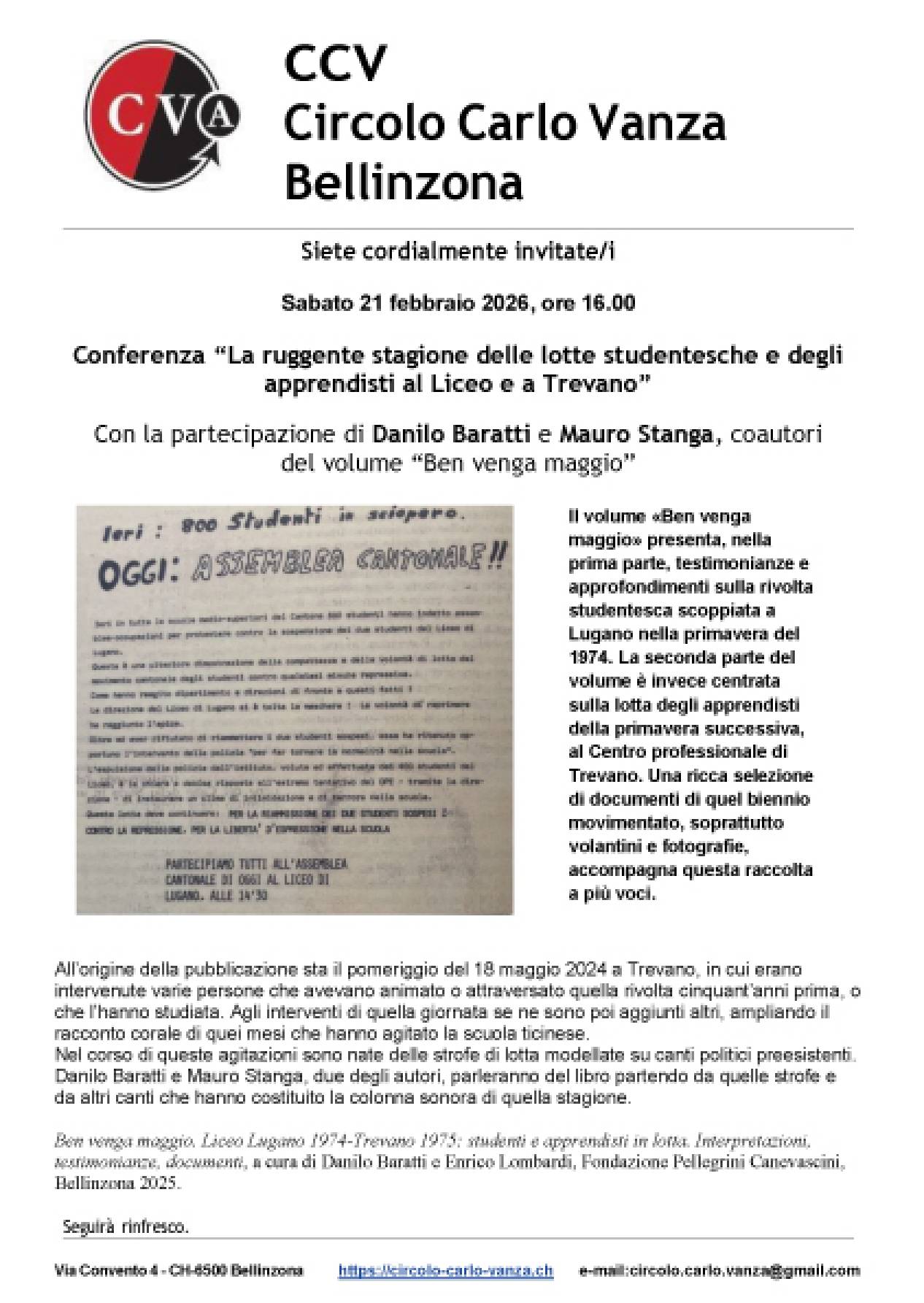Un numero crescente di governi occidentali ha annunciato nelle ultime settimane il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. Un gesto accolto con favore nelle capitali arabe e celebrato nelle dichiarazioni pubbliche, ma che, a conti fatti, rimane privo di implicazioni pratiche. Per i palestinesi, immersi in una delle fasi più drammatiche della loro storia, la mossa non offre prospettive concrete. Per Israele – al di là delle dichiarazioni rabbiose di Benyamin Netanyahu e dei suoi ministri che accusano gli alleati occidentali di «dare una ricompensa al terrorismo di Hamas» – non rappresenta una minaccia concreta né un freno alla prosecuzione dell’offensiva militare e delle restrizioni ad ogni livello che hanno spinto nel baratro della fame oltre due milioni di palestinesi, di cui circa mezzo milione a rischio immediato di carestia. I morti per fame e malnutrizione sono già centinaia, tra cui numerosi bambini.
I palestinesi, inclusi i leader di Hamas e quelli dell’Autorità nazionale palestinese, esprimono apprezzamento per questa ondata di riconoscimenti. Allo stesso tempo, sanno che l’isolamento diplomatico di Israele seppur importante, non cambia nulla sul terreno – a Gaza come in Cisgiordania – se gli Stati Uniti continueranno a garantire appoggio pieno al governo Netanyahu. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è stato determinante, tra le altre cose, per lanciare l’idea della «emigrazione volontaria» (pulizia etnica) dei palestinesi di Gaza, per la esclusione di gran parte delle attività delle Nazioni Unite dalla Striscia, e per l’oscuramento delle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Senza dimenticare che Trump ha deciso, rapidamente, due mesi fa di bombardare le centrali atomiche iraniane, realizzando un sogno ventennale di Netanyahu. La creazione di uno Stato palestinese, nella forma piena e riconosciuta dal diritto internazionale, richiede un passaggio decisivo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Qui, il veto degli Stati Uniti, sistematico già prima della presidenza Trump, continua a bloccare ogni possibilità.
La discussione, perciò, resta confinata a un livello simbolico, incapace di tradursi in cambiamenti reali. A ciò si aggiunge la convinzione di alcune cancellerie che il riconoscimento possa compensare la sofferenza dei palestinesi o funzionare come deterrente contro l’espansione militare israeliana. Per certi versi è paradossale che ad adottare la misura più concreta sino a d oggi sia stata proprio la Germania, principale alleato di Israele in Europa. Berlino se da un lato esita a riconoscere lo Stato di Palestina dall’altro ha comunicato lo stop alle forniture di armi tedesche a Tel Aviv per impedire che vengano usate a Gaza. La Germania, dopo gli Stati Uniti, è il principale fornitore di armi, motori e pezzi di ricambio per i mezzi corazzati di Israele. Il passo ha suscitato l’ira di Netanyahu e le preoccupazioni dei comandi militari israeliani.
Ciò dimostra che la comunità internazionale dispone di strumenti incisivi per esercitare pressione su Israele: congelamento di investimenti, sospensione di accordi, boicottaggi, riduzione della rappresentanza diplomatica, embargo sulle armi e restrizioni sui voli. Tutti metodi già applicati contro regimi come quello sudafricano dell’apartheid o contro l’Iraq di Saddam Hussein, la Siria di Bashar Assad o la Russia di Vladimir Putin. Tuttavia, per arrivare a misure simili serve un consenso politico e morale globale, fondato sulla conclusione che l’offensiva in corso a Gaza non sia la «giusta» conseguenza dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, piuttosto è la realizzazione di disegni politici e militari pronti da lungo tempo.
Israele, pur non avendo mai proclamato ufficialmente tutti gli abitanti di Gaza come «terroristi», agisce di fatto come se fossero una collettività indistinta e responsabile dell’attacco di Hamas, quindi da punire senza esitazioni e in ogni modo. Gli attacchi degli ultimi ventidue mesi –bombardamenti massicci, distruzione di infrastrutture, uccisioni indiscriminate di civili, sfollamenti di massa, la fame, la sete – hanno trasformato un intero popolo in una «organizzazione terroristica». Una visione che non riguarda solo l’establishment politico. Il 79% degli israeliani, secondo un sondaggio dell’Israel Democracy Institute, afferma di «non essere turbato in alcun modo» dalle immagini della fame a Gaza e dalle sofferenze che patiscono i civili palestinesi. Il riconoscimento simbolico dello Stato palestinese, pertanto, è un atto di comoda neutralità morale. Anziché attivare strumenti di pressione concreta, i governi occidentali preferiscono una mossa diplomatica priva di costi. Fonti diplomatiche europee hanno commentato che «il gesto non produce alcuna pressione reale su Israele, mentre alimenta nei palestinesi una falsa aspettativa di protezione internazionale».
Mentre la diplomazia internazionale moltiplica le dichiarazioni di principio, il governo Netanyahu ha imboccato la strada dell’occupazione totale di Gaza (Israele già controlla il 75% della Striscia). Lo scorso 8 agosto, il gabinetto di sicurezza ha approvato un piano per l’invasione di Gaza city, un passo decisivo verso il controllo permanente del territorio palestinese. Gli obiettivi ufficiali sono cinque: disarmare Hamas, liberare tutti gli ostaggi israeliani a Gaza, smilitarizzare la Striscia, stabilire il controllo di sicurezza israeliano e creare un governo che non sia legato né a Hamas né all’Anp. «Non vogliamo governare Gaza, ma garantire un perimetro di sicurezza che impedisca il ritorno della violenza. Vogliamo liberare Gaza da Hamas» ha affermato Netanyahu. Mosso da questioni ideologiche e dall’alleanza con i partiti di estrema destra e il movimento dei coloni, il primo ministro non sì è fatto fermare dalle forti riserve espresse dai vertici militari israeliani. Il capo di stato maggiore, Eyal Zamir, e altri alti ufficiali hanno avvertito che un’occupazione prolungata metterebbe a rischio la vita degli ostaggi, aggraverebbe le perdite tra i soldati, esporrebbe l’esercito a un logoramento senza precedenti e amplificherebbe la crisi di fiducia tra governo e forze armate. «L’occupazione di Gaza city non riporterà indietro gli ostaggi e non porterà alla sconfitta di Hamas, ma creerà più famiglie in lutto e danneggerà ulteriormente la reputazione di Israele nel mondo», ha previsto Gadi Shamni, generale in pensione e analista militare. Oltre 550 ex alti ufficiali e diplomatici israeliani hanno firmato un appello pubblico contro la decisione del governo, definendola una «trappola strategica». Secondo molti di loro, le risorse militari necessarie per mantenere il controllo di Gaza City superano di gran lunga quelle disponibili e comportano gravi rischi. Gli analisti militari avvertono che l’attacco a Gaza city potrebbe trasformarsi in una guerra di logoramento, nel «Vietnam di Israele». Hamas, pur indebolito, possiede ancora infrastrutture e reti di tunnel sotterranei che consentono una resistenza prolungata. Inoltre, un attacco in massa in una città ancora popolata da centinaia di migliaia di palestinesi, aggraverà inevitabilmente il numero delle vittime civili.
Sul piano internazionale, le condanne sono state unanimi. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres ha definito il piano di Netanyahu «una pericolosa escalation». L’Unione europea, la Germania, la Francia, il Regno unito, la Cina e diversi Paesi arabi hanno chiesto a Israele di rinunciare alla nuova offensiva. Egitto, Giordania e Arabia saudita hanno ribadito che qualsiasi gestione futura di Gaza dovrà passare per un cessate il fuoco negoziato e per una soluzione politica che includa la creazione di uno Stato palestinese. La posizione dei leader arabi è chiara: una gestione israeliana permanente di Gaza non solo rischia di compromettere ogni soluzione politica, ma può alimentare ulteriori tensioni nella regione. «Gaza deve tornare a essere un territorio amministrato dai palestinesi con supporto internazionale, non un avamposto militare occupato», ha dichiarato un funzionario saudita. Israele ha replicato lasciando trapelare, il 12 agosto, la notizia secondo cui un imprenditore palestinese, Samir Huleilah, si sarebbe detto pronto ad essere nominato «governatore» di Gaza e ad amministrare al posto di Hamas.
Il futuro della Striscia, e più in generale della questione palestinese, dipenderà dalla capacità e dalla volontà della comunità internazionale di andare oltre il simbolismo. Se il riconoscimento dello Stato palestinese resterà un atto isolato, privo di strumenti veri, e se l’occupazione israeliana procederà senza freni, la prospettiva già molto incerta di una soluzione a Due Stati (Israele e Palestina) si spegnerà definitivamente. Viceversa, un’azione diplomatica concertata, accompagnata da pressioni economiche e politiche reali, potrebbe ancora trasformare un gesto simbolico in un primo passo concreto. In ogni caso, tra Gaza ridotta a un cumulo di macerie e Israele impegnato in una nuova fase di guerra aperta, il futuro parla di escalation e di una tregua sempre più improbabile. «Se non si interviene subito con un cessate il fuoco, perderemo un’altra generazione e la speranza di uno Stato palestinese sarà compromessa per decenni», ha commentato un funzionario dell’Onu.
Il pericolo più immediato non è solo politico, oltre alla crisi umanitaria catastrofica in cui l’offensiva israeliana ha gettato la popolazione palestinese. La pulizia etnica mascherata sulla quale insiste Netanyahu con l’appoggio di Trump, è una possibilità sempre più concreta. Israele, ha rivelato l’agenzia di stampa Ap, sta discutendo con il Sud Sudan sulla possibilità di «trasferire» i palestinesi della Striscia nel paese dell’Africa orientale (devastato dalla guerra).
Non è chiaro a che punto siano i colloqui, ma se attuati, i piani equivarrebbero a trasferire civili da una terra distrutta e a rischio carestia a un’altra terra devastata dalla guerra civile. Netanyahu afferma di voler realizzare la visione del presidente degli Stati uniti. «Penso che la cosa giusta da fare, anche secondo le leggi di guerra così come le conosco, sia permettere alla popolazione di andarsene, e poi attaccare con tutte le forze il nemico (Hamas) che rimane lì», ha detto il premier in un’intervista alla tv i24, un’emittente televisiva israeliana. Non ha fatto riferimento al Sud Sudan, ma il paese africano è notoriamente alleato di Israele e con un accordo del genere forse pensa di poter costruire legami più stretti con Tel Aviv. Joe Szlavik, fondatore di una società di lobbying statunitense che collabora con il Sud Sudan, ha dichiarato di essere stato informato dai funzionari sudsudanesi sui colloqui e ha rivelato che una delegazione israeliana ha in programma di visitare il Paese per valutare la possibilità di allestire campi profughi per i palestinesi. Nei mesi scorsi si era parlato di colloqui simili avviati da Israele e Stati Uniti con Sudan e Somalia e con la regione separatista del Somaliland. Non pochi palestinesi dicono di poter lasciare Gaza, ma solo temporaneamente, per sfuggire alla guerra e alla carestia causata da Israele. Ma rifiutano categoricamente una nuova Nakba, ossia l’esilio permanente dalla loro patria. Israele sanno bene, non permetterà mai loro di tornare e una partenza di massa consentirebbe a Netanyahu di annettere Gaza e di ristabilire lì gli insediamenti coloniali ebraici evacuati esattamente venti anni fa.