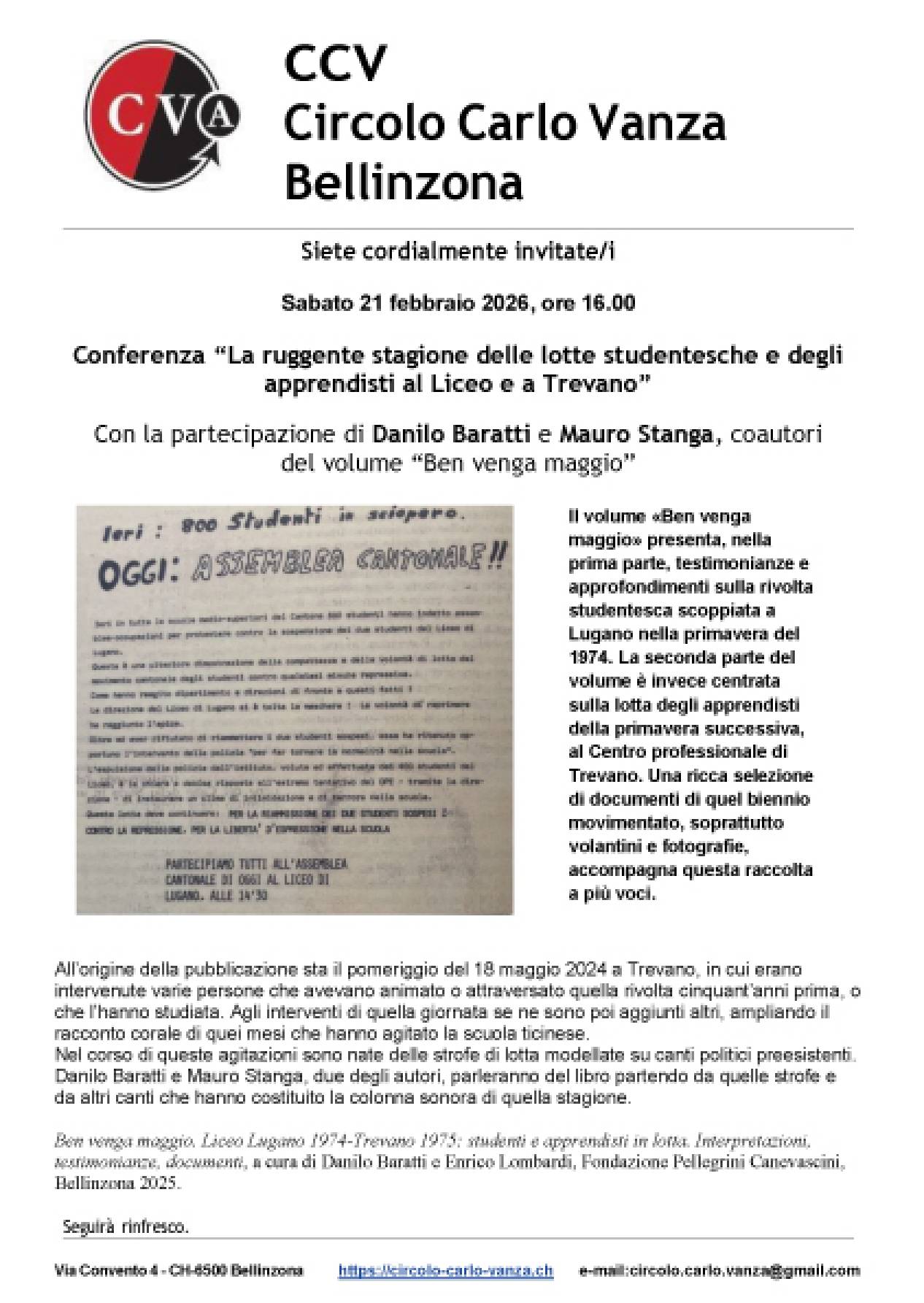È una guerra da manuale quella scatenata da Israele e Stati uniti contro la Corte penale internazionale (Cpi). Una guerra che usa strategie che ricordano quelle militari: prima si accerchia il nemico, poi lo si priva delle vie di rifornimento e infine si colpisce.
Non è una guerra nuova, sono anni che il governo israeliano opera dietro le quinte per minare la credibilità di uno dei due più alti tribunali del pianeta, con il sostegno indispensabile di amministrazioni statunitensi compiacenti. Quella trumpiana, senza dubbio, è la più disponibile al lavoro sporco. Dopo gli attacchi sferrati durante il primo mandato di Donald Trump, tra il 2016 e il 2000, è in quello attuale – inaugurato appena nove mesi fa – che la sfida alla Cpi si è fatta senza quartiere e soprattutto alla luce del sole.
Il motivo è stringente: dopo anni di titubanze e ritardi, a seguito del 7 ottobre 2023, dell’attacco di Hamas al sud di Israele e dell’inizio del genocidio a Gaza, la procura della Corte dell’Aja ha capito che era tempo di agire. Il procuratore Karim Khan ha ripreso in mano il fascicolo lasciatogli in eredità dalla sua predecessora, Fatou Bensouda, e costruito grazie al lavoro indefesso e coraggioso della società civile palestinese. Ha ripreso le indagini e non si è mai fermato, fino ad arrivare a una conclusione senza precedenti: a novembre 2024 il procuratore Khan ha chiesto alla Camera preliminare della Cpi l’emissione di mandati d’arresto per crimini di guerra e contro l’umanità per il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, l’allora ministro della difesa Yoav Gallant e tre dei più alti leader di Hamas, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Mohammed Deif, tutti nel frattempo uccisi in omicidi mirati extragiudiziali dall’esercito e dai servizi israeliani.
Tel Aviv non è stata a guardare, che l’indagine stesse proseguendo spedita e che i mandati d’arresto fossero ormai nell’aria era risaputo. Per questo, fin da subito, la leadership militare, politica e di intelligence di Israele ha lanciato una vera e propria campagna di diffamazione e di intimidazione. I mezzi sono i soliti noti: da una parte le dichiarazioni pubbliche di condanna, le accuse di antisemitismo e di doppio standard, che però ormai sembrano non trovare più terreno fertile nelle opinioni pubbliche globali; dall’altra gli attacchi individuali e le minacce ad personam, per sgretolare le figure più in vista della Corte. Ovvero: sanzioni emesse dagli Stati uniti per conto dell’alleato che hanno colpito giudici e membri della Procura – inficiando pesantemente sulla loro vita, tra divieti di viaggio in determinati paesi e congelamento dei conti correnti – e campagne diffamatorie a mezzo stampa, condite con intimidazioni faccia a faccia per le strade dell’Aja.
La più significativa è quella lanciata contro il procuratore Khan, dallo scorso anno impegnato a difendersi dall’accusa di molestie sessuali contro una collaboratrice e a tutelarsi dalle minacce subite. La più plateale risale al primo maggio scorso: l’avvocato britannico-israeliano Nicholas Kaufman – legale di Israele, tra gli altri – ha approcciato il procuratore in un hotel perché ritirasse i mandati d’arresto: «Distruggeranno te e distruggeranno la Corte», le parole di Kaufman.
Dopo mesi trascorsi a resistere, senza passi indietro rispetto ai mandati d’arresto, a maggio Khan si è messo in «ferie forzate» in attesa della conclusione delle indagini sul suo conto. Una decisione che ha avuto degli effetti immediati: secondo fonti interne che abbiamo potuto sentire con “il manifesto,” il fascicolo Palestina è pressoché congelato. A regnare, dice la nostra fonte, è la paura. La paura di essere presi di mira, la paura di vedere terremotata la propria vita personale e professionale, ma soprattutto la paura per l’istituzione che ha fornito al mondo un’aula di giustizia internazionale.
Il fascicolo sui crimini commessi nei Territori palestinesi occupati è lì, ad attendere qualcuno che lo riprenda in carico e lo porti avanti (e di indagini in corso ce ne sono: è dalla scorsa primavera che si attende la richiesta di mandati d’arresto per altri due ministri israeliani, Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, con l’accusa di apartheid, una prima volta assoluta per tale crimine) o ad attendere che qualcuno stacchi la spina. Le preoccupazioni, ha aggiunto la fonte, coinvolgono ogni livello della Corte che si sente oggi più che mai senza difese esterne: nonostante le bordate lanciate dall’amministrazione statunitense e le palesi interferenze illegali di Israele, nessuno dei paesi firmatari dello Statuto di Roma – a partire da quelli europei – ha alzato la voce o un dito a difesa del tribunale. Di nuovo, la mancanza di volontà politica rischia di demolire una delle conquiste più significative del diritto internazionale.
È la manovra di accerchiamento. Che non ha coinvolto solo la Corte, ma anche i suoi «alleati»: a inizio settembre gli Stati uniti hanno emesso sanzioni su tre delle più note e rispettate organizzazioni palestinesi per i diritti umani, Al-Haq, Al-Mezan e il Palestinian Center for Human Rights, ovvero le tre associazioni che in questi anni hanno raccolto prove, documenti, materiali per dimostrare i crimini di guerra commessi da Israele a Gaza e in Cisgiordania e che, fornendoli alla Cpi, hanno reso possibile l’apertura del fascicolo Palestina nel 2019 e l’emissione dei mandati d’arresto nel 2024. Che non sono nemmeno il problema principale: secondo la nostra fonte, a preoccupare Israele non sono tanto le richieste di arresto (che necessitano dell’intervento degli Stati per poter essere agiti, non avendo la Cpi una sua polizia), ma le indagini sulle colonie, cuore dell’impresa espansionistica e coloniale israeliana dal 1948, natura originaria dello Stato.
L’amministrazione Trump lo ha detto in modo che più chiaro non si può: per bocca del segretario di stato Marco Rubio, Washington ha definito le sanzioni alle tre ong palestinesi una risposta agli «sforzi della Corte penale internazionale di indagare, arrestare, detenere o perseguire cittadini israeliani, senza il consenso di Israele». Rubio ha poi aggiunto che «gli Stati uniti continueranno a rispondere con conseguenze significative e tangibili per proteggere le nostre truppe, la nostra sovranità e i nostri alleati dal disprezzo della Cpi per la sovranità e per punire le entità che sono complici».
Una minaccia diretta che si sta concretizzando nei giorni in cui questo articolo va in stampa: Washington starebbe per emettere sanzioni direttamente contro la Corte penale, contro il tribunale in sé. Accerchiamento, taglio dei rifornimenti e infine attacco diretto.
Dopo i singoli individui, ora toccherebbe all’istituzione stessa. Le sanzioni avrebbero effetti devastanti: renderebbero pressoché impossibili le operazioni quotidiane, le indagini, il reperimento di finanziamenti. Impedirebbero a società terze di lavorare con la Cpi, privandola quindi di tutti quei servizi necessari al suo funzionamento, dai software per computer agli strumenti di archiviazione, dalle assicurazioni ai servizi bancari.
Una vera e propria bomba ad orologeria. Alla Corte hanno capito benissimo le conseguenze, le temevano da tempo, tanto da aver «rallentato» indagini considerate troppo sensibili in attesa del ritorno del procuratore Khan o la sua sostituzione. Secondo il “Times of Israel”, a fine settembre all’Aja si sono svolti incontri d’emergenza per discutere del possibile impatto delle sanzioni, mentre altri meeting avrebbero coinvolto anche diplomatici di alcuni paesi membri della Cpi. Addirittura, sarebbero stati pagati gli stipendi in anticipo per tutto il 2025 per timore di non poter più accedere ai conti bancari.
La campagna politica di Usa e Israele ha effetti anche oltre i confini dei Paesi Bassi, che ospitano la sede della Cpi. Il 23 settembre tre paesi africani, Burkina Faso, Mali e Niger, hanno annunciato il ritiro dalla Corte penale internazionale definendola uno strumento di imperialismo neocoloniale. Le ragioni, stavolta, non sono legate alla questione palestinese: i tre paesi del Sahel – protagonisti di tre golpe militari compiuti tra il 2020 e il 2023 – accusano la Corte di non aver saputo «gestire e perseguire crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di genocidio e aggressione» compiuti dalla Francia nei propri territori. E chiedono la creazione di «meccanismi indigeni di consolidamento della pace e la giustizia». Una presa di posizione che si intreccia a una delle accuse storiche mosse contro l’Aja, ovvero di aver preso di mira solo ed esclusivamente leader politici e militari del sud globale. Così è stato per anni: è stato solo con i mandati d’arresto per Putin (per l’invasione dell’Ucraina) e per Netanyahu e Gallant che per la prima volta sono stati messi sotto indagine individui bianchi, del nord del mondo.
L’uscita dalla Cpi non è immediata. Serve un anno di procedure per potersi ritirare dallo Statuto di Roma, un percorso avviato lo scorso aprile anche dall’Ungheria di Viktor Orbán, alleato di ferro di Tel Aviv, proprio in polemica con i mandati d’arresto contro i leader israeliani.
Nell’era dell’impunità dichiarata, i tribunali internazionali sono considerati un ostacolo da stati sovranisti, democrature, paesi responsabili di genocidio. Per questo andrebbero difesi da quelle che ancora oggi si considerano «democrazie liberali» e che però restano in silenzio. Secondo fonti diplomatiche, alcuni paesi europei starebbero lavorando a meccanismi di protezione della Cpi dalle eventuali sanzioni statunitensi, ma di dettagli non ce ne sono. La paura, condivisa in molte capitali, dentro gli uffici dell’Aja e tra le associazioni della società civile che ai tribunali internazionali si sono affidate per ottenere giustizia, è che alla fine le intimidazioni, le minacce, le sanzioni avranno effetto: che le Corti faranno un passo indietro per preservare se stesse, ma segnando così, paradossalmente, il primo atto della definitiva morte del diritto internazionale.