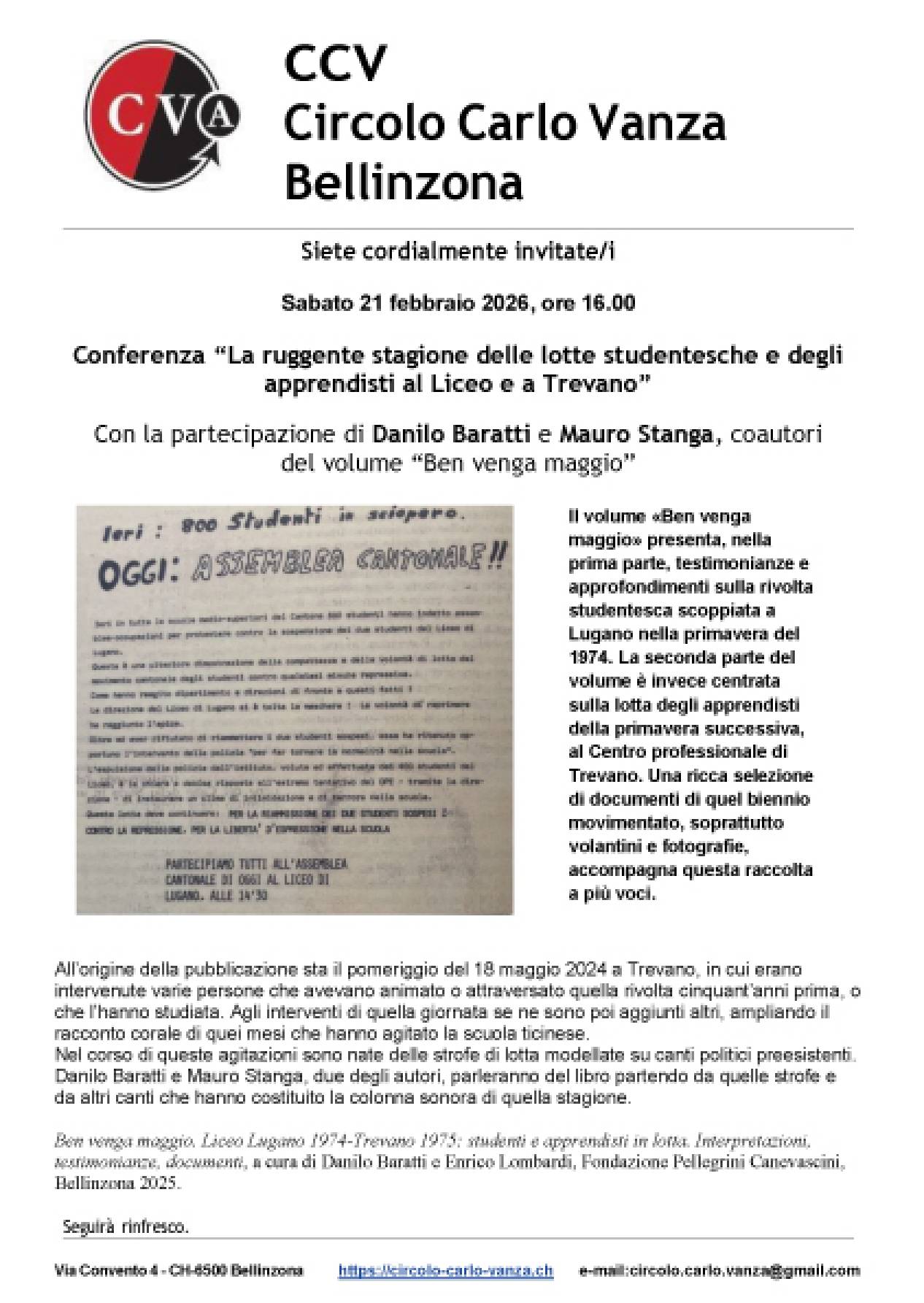La crescita della ricchezza di un Paese, nelle nostre società, viene ancora oggi misurata con il PIL, cioè con la misura del valore di quanto vien prodotto in beni e servizi su un territorio in un certo periodo. Di fatto il PIL viene identificato con il benessere prodotto anche se il PIL è una misura esclusivamente quantitativa, tanto che lo stesso cresce quando vi è una catastrofe naturale o indotta dall’uomo (leggi GUERRA!) e questo indipendentemente da quanta povertà la catastrofe stessa ha prodotto o da quante siano state le perdite umane da essa generata.
Questo perché nella nostra società si considera che ci sia crescita della ricchezza solo se girano a pieno regime i due motori della macchina “capitalista” e cioè lo sviluppo delle forze produttive senza che vi siano intoppi o limiti esterni e il continuo aumento quantitativo della produzione. Solo così si sostiene ancora oggi sia possibile produrre vera ricchezza. E per decenni il capitale (e i suoi rappresentanti politici) ci ha raccontato che è solo così che si pongono le basi per il sempre promesso e quasi mai realizzato miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli individui.
Oggi sappiamo bene che non è vero, che si tratta di un costrutto certificatamene inveritiero
Da un lato perché la maggior produttività e la ricchezza da essa prodotta non viene più distribuita correttamente (i salari reali non sono cresciuti e in molti casi sono diminuiti, lo stato ha ridotto o reso molto più cara l’offerta di prestazioni e di servizi pubblici per cui la popolazione rinuncia agli stessi o deve far capo a servizi a pagamento, le imposte sono progressivamente meno incisive sugli alti redditi, ecc.) ma si è semplicemente accumulata nelle tasche di pochi, non producendo il promesso miglioramento qualitativo nelle vite delle persone. Anzi! Il numero dei poveri è cresciuto (in Ticino il rischio di povertà tocca tra il 24 al l 27% della popolazione) e la qualità di vita della classe media è decisamente peggiorato. Basti dire che in Svizzera, secondo il World Inequality Database, il 10% più ricco della popolazione possiede il 63% del capitale (una percentuale aumentata di quasi 6 punti dal 1995), mentre la metà meno abbiente della popolazione non arriva neppure al 4% del patrimonio. Nell’Europa occidentale, solo l’Irlanda registra una quota più elevata (66%).
A tutto questo si aggiunge il dirompente impatto ambientale di questa continua crescita quantitativa della produzione, sia in termini di consumo di energia e di risorse non rinnovabili necessarie per produrre, commercializzare e distribuire quanto prodotto, sia per le ricadute sui territori delle produzioni e degli scarti produttivi, nonché per lo smaltimento di quanto “consumato”, un consumato” in larga misura progettato e costruito per non durare, per avere una data di scadenza che ne obbliga la sostituzione in tempi brevi. Non va infatti dimenticato che dal 1992, quando fu firmata la Convenzione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, le emissioni sono quasi raddoppiate. Come dire: in questi trenta e passa anni il capitalismo nei fatti ha vinto la propria battaglia e l’ambiente l’ha persa.
In altre parole, il sistema capitalistico continua imperterrito il suo cammino ignorando sia il debito sociale che ha nei confronti di chi concretamente mantiene in vita il sistema producendo e consumando, sia l’enorme debito nei confronti del mondo naturale da cui da sempre trae le proprie risorse.
Ma non basta! Oggi (ma anche ieri!) il capitalismo non si accontenta più di non dover fare i conti con ostacoli o limiti al suo sviluppo! Vuole sostegno politico e finanziario alla sua crescita ogni volta che ne ha bisogno, indipendentemente dal fatto che tale bisogno sia generato da contingenze ineluttabili (ad esempio il Covid) o da vere e proprie incapacità manageriali (in Svizzera si pensi solo a Swiss, al Credito svizzero, ecc.). Con questo unico obiettivo, per essere sicuri che i soldi pubblici ci siano e siano sempre disponibili, la battaglia più importante e prioritaria per il capitale è diventata quella di risanare i bilanci pubblici e ridurre le spese dello Stato.
Non per caso nelle scorse settimane si è assistito ad un confronto serrato su La Regione tra i rappresentanti istituzionali dell’economia e diversi esponenti economici e politici sull’importanza di avere finanze pubbliche sane. Il tutto a partire da un ottimo contributo di Marazzi e Greppi sulla realtà e la retorica del debito pubblico.
Un confronto anomalo, quasi passionale, oserei dire insolito.
Sono infatti state molto più contenute, per non dire assenti, le reazioni da parte del mondo economico sulle sollecitazioni sindacali sull’urgenza di far crescere i salari in Ticino. E con analogo distacco e freddezza una parte significativa del mondo economico (con i suoi paladini politici) si è espressa sui Bilaterali 3, quasi se ne fregasse di perdere o quanto meno di avere difficoltà nel vendere ai 450 milioni consumatori europei che vivono fuori dalla nostra porta di casa, ritenendo sufficiente poter contare sugli scambi commerciali con Singapore, India, ecc., dimenticandosi quindi bellamente (per lo meno nel contesto della realtà del Ticino!) che più del 90% delle aziende ha meno di 10 dipendenti e quindi, salvo rare eccezioni, non ha le risorse umane e finanziarie per intrattenere relazioni commerciali con l’altra parte del mondo!
Questa accesa battaglia del capitale sul debito pubblico sembra suonare un campanello d’allarme, dimostrando come ci sia paura, una grande paura, da parte del capitalismo rispetto al proprio futuro, una paura in parte forse innestata anche dalle attuali difficoltà commerciali con gli Stati Uniti. Lo vedremo!
Ma tornando alla menzogna iniziale del capitalismo (il più è meglio) alla luce di tutto quanto precede, la necessità di cambiare prospettiva è urgente.
Per farlo bisogna far affondare le radici dell’economia all’interno della società, subordinandola al controllo dei produttori e dei consumatori.
Certo si tratta di una grande sfida, ma alcune piste di sviluppo esistono e potrebbero essere esplorate con maggiore coraggio, determinazione e creatività sia dai socialisti che dagli ecologisti rispetto a quanto fatto fin qui.
Qualche esempio di alcuni possibili principi su cui riflettere:
- serve prima di tutto una pianificazione democratica degli obiettivi, delle scelte di produzione, dei sistemi di distribuzione, dei modelli di consumo;
- è necessario il controllo democratico della struttura tecnologica delle forze produttive;
- è e resta irrinunciabile la collettivizzazione dei mezzi di produzione;
- bisogna creare consorzi e associazioni che, coinvolgendo trasversalmente la popolazione, riorientino le scelte del mercato nel solco di una pianificazione democratica dal basso, capace di tenere in debita considerazione sia i bisogni reali di ogni territorio e della sua popolazione, sia i limiti del mondo naturale.
In prospettiva è auspicabile una trasformazione economica qualitativa e non quantitativa dell’economia che sappia reindirizzare le risorse a favore dei sistemi produttivi circolari.
Per farlo serve un consenso popolare forte, ma servono anche soldi pubblici. Tanti. Soldi recuperabili sia cancellando i finanziamenti ai settori inutili o dannosi (ancora una volta, ad esempio, per le armi), sia rimettendo in campo con forza la fiscalità ridistributiva, perché è proprio stato il sistema fiscale redistributivo, quanto meno fino agli anni Ottanta, a determinare la ricchezza e il successo soprattutto della classe media ma anche del Paese tutto negli Stati Unti, in Inghilterra e in gran parte d’Europa.
Utopie o ingenuità? Piuttosto idee, principi, direzioni e piste da esplorare e su cui lavorare.
Oggi sappiamo con certezza che il capitalismo ha generato la crisi climatica che stiamo vivendo e ha spalancato la forbice sociale accentuando fortemente le diseguaglianze. Ma il capitalismo non vuole, ma forse sarebbe meglio dire non può, per la sua stessa natura, risolvere questi problemi, anzi!
Ridisegnare e costruire un nuovo sistema economico è quindi necessario e urgente.