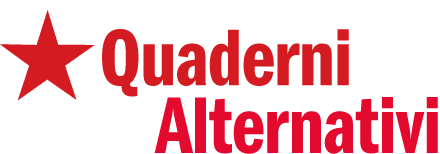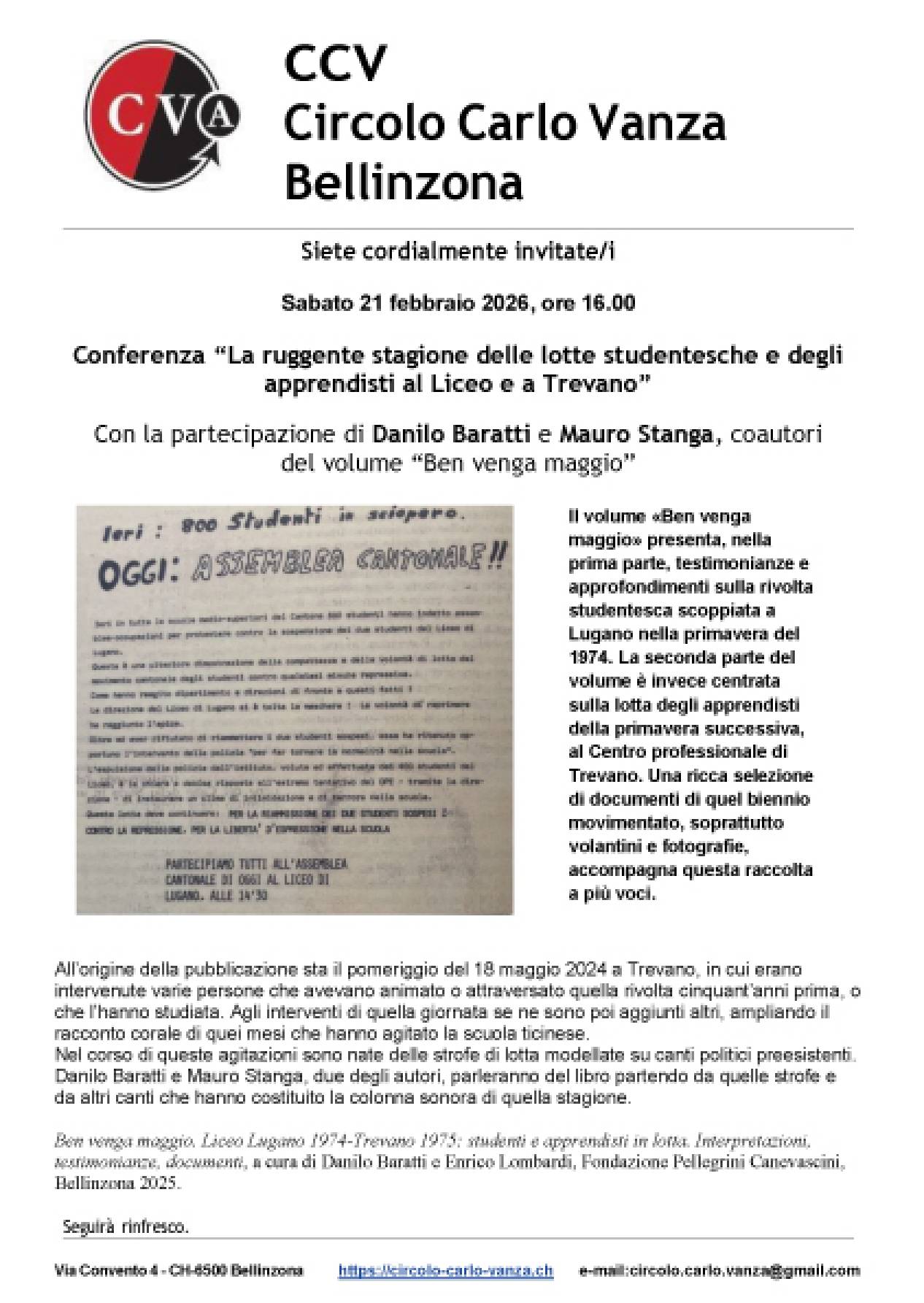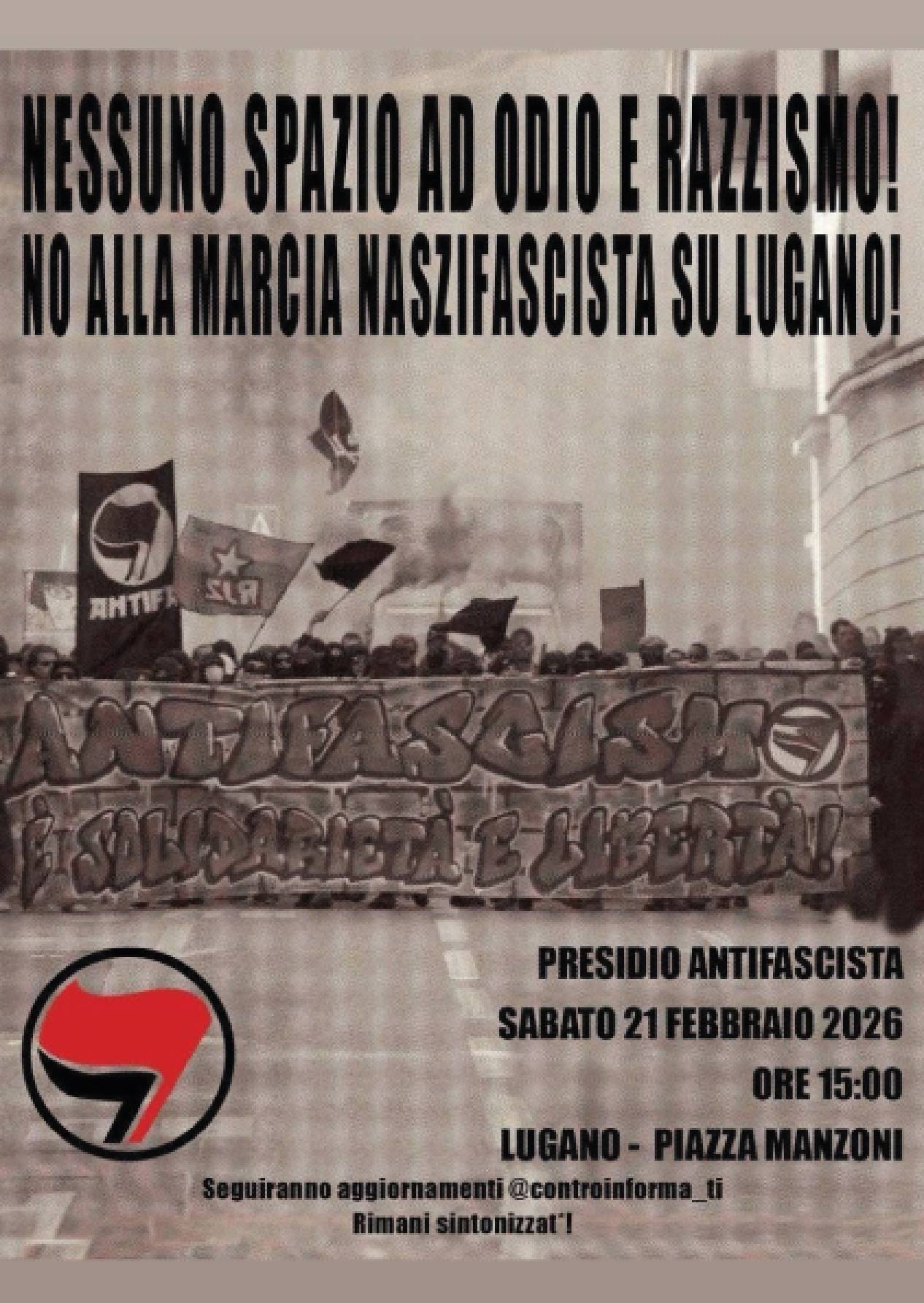Nota di RedazioneNel numero 48 dei Quaderni abbiamo consigliato ai nostri lettori quale rivista Jacobin Italia. Jacobin è la rivista cult della Sinistra neomarxista statunitense, ora disponibile anche in una versione italiana, che riprende almeno parzialmente gli articoli di quella statunitense, aggiungendone però una serie di originali. Siamo perciò grati alla redazione di Jacobin Italia che ci ha permesso di riprendere questa interessante intervista/discussione tra Christian Marazzi e Marco Bertorello (autore di saggi sull’economia e collaboratore del Manifesto) a proposito della crisi della produttività nelle economie dei principali paesi occidentali. Se questo calo è evidente, la domanda centrale di questa discussione è se gli indicatori di produttività siano totalmente oggettivi o se non riescano più a catturare il vero impatto p. es. dell’automazione sull’economia. Parallelamente si osserva anche una diminuzione del tasso d’innovazione, quasi che un ciclo si stesse a poco a poco spegnendo. Secondo Marazzi il fatto che questi indici non riescono più a catturare esattamente la situazione potrebbe essere legato anche all’aumento del lavoro gratuito e alla precarizzazione crescente. Sul tema c’è anche da segnalare un commento interessante pubblicato da Sergio Bologna “Lo schiavismo come rispettabile modello” nel Manifesto (25 giugno 2024) dove discutendo della tragedia di Satnam Singh afferma che forse soprattutto nel capitalismo post-fordista attuale lo schiavismo (quale realità oggettiva o quale forma estrema della precarizzazione) determina spesso la struttura dei costi e come tale sia materialmente impossibile da eliminare. Forse vale la pena di ricordare che in greco la parola per lavoro e schiavitù è la stessa, il senso cambia solo spostando di poco l’accento. |
|
Marco Bertorello: Spesso è difficile comprendere la traiettoria dell’economia contemporanea. Alcuni assunti che sembravano punti fermi nel passato, da un po’ di tempo sembrano inspiegabilmente contraddetti dalla realtà. Pensiamo ai due decenni precedenti il Covid. Immissione nel sistema di moneta facile in quantità mai viste prima e assenza di inflazione, se non quella negli asset finanziari. Se allontaniamo il punto di visuale un altro enigma fa capolino su quanto sta accadendo tra innovazione tecnica e poca crescita. Già nel 1987 l’economista Robert M. Solow sottolineava il paradosso di come «si possono vedere computer dappertutto, tranne che nelle statistiche della produttività». Il tema è piuttosto complesso, per certi versi viene da lontano e coinvolge una molteplicità di fattori.
Christian Marazzi: In generale si può partire dal paradosso della produttività di Solow. Il paradosso della produttività serve a ricordare che gli impatti del cambiamento tecnologico sulla produttività sono molteplici e non sempre immediatamente evidenti nei dati economici (problema di misura, ma non solo: è sempre più difficile, concretamente, capire come nasce la ricchezza comunque definita), evidenziando l’importanza di un’analisi più articolata della valutazione degli effetti dell’innovazione sulla crescita e sullo sviluppo economico.
M.B.: Nell’economia contemporanea è in corso quello che gli economisti chiamano productivity slow down, in particolare nei principali paesi occidentali. Recentemente sono usciti due rapporti, uno della società di consulenza Mc Kinsey e l’altro del Fondo monetario internazionale (Fmi) che sottolineano proprio come stiamo assistendo a un calo della produttività nelle economie avanzate. Quanto ritieni l’indicatore di produttività possa riflettere una crescita del benessere delle nostre società? Esiste un problema di misurazione sostanziale? Inoltre, esiste sempre uno stretto rapporto tra l’esser più ricchi e lo stare meglio?
C.M.: Partiamo dal presupposto che utilità è un surrogato di felicità e che nella tradizione benthamiana tutti desideriamo la felicità. Ora, il problema è che oggi – ma naturalmente non è il solo problema – nell’economia mainstream con il termine utilità ci si riferisce al valore di qualcosa. Perciò, se il reddito coincide con l’utilità e l’utilità coincide con la felicità, allora un reddito più elevato dovrebbe portare a maggiore felicità, almeno a livello complessivo se non a quello individuale. Non è proprio così. A parte che, se il reddito cresce per taluni, ma non per altri, ossia se crescono le disuguaglianze, è tutta la società ad essere meno felice (Wilkinson & Pickett, La misura dell’anima, 2009). Dopo gli studi di Richard Easterlin degli anni Settanta, sappiamo che un reddito maggiore aumenta la felicità di chi parte da un reddito molto basso. Oltrepassata una certa soglia, avere più soldi sembra determinare una diminuzione dei vantaggi aggiuntivi. Poi c’è tutta la tradizione neo-aristotelica (Amartya Sen) secondo cui denaro e utilità non rappresentano un indice della qualità di vita in una società. Il benessere dipende piuttosto dalle «capacità» delle persone di vivere bene, di trasformare queste capacità in funzionamento esistenziale in un determinato contesto.
M.B.: Vero, ma quel che appare, a giudicare dai giudizi di importanti organismi internazionali, è una certa preoccupazione per questo calo di produttività. Studiosi come Robert Gordon sostengono che gli effetti dell’innovazione tecnologica della cosiddetta terza rivoluzione industriale stiano esaurendosi. Come se l’impatto dell’innovazione avesse incontrato una certa saturazione, un limite difficilmente valicabile. Sottolinea come le innovazioni della seconda rivoluzione industriale siano state qualitativamente superiori rispetto alla terza. Ora vivremmo una sorta di approfondimento di trasformazioni precedenti. In tal caso non ci sarebbe nulla da poter fare. Qualcosa di vero, almeno in alcuni segmenti produttivi, c’è in questa lettura. Gli andamenti della produttività complessivi nel lungo periodo, cioè a partire dagli anni Cinquanta, fatta salva una breve parentesi tra metà degli anni Novanta e metà del primo decennio del nuovo secolo, hanno avuto un tasso di crescita quasi dimezzato, anche nel settore manifatturiero, nonostante sia intervenuta un’elevata automazione. Ma forse non basta leggere le trasformazioni attuali solo in questi termini.
C.M.: Aaron Benanav affronta il paradosso della produttività suggerendo che le misure convenzionali di produttività non riescono a catturare il vero impatto dell’automazione sull’economia. Più precisamente, Benanav sostiene che questa discrepanza può esser attribuita a diversi fattori. Vi sono problemi di misurazione, in quanto non si riesce a tener conto pienamente dell’apporto dell’innovazione nei processi, nei prodotti e nei metodi di distribuzione. Da qualche anno anche il Financial Times ritiene che la questione della dismisura, dell’enigma della produttività, sia alquanto centrale. Si è sempre più consapevoli che tutta una parte della produzione di ricchezza sfugga alla quantificazione e che, non lasciando tracce monetarie, non appaia nel Pil, e quindi nemmeno nei tassi di produttività. Penso che il fenomeno abbia sempre più a che fare con la categoria del lavoro gratuito, con l’aumento del lavoro invisibile e non riconosciuto come effetto dei processi di esternalizzazione, cioè del trasferimento di attività sul cittadino. Fenomeno ben riassunto nella figura del prosumatore, colui che contribuisce in parte alla produzione degli stessi servizi che consuma. Un fenomeno che si è ampliato con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A partire dal lettore ottico e del codice a barre negli anni ‘70, vi è stata una continua proliferazione di dispositivi tele-tecnici volti a catturare, accumulare e commercializzare informazioni e dati relativi alle nostre forme di vita, ai nostri comportamenti e alle nostre attività in ambiti extra-lavorativi. In questo senso, la digitalizzazione in senso lato ha fortemente ampliato l’area del lavoro gratuito, della “vita messa al lavoro”, per la felicità delle grandi corporation della Silicon Valley.
M.B.: Chiarissimo il tuo ragionamento. Quel che vorrei capire è perché a Mc Kinsey preoccupa una sorta di slittamento nell’aumento dei tassi di produttività verso alcuni importanti paesi emergenti. Lo stesso Benanav evidenzia come il calo di capacità produttiva stia iniziando a coinvolgere persino la Cina. Una parabola dello sviluppo verso una tendenziale deindustrializzazione. Dove persino il passaggio dal lavoro industriale a quello nei servizi comporta un ridimensionamento della sua produttività. Questo non è un dato che viene semplicemente registrato, è fattore di preoccupazione. Come se tale fenomeno in qualche modo mostrasse difficoltà in particolare nelle economie avanzate. Perché preoccupa tanto? Se una crescita della produttività reale vi fosse davvero, ma semplicemente non fosse misurata, perché preoccuparsi?
C.M.: La domanda me la pongo anch’io da tempo. Mettiamola così. L’aumento del lavoro gratuito significa aumento di valore senza un corrispettivo monetario. Non c’è salario, non ci sono redditi, insomma. Aumenta la ricchezza reale, ma manca il corrispettivo monetario del valore creato. Anche se può sembrare una provocazione, io penso che la finanziarizzazione sia quel dispositivo che produce sotto forma di rendite quei redditi che, se fossero diversamente distribuiti, potrebbero corrispondere a quella parte di valore prodotto, ma non riconosciuto perché occultato. La finanziarizzazione genera rendite in modo perverso, con una concentrazione enorme di ricchezza al vertice della piramide, su questo non ci piove. Ciò non significa comunque che la finanza, smentendo una lunga tradizione anche marxista, sia parassitaria. Nella finanziarizzazione è il denaro che produce denaro, lo sappiamo, ma la rendita finanziaria così creata in qualche modo ha un suo corrispettivo in termini di valore. Per questo non è semplicemente parassitaria. Poi la distribuzione della rendita è sperequata in maniera abnorme attraverso la distribuzione di dividendi, plusvalenze, tassi d’interesse, ecc., confluendo su una cerchia ristretta di popolazione. Ma se le transazioni finanziarie e le plusvalenze fossero opportunamente tassate, si potrebbero risolvere non pochi problemi di tipo redistributivo, quei problemi che oggi non vogliamo affrontare nascondendoci dietro il debito pubblico “fuori controllo” e i tassi di crescita “anemici”. Tornando alla tua domanda, perché comunque ci si pone il problema del rilancio della produttività? Non solo il modo di come misurarla correttamente, ma di come rilanciarla attraverso investimenti. Mc Kinsey e Fmi dicono che c’è stato un calo vertiginoso degli investimenti proprio a partire dalla crisi del 200708. Per cui gli aggiustamenti e gli aumenti di produttività passano per altre vie, anziché in investimenti in capitale fisso. Cosa significa? Che una parte consistente, probabilmente maggioritaria, dei capitali investiti sono stati riversati nella finanza.
M.B.: Questi organismi pongono l’accento sul basso tasso d’investimento. Nonostante la relativa salute dell’attuale sistema finanziario e il deciso sfruttamento del lavoro salariato e gratuito. Mi pare che implicitamente, pongano un problema di mancato equilibrio tra intervento più redditizio in direzione della finanziarizzazione e quello in attività più tradizionali. Come se con modesti investimenti si potesse far crescere la rendita nei meccanismi finanziari, ma non le condizioni di vita nella società e nell’economia nel loro complesso. Come se ponessero un problema di sostenibilità. Senza ricadere nello schema della polarizzazione tra economia finanziaria e quella reale. Che giudico due sfere ormai complementari.
C.M.: Hai ragione, penso che sia quello il problema che sollevano questi organismi. Essi temono che questo aumento delle diseguaglianze, di cui la finanziarizzazione è in buona parte responsabile, metta a rischio la pur minima coesione sociale. La via proposta dal Fmi di riprendere ad investire nel senso classico, nell’economia reale, credo abbia a che fare con un problema di creazione di ricchezza, ma distribuita con modalità meno diseguali. Implicitamente mi pare pongano la questione che non si possa continuare a ritenere la finanziarizzazione l’attore principale che provvede a creare quei redditi/rendite che i processi di produzione del valore reale non creano. Perché ciò significherebbe un’ulteriore polarizzazione della ricchezza. Sapendo bene che la spesa dei ricchi non garantisce la realizzazione monetaria di tutto il valore creato. Sappiamo che la spesa dei ricchi si concentra in fasce di consumo non rappresentative della totalità del valore creato. C’è la necessità, in qualche modo, di investire in produttività per creare o aumentare i salari che oggi sono penalizzati dai processi di finanziarizzazione.
M.B.: L’impressione è quella che isolare la questione della misurazione della produttività possa distrarre da problemi veri che attorno al tema ruotano. Quindi senza negare il fatto che un problema di caduta della produttività sia in corso, vale la pena associarlo, o spiegarlo, affrontando fattori d’insieme. Innanzitutto nonostante l’innovazione sia ubiqua risulta meno produttiva. Cioè c’è una crescita inferiore di idee e innovazione. Si riduce la spesa in Ricerca & Sviluppo, cala il numero di brevetti. È, dunque, sempre più difficile innovare. Anche perché i rendimenti sono decrescenti.
C.M.: Una diminuzione dell’innovazione potrebbe contribuire a una diminuzione della produttività complessiva, ammesso che si riesca a dimostrare che c’è meno innovazione. Tuttavia, è importante considerare anche altri fattori che potrebbero influenzare la produttività, come l’efficienza operativa, l’istruzione e la formazione della forza lavoro, l’infrastruttura e così via. Inoltre, esistono casi in cui la produttività può aumentare anche senza un aumento dell’innovazione, ad esempio attraverso miglioramenti nell’uso delle risorse esistenti o nell’ottimizzazione dei processi esistenti. Si potrebbe anche invocare la finanza buyback che dagli anni Ottanta ha trasformato molte grandi aziende in aziende attente ai loro shareholder e ai vari stakeholder. Giovanni Gozzini (Ecologia del denaro. Finanza e società nel mondo contemporaneo, 2024) afferma che «se i profitti salgono e si licenziano gli operai, è chiaro che la finanza prende il sopravvento sull’economia reale. E che il predominio della finanza si traduce in effetti esiziali (minor crescita, più disoccupazione, meno ricerca, meno innovazione, meno coesione) per la grande maggioranza della società civile».
M.B.: Esiste, dunque, un problema di contesto economico. Tradizionalmente l’innovazione ha un limite nell’essere protetta. C’è un problema di imitazione e concorrenza. Oggi l’economia globale è sempre più monopolizzata da grandi attori che finiscono per inglobare presto start up, per non dire che finiscono per inibire sul nascere le potenzialità dell’innovazione. La concentrazione c’entra con una bassa produttività? Contribuisce a un declino del dinamismo in tutti i settori?
C.M.: Forse sì. Quello che posso proporre è una riflessione partendo da una serie di letture. I modi di produrre, lavorare, comunicare e remunerare che contraddistinguono l’economia delle piattaforme, si stanno diffondendo a tutti i settori del sistema di produzione. Questo processo di diffusione si sta compiendo mutuando dall’economia delle piattaforme le caratteristiche di rete, i sistemi di razionalizzazione dei processi produttivi e le forme di controllo del lavoro attraverso procedure di valutazione e di misura della prestazione lavorativa. Ciò che sta avvenendo nell’odierno sistema di produzione è simile al processo di imitazione dell’innovazione teorizzato da J.A. Schumpeter, come ha evidenziato Philipp Staab (DigitalerKapitalismus, 2019). Per Schumpeter, la dinamica delle economie di mercato è avviata dagli innovatori seguiti dagli imitatori attratti dai profitti generati dall’innovazione. Questo processo si esaurisce con la diminuzione dei prezzi e il conseguente assorbimento dei profitti inizialmente generati dall’innovazione. Se il processo di imitazione dell’economia delle piattaforme caratterizza la dinamica dell’intero sistema di produzione contemporaneo, è anche possibile che tale processo si esaurisca con l’assorbimento del valore aggiunto generato dai principi organizzativi e di funzionamento dell’economia delle piattaforme adottati dagli imitatori. A meno che un’ulteriore e prolungata azione di contenimento dei costi di produzione possa evitare o quanto meno differire il riassorbimento del valore aggiunto. Chiave di volta di questa azione di contenimento è la moderazione salariale attraverso il riconoscimento del solo tempo di erogazione o produzione effettivamente lavorato ai fini della remunerazione.
M.B.: In qualche modo ti poni in rottura e al contempo in continuità con la tradizione marxista. Il fatto che ci sia lavoro gratuito che sostituisce lavoro remunerato fa si che l’impianto secondo cui il lavoro resta uno degli elementi fondamentali nei processi di valorizzazione resta valido?
C.M.: Direi di si. A parte un piccolo particolare. Negli anni Settanta si pensava che si fosse prossimi alla fine del lavoro. Cosa che non è accaduta. Non c’è mai stato tanto lavoro come in questo periodo. Contraddicendo sia il Marx dei Grundrisse sia il Keynes delle Prospettive economiche per i nostri nipoti. Proprio in questo periodo, cioè oggi, secondo l’economista inglese si doveva arrivare a una società in cui si lavora 15 ore alla settimana. In realtà il capitale ha rovesciato questa prospettiva. Che era legittima, considerando lo sviluppo delle forze produttive che ci poteva e ci potrebbe liberare dalla necessità del lavoro. Però non è andata così, perché il capitale ci ha fregati con la moltiplicazione dei bisogni, costringendoci a lavorare sempre di più. I tassi di disoccupazione negli Usa sono pari al 3-4%. Il che non significa che quell’occupazione sia buona occupazione. Il problema, dunque, non è la scomparsa del lavoro, ma l’aumento dell’occupazione precaria. Per esempio, dietro l’economia digitale, c’è un vero e proprio esercito di lavoratori e lavoratrici. Antonio Casilli lo spiega molto bene quando parla degli «schiavi del clic». Dietro la facciata asettica e apparentemente immateriale dell’economia digitale appare il lavoro più materiale che ci sia, quello del dito, del digitus, occultato dalla distanza geografica, dissimulato negli appartamenti dei paesi sviluppati, nelle cucine delle click farm dei moderatori africani, nelle fabbriche filippine dei cleaners, gli spazzini della rete di cui «i social non dicono». Autori come Thomas Fuchs affermano che il tempo di lavoro produttivo sfruttato dal capitale implica tutto il tempo trascorso online dagli utenti. Per lui il tasso di sfruttamento converge verso l’infinito se i lavoratori non sono retribuiti. Stiamo assistendo a una dilatazione del lavoro. Sempre più parte della nostra vita è messa al lavoro, appunto.
M.B.: Veniamo al caso italiano. Potrebbe essere che siamo di fronte a un’ambivalenza. La produttività scende nei paesi occidentali, cioè dove l’automazione ha un’incisività minore, diversamente dai paesi emergenti. Nei paesi più sviluppati crescono i servizi a scapito del manifatturiero, dove però alberga una produttività più bassa. L’Italia si caratterizza come fanalino di coda sulla produttività tra i paesi più ricchi. Dato che la nostra economia si concentra nei segmenti manifatturieri e anche nei servizi a basso valore aggiunto questo spiega i modesti tassi di produttività? E questo è indice di un’arretratezza industriale, ma anche di un modello che va spostandosi verso i servizi a basso valore aggiunto? Siamo arretrati e al contempo anticipatori di tendenza più in generale in via di affermazione?
C.M.: Da perlomeno due decenni si sta affermando un modello capitalistico che è stato definito antropogenetico, cioè di “produzione dell’uomo attraverso l’uomo”, in cui l’attività lavorativa non è finalizzata alla produzione di oggetti, ma a quella di soggetti. Centrato sui servizi alla persona, come sanità, salute, socialità, formazione, cultura, ricerca e formazione, questo modello, dal punto di vista occupazionale e di volume di redditi, sta statisticamente prevalendo sul settore manifatturiero. Negli Usa il consumo di beni sanitari e relazionali è ormai superiore al consumo di beni materiali e durevoli. Si tratta di una tendenza di fondo, effetto di digitalizzazione e automazione, ma soprattutto dovuto alla crescita di bisogni legati alla società della cura e ai mutamenti demografici. Il problema è, semmai, capire in che misura questo modello è riconosciuto anche dal punto di vista dei redditi. In questi settori bisognerebbe investire molto di più, contrariamente a quanto si sta facendo, il che significa fare i conti con la cosiddetta «malattia dei costi» di Baumol, l’economista che sviluppò questo concetto negli anni ‘60. La malattia dei costi di Baumol si manifesta nella cura, come in altri settori antropogenetici (ad esempio nell’educazione), in diverse maniere. La cura è spesso un settore intensivo di lavoro, dove la presenza umana è insostituibile e difficilmente automatizzabile. Ciò significa che, mentre in altri settori si possono implementare tecnologie avanzate per aumentare l’efficienza e ridurre i costi, nella cura e nei servizi alla persona in generale questo processo è limitato, portando a un aumento graduale dei costi nel tempo. Infatti, in questi settori i salari tendono ad aumentare per tenere il passo con quelli nei settori che registrano una crescita maggiore della produttività, contribuendo all’aumento complessivo del costo dei servizi rispetto a quello dei beni. La fragilità dei sistemi di cura può portare a una trascuratezza nei confronti dei più vulnerabili, aggravando ulteriormente la crisi in questi servizi alla persona senza riuscire ad aumentare la produttività. Da qui la cosiddetta malattia dei costi interna al modello antropogenetico. Queste tendenze chiamano in causa criteri diversi nella misurazione del lavoro e della sua produttività. Non si può applicare il medesimo criterio di misurazione valido per il capitalismo manifatturiero otto-novecentesco. L’aumento della produttività oggi è sbilanciato verso alcuni settori dove puoi far lavorare di più le persone, segmentando il lavoro, ma in parti sempre più centrali della società l’aumento della produttività è condizionato e limitato dalla natura del lavoro. Dove questo non produce beni, ma dove il lavoro è il prodotto stesso. Dove la cura e la sua qualità si inverano nel lavoro. Si tratta di concettualizzare principi diversi per ipotizzare una sorta di «produttività non conforme», per dirla con Chiara Valerio (La tecnologia è religione, 2023).
M.B.: Direi che occorre proporsi un duplice obiettivo. Da un lato redistribuire la produttività dove ancora si riesce a misurare con una relativa facilità: penso al manifatturiero e alla produzione tradizionale. Ma anche in quei settori dove questi incrementi di produttività non si possono misurare e in realtà la produzione contribuisce a creare ricchezza, in particolare benessere sociale. Quindi una sorta di duplice redistribuzione della produttività, misurabile o meno che sia. Una difficile sfida per affermare una produttività non convenzionale.
C.M.: È chiaro che il ruolo dello Stato come agente di questa duplice redistribuzione diventa cruciale. Qui si determinano delle urgenze che violano la disciplina di bilancio. Esiste l’opzione austeritaria che colpisce la spesa, in definitiva colpendo le vittime predestinate considerate all’origine della malattia dei costi di Baumol. Esiste invece un’altra opzione, quella che mira a redistribuire la ricchezza prodotta, prendendo in conto socialmente i costi a partire da tutto il lavoro non riconosciuto. Bisogna scardinare il concetto di produttività per svelare nuovi criteri
di giustizia sociale.
1 Christian Marazzi, economista, è autore di saggi sulle trasformazioni del mondo del lavoro e dei processi di finanziarizzazione.
2 Marco Bertorello lavora nel porto di Genova, collabora con il manifesto ed è autore di saggi su economia, moneta e debito.
Pubblicata su “Jacobin Italia” (11 giugno 2024)