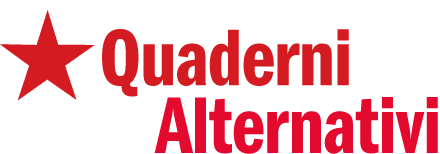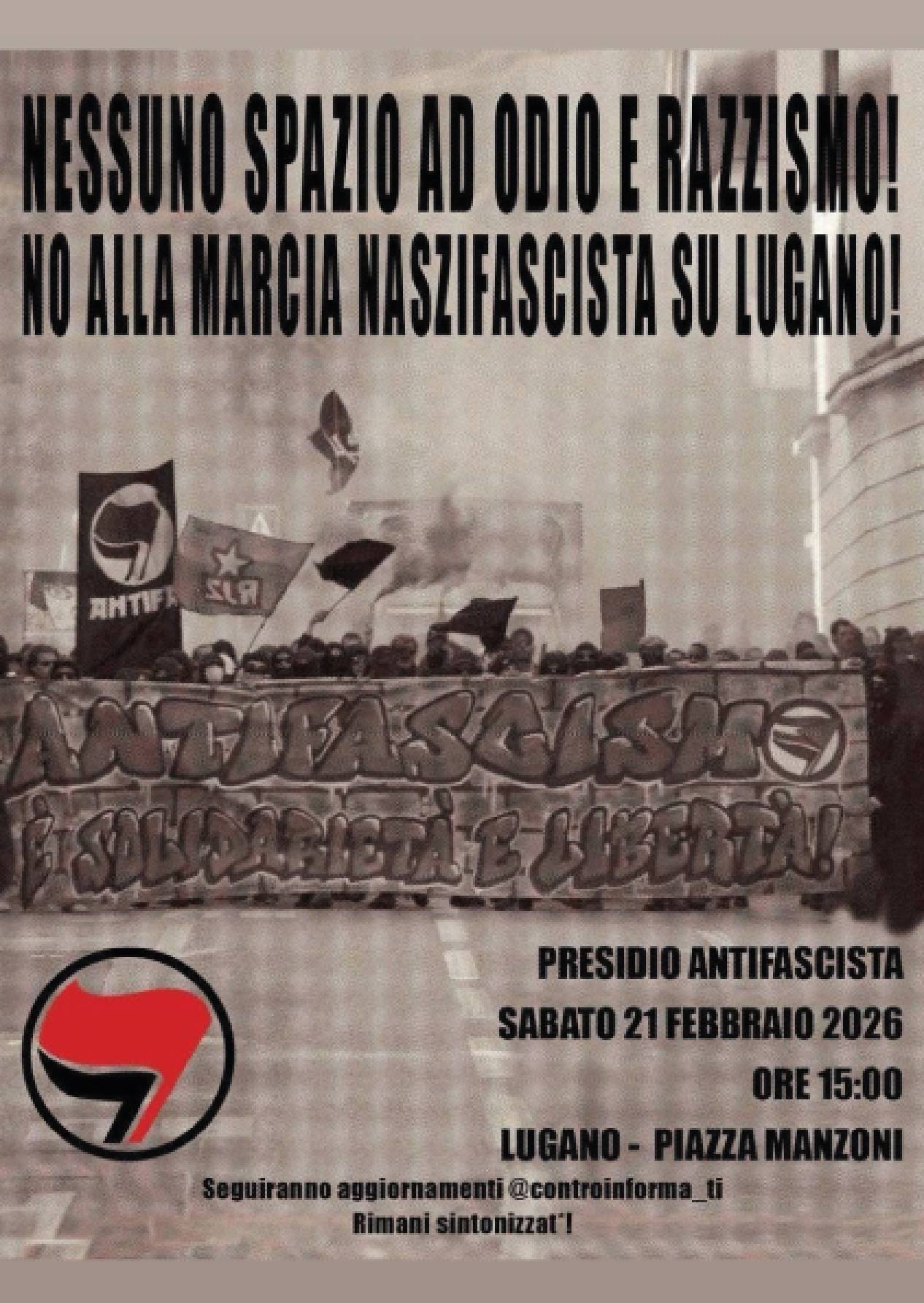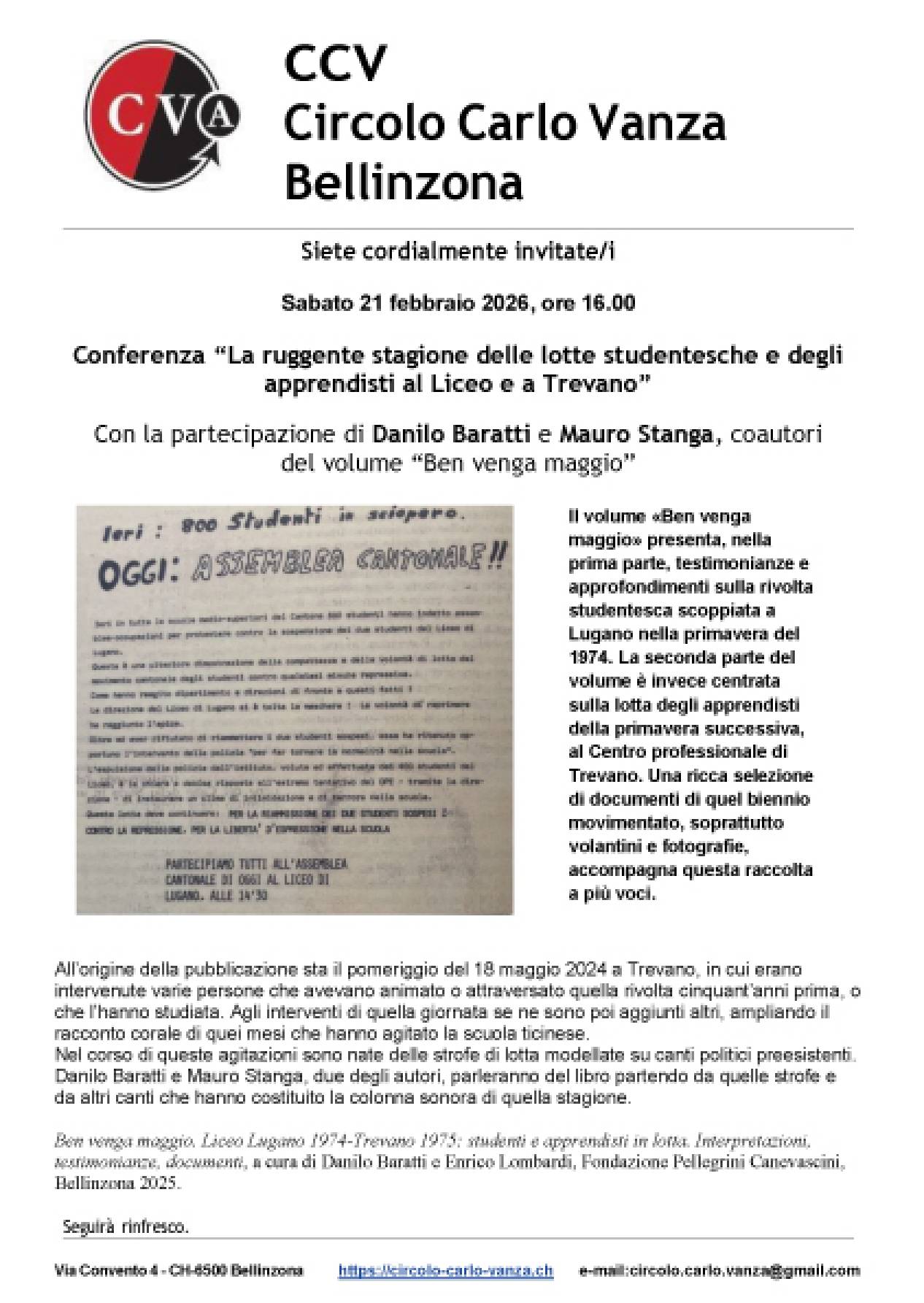Sono circa due milioni e mezzo, più di un quarto della popolazione, le persone che vivono in Svizzera e che non posseggono il passaporto rossocrociato.
Oltre quattrocentomila di queste sono nate e cresciute in questo Paese. Tuttavia esse non fruiscono dei diritti di cittadinanza e sono quindi escluse dalla partecipazione attiva al processo democratico e decisionale che caratterizza il federalismo elvetico.
La naturalizzazione permette di essere riconosciuti come membro a pieno titolo della comunità, generando un profondo senso di appartenenza, promuovendo la coesione sociale e il rafforzamento della democrazia.
“Per evitare di fare discriminazioni e consolidare la legittimità del suo sistema democratico, la società migratoria svizzera necessita di un diritto sulla cittadinanza più inclusivo”. È questa una delle conclusioni a cui giunge uno studio recente realizzato da Rosita Fibbi, Barbara von Rütte e Philippe Wanner su incarico della Commissione federale della migrazione. Gli autori hanno esaminato gli effetti della nuova legge sulla cittadinanza del 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, su un arco temporale che va dall’entrata in vigore del nuovo testo normativo al 2020, durante il quale le domande di naturalizzazione ordinaria sono state trattate contemporaneamente in base al diritto previgente e al nuovo testo di legge.
L’approccio dello studio ha permesso di confrontare l’accesso alla procedura di naturalizzazione fondato sulle norme previgenti e su quelle entrate in vigore nel 2018. Ne è emerso un quadro per nulla incoraggiante. La revisione totale del 2018, invece di semplificare la complessa procedura di naturalizzazione ordinaria, ha limitato ulteriormente l’accesso alla procedura di naturalizzazione. Per acquisire la cittadinanza svizzera, i richiedenti devono oggi soddisfare requisiti formali e materiali. In primo luogo, ed è forse l’aspetto più limitante e restrittivo della nuova legislazione, per avviare la procedura di naturalizzazione occorre essere in possesso del permesso di domicilio, ovvero il permesso “C”. Un qualunque altro statuto di soggiorno, non permette, come avveniva in passato, di accedere alla procedura di naturalizzazione. Solo i cittadini di Paesi con i quali la Svizzera ha sottoscritto accordi di domicilio riescono ad accedere a questo permesso di soggiorno in tempi relativamente brevi (solitamente cinque anni) e se tutte le condizioni per ottenerlo sono soddisfatte, il che non è così scontato. Per gli altri, ovvero la maggioranza dei potenziali richiedenti la cittadinanza, i tempi per l’ottenimento di un permesso di domicilio possono essere biblici.
Sempre dal profilo formale, il richiedente deve aver soggiornato in Svizzera per dieci anni prima di poter richiedere il passaporto svizzero. Sembrerebbe un miglioramento rispetto alla precedente normativa che imponeva un soggiorno di dodici anni. E invece non è così, perché vengono computati per intero solo i soggiorni effettuati sulla base di un permesso di dimora, ovvero sulla base di un permesso “B”. Gli anni di soggiorno come richiedente asilo, come beneficiario della protezione provvisoria – lo statuto “S” conferito nel 2022 ai rifugiati provenienti dall’Ucraina – o con permessi temporanei (i permessi “L”) non sono più computati. Dal profilo materiale, per contro, il richiedente il passaporto svizzero, deve dar prova di “un’integrazione riuscita”, oltre a dimostrare di avere familiarità con le condizioni di vita in Svizzera e di non compromettere la sicurezza interna e esterna del Paese. Un cambio di paradigma, rispetto alla precedente legge, che chiedeva che i richiedenti avessero acquisito familiarità con gli usi, i costumi e le condizioni di vita in Svizzera. L’integrazione riuscita, per così dire, veniva dopo, perché solo un’appartenenza piena e senza limiti ai diritti politici, civici e sociali può permettere una piena integrazione e un’inclusione sociale riuscite.
Lo studio ha inoltre dimostrato che la nuova procedura è particolarmente selettiva – una legge classista, diremmo noi perché vi accedono più facilmente i richiedenti più istruiti e con un livello socio economico più elevato. Per questi motivi appare di fondamentale importanza la riuscita dell’iniziativa popolare “Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)” per la quale hanno diritto alla concessione della cittadinanza su domanda coloro che: soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni; non sono stati condannati ad una pena detentiva di lunga durata; non compromettono la sicurezza interna e esterna della Svizzera; hanno conoscenze di base di una lingua nazionale. Pochi criteri, oggettivamente identificabili, che sottraggono l’acquisizione della naturalizzazione all’attuale iniquità e complessità normativa e alla disparità che vige tra un Cantone e l’altro.
Se questi criteri sono soddisfatti, il richiedente ha diritto alla concessione della cittadinanza e non vi è più alcun margine di apprezzamento da parte dell’autorità preposta per rifiutare la naturalizzazione. È dunque importante che l’iniziativa abbia successo, non foss’altro che per riflettere sull’approccio attuale alle tematiche legate al diritto di cittadinanza e contrastare una politica migratoria che si fonda sul rifiuto e sull’esclusione dell’altro.