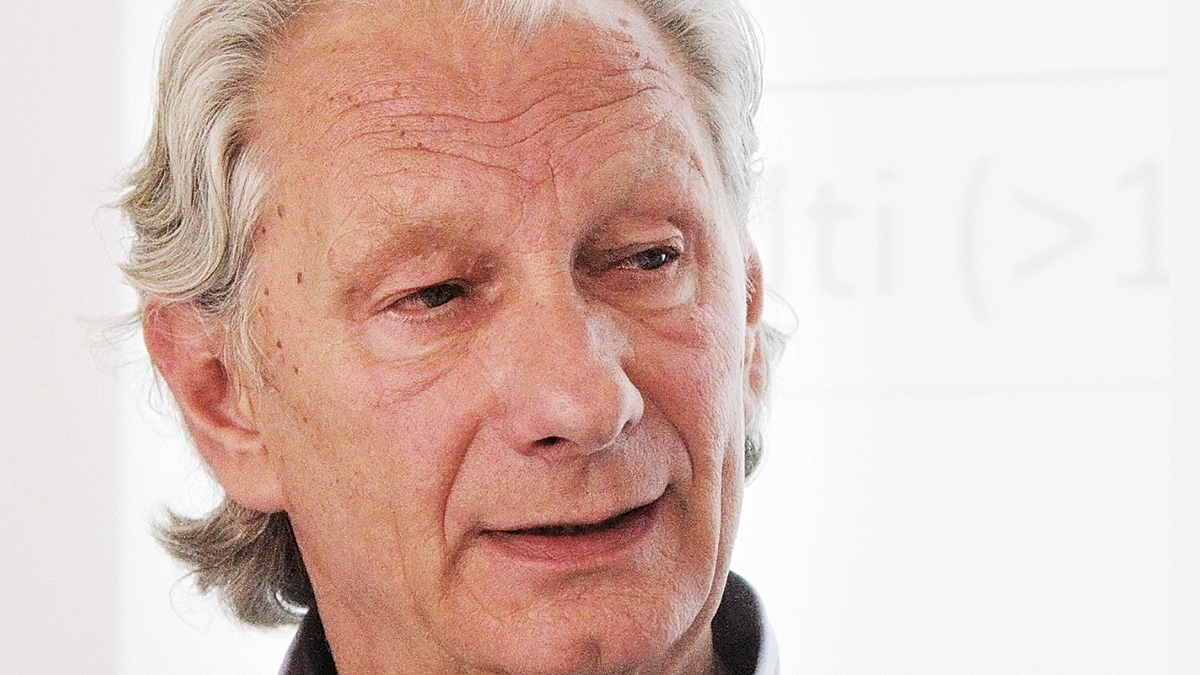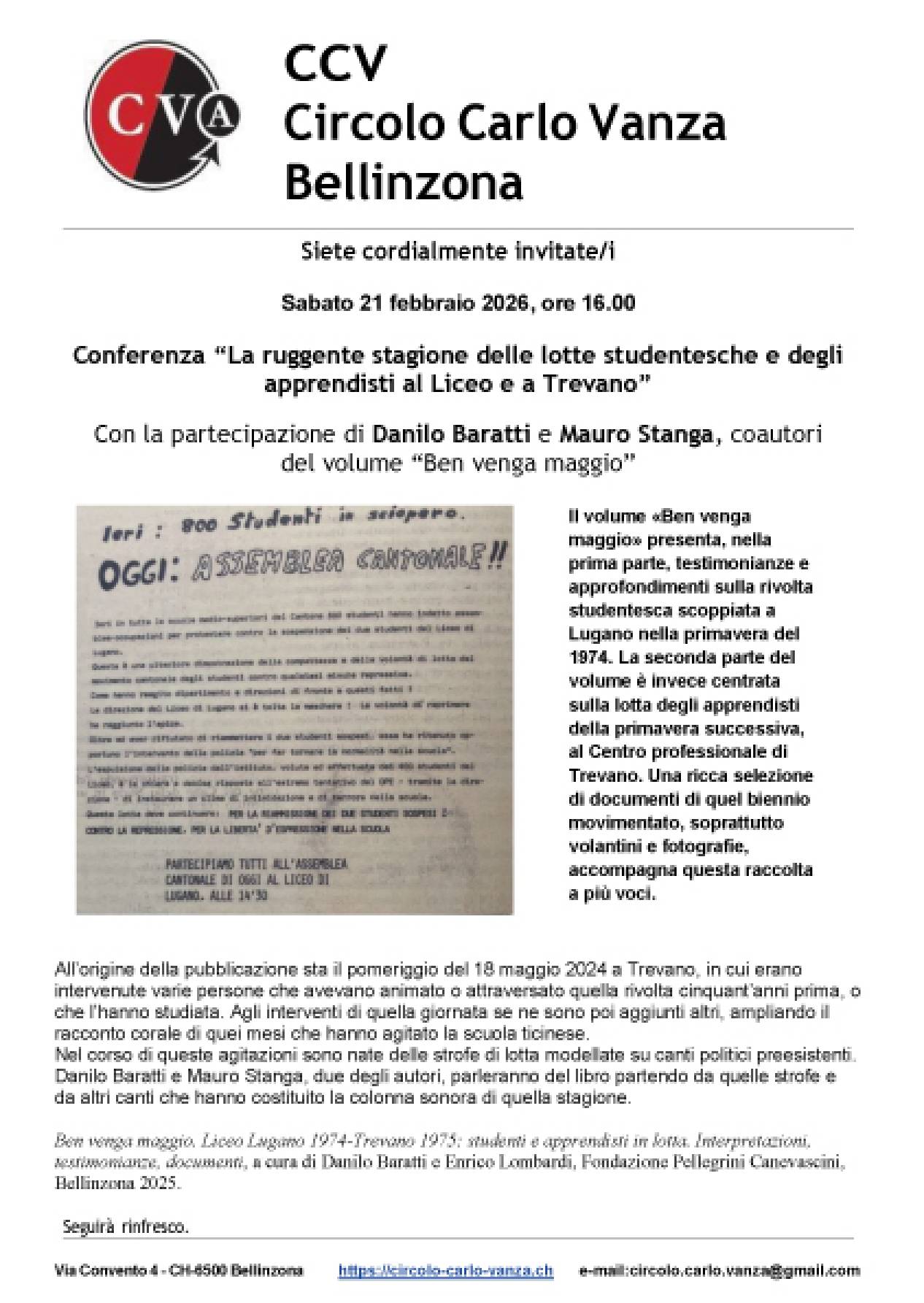Al comune mortale la politica economica erratica di Trump sembra totalmente senza senso. In un articolo che hai pubblicato nella Regione, tu sostenevi però che un senso c’è. Lo stesso ha sostenuto nel Manifesto (05.04.2025) Francesco Raparelli. Ci spieghi qual è questo senso?
Sì, credo ci sia del metodo nella follia trumpiana, per parafrasare il detto shakespeariano, anche se a volte è molto difficile destreggiarsi nei labirinti delle decisioni e contro decisioni della sua amministrazione. Atteniamoci però al suo programma, quello esibito durante la campagna elettorale e che, con coerenza (qualità molto apprezzata dal suo elettorato), persegue dal primo giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. Oltre a ridurre drasticamente lo Stato sociale e aumentare la spesa militare, Trump vuole re-industrializzare l’America, vuole cioè ricostruire l’economia industriale che nel corso dei decenni della globalizzazione è stata distrutta a causa delle delocalizzazioni delle grandi imprese statunitensi verso paesi, in particolare ma non solo la Cina, con bassi salari e deboli Stati sociali (e quindi bassa pressione fiscale).
Basta leggere il libro del suo vice J.D. Vance, Elegia americana (2016), per farsi un’idea precisa di cosa la de-industrializzazione abbia significato per milioni di americani, ad esempio nella rust belt, la regione mineraria tra gli Appalachi e i Grandi Laghi, in termini di povertà, depressione, sfascio delle famiglie, dipendenza da oppiacei (e Fentanyl), ma anche abbandono al loro destino da parte del Partito democratico, più preoccupato a ottenere il consenso dei ceti medio-alti metropolitani emergenti dai processi di finanziarizzazione.
I dazi, la politica tariffaria annunciata in pompa magna il 2 di aprile, poi sospesa per novanta giorni, poi ridimensionata (salvo per la Cina, almeno per il momento), sono l’arma negoziale con la quale Trump cerca di convincere Stati e imprese a investire negli Stati Uniti. Novartis e La Roche sono stati tra i primi a rispondere all’appello. Sappiamo che cosa è successo da quel momento in poi: crollo delle borse, crollo dei prezzi dei Buoni del Tesoro (non si sa bene se provocato dalle vendite di Treasury Bonds da parte dei giapponesi o dei cinesi, probabilmente da entrambi), con conseguente aumento dei rendimenti, cioè dei tassi d’interesse sulle obbligazioni pubbliche e private (che poi si ripercuotono sui tassi ipotecari) e, cosa senza precedenti, svalutazione del dollaro, che Trump auspica per rilanciare le esportazioni, certo, ma non come espressione della perdita di fiducia da parte del resto del mondo nei confronti della moneta internazionale per eccellenza. Perché? Perché i dazi, e che dazi!, di Trump portano diritti all’inflazione all’interno degli Stati Uniti, il che impedisce alla Federal Reserve di abbassare i tassi di interesse, cosa che invece Trump vuole assolutamente, anche per alleggerire un debito pubblico destinato a crescere enormemente a causa dei tagli fiscali ai ricchi.
Una concatenazione di fatti-eventi che conduce alla recessione o, se tutto va bene, alla stagflazione, in ogni caso ben lontani dalla crescita del benessere per tutti, alla golden age promessa dal neo-presidente. Quando si dice che le guerre commerciali, di fatto, sono guerre di classe non si è lontani dalla verità.
Possibile che uno scenario del genere non fosse stato contemplato dai consiglieri economici della nuova amministrazione, in particolare dal suo principale consigliere economico Stephen Miran, la vera mente dietro la svolta trumpiana? Possibile che dazi, inflazione, diminuzione dei tassi di interesse, svalutazione del dollaro, non fossero pensati come un programma logicamente impossibile da realizzare? Infatti, puntualmente, a cento giorni dal suo insediamento e senza neppure che tutti i dazi siano entrati in vigore, i segnali di recessione ci sono tutti, e la stessa amministrazione lo ammette, anzi dice che “un po’ di sofferenza” è il prezzo da sopportare per raggiungere gli obiettivi di “crescita e di ricchezza per tutti”. Solo la recessione può ridurre contemporaneamente l’inflazione, i tassi di interesse, e svalutare il dollaro.
È proprio qui che si invera il metodo, nel fatto che per raggiungere questi obiettivi occorre impoverire milioni di cittadini, anche quelli che hanno votato Trump. Col forte rischio, però, che il popolo americano, anche quello MAGA, insorga. Non dimentichiamo che, oltre all’aumento sicuro dei prezzi dei beni di consumo importati, il 60% degli americani detiene direttamente o indirettamente (tramite fondi pensione) titoli azionari e obbligazionari. Sono convinto che il vero progetto (politico, prima ancora che economico) di Trump – e tutto va decisamente in questa direzione – sia l’instaurazione di un regime autocratico-dittatoriale, extra-costituzionale, per raggiungere il quale occorre provocare una rivolta sociale tale da giustificare la sospensione dello stato di diritto per aggirare tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dei suoi obiettivi liberisti, autocratici e nazionalisti. La crisi economica è il passaggio necessario per effettuare questo cambio di regime. Ecco perché There’s method in this madness.
Al momento attuale Trump ha messo in pausa per tre mesi le sue decisioni che ha annunciato al “Liberation Day”. Indubbiamente di fronte al crollo di Wall Street, i grandi baroni della finanza e i miliardari della Silicon Valley l’hanno obbligato a fare almeno momentaneamente marcia indietro. Cosa ci si può ragionevolmente aspettare dopo questi 90 giorni?
È verosimile, come scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera del 3 maggio, che l’amministrazione Trump comprenda – adesso – i suoi errori sui dazi (gli effetti collaterali, direi), anche perché il flusso di merci tra le due economie più grandi, tra gli Stati Uniti e la Cina, ma anche la Ue, sta rallentando fortemente. Secondo Gene Seroka, direttore del porto di Los Angeles, “Iniziamo a vedere un rallentamento del flusso dei cargo.Tra due settimane (cioè a metà maggio) gli arrivi scenderanno del 35%, dato che essenzialmente tutte le spedizioni dalla Cina per i grandi rivenditori al dettaglio (Home Depot, Target e Wallmart) e per i produttori si sono interrotte”.
La paralisi dei porti e della logistica sta innescando licenziamenti a catena fra i colletti blu, esponendo i 300 mila operai dello scalo di Los Angeles e milioni di camionisti, magazzinieri e addetti ai negozi in tutta America. Per non parlare del settore automotive e di tutte quelle imprese americane che, assemblando i loro prodotti in Cina, rischiano di vedersi sommare i dazi in uscita (125% sulla componentistica esportata verso la Cina) e in entrata (145% dei beni finiti importati negli USA dalla stessa Cina). Per questo ora si corre ai ripari parlando di “disgelo con la Cina” (ma la vera trattativa non è ancora cominciata) e di negoziati sui dazi con l’Europa “prossimi ad una soluzione” (al momento non c’è nulla di concreto), il che è bastato a far schizzare le borse di tutto il mondo, al punto da azzerare le perdine accumulate a partire dal Liberation day. “La domanda a questo punto dunque non è se Trump voglia fare marcia indietro, perché non ha scelta. È quanto tempo ha per riuscirci, prima che i danni all’economia americana si facciano ancora più seri”. E tra i danni causati dai dazi, da non trascurare, c’è la corsa al contante da parte delle corporation (corporate rush for cash) per far fronte all’aumento dei prezzi delle importazioni, una domanda di contante che inizia a stressare il sistema creditizio.
Resta il fatto che i dazi, pur ridimensionati, resteranno anche dopo i 90 giorni di tregua, anche perché, come arnese negoziale, servono a Trump per convincere le multinazionali ad investire negli USA. Il problema, anche in questo caso, è però il tempo: come ricordava il Wall Street Journal, per avviare una nuova produzione ci vogliono anni, durante i quali gli effetti negativi su salari e occupazione causati dai dazi non saranno facilmente gestibili. E resteranno, i dazi, anche perché Trump vuole, esattamente come si fa con le imposte, usare le entrate per abbattere il debito federale.
Abbastanza scalpore ha suscitato a sinistra il fatto che la United Auto Workers (UAW), il principale sindacato del settore automobilistico negli USA e ultimamente profilatosi abbastanza su posizioni radicali, ha sostenuto la posizione di dazi da parte di Trump per le importazioni di automobili. È semplicemente una reazione da “aristocrazia operaia” (Lenin) o come te la spieghi?
Hanno ragione gli amici de il manifesto (2 aprile 2025) a considerare un abbaglio il sostegno alla politica dei dazi trumpiana. Se ci sarà un effetto positivo dei dazi sull’occupazione nel settore auto è ancora ignoto, dato che molto dipenderà dalla decisione delle imprese straniere e dall’impatto che l’aumento dei prezzi avrà sulla domanda. In passato, per aggirare le restrizioni all’importazione di auto (il contingentamento voluto da Reagan negli anni ‘80), i produttori asiatici aprirono diversi stabilimenti negli Stati Uniti, ma per la maggior parte questi stabilimenti furono aperti negli stati del Sud, dove i sindacati sono di fatto banditi e dove i salari e i benefit sono molto più bassi di quelli presenti nelle fabbriche sindacalizzate degli stati del Nord, ciò che aggravò ulteriormente la competizione al ribasso fra i lavoratori. Lo Uaw, d’altronde, ha sempre osteggiato le politiche di libero scambio, come quelle che portarono al North American Trade Agreement (NAFTA), che creava un’area di libero scambio con Canada e Messico con protezioni sociali e ambientali molto limitate. È indubbio che negli ultimi due decenni la delocalizzazione di parti importanti della filiera automobilistica abbia portato alla perdita di circa un terzo dei posti di lavoro del settore, come pure una moderazione salariale causata dal solo ricatto della delocalizzazione.
L’apertura dello Uaw all’amministrazione Trump è, comunque, incomprensibile alla luce delle centinaia di migliaia di licenziamenti indiscriminati sotto l’egida del Doge guidato da Elon Musk e della repressione delle organizzazioni sindacali nel settore pubblico, privando i lavoratori del diritto alla contrattazione collettiva. Di fronte a quella che si annuncia come una delle più grandi offensive anti-labor della storia degli Stati uniti, la posizione dello Uaw, che fa seguito a quella dei Teamster, rischia di aggravare la divisione del fronte sindacale americano, che negli anni dell’amministrazione Biden, con un’ondata di scioperi importanti, aveva dato segnali concreti di ripresa. Più che di reazione (leniniana) dell’“aristocrazia operaia”, parlerei di “nazionalismo operaista”, una forma di resistenza un po’ datata visti i cambiamenti della composizione socio-economica della classe operaia nel corso degli ultimi decenni post-fordisti. Il sindacato dei portuali californiani, l’International Longshore & Warehouse Union, sta attaccando diversamente il governo Trump: “I dazi sono tasse. Queste e altre scriteriate, miopi misure hanno iniziato a devastare i lavoratori americani”. Mi sembra piuttosto questa la linea da seguire.
Mentre quasi tutto il mondo, come ha detto spudoratamente Trump, “gli stava baciando il deretano”, i cinesi hanno risposto colpo su colpo, non arretrando di un millimetro. Pensi che la Cina abbia la forza di resistere all’attacco economico di Trump? Come valuti ad ogni modo i possibili danni per l’economia cinese?
Credo che i cinesi abbiano ragione nel definire le misure di Trump come la reazione disperata di una “tigre di carta”. Infatti, non è vero, come sostiene Scott Bessent, l’influente segretario al Tesoro, che se gli Stati uniti esportano un quinto di quanto i cinesi esportano agli americani, la Cina è in posizione sfavorevole. È esattamente il contrario: il fatto che la Cina esporti di gran lunga di più verso gli US è in realtà una fonte di forza, non di debolezza. Gli Stati uniti non acquistano prodotti cinesi per spirito di carità, ma perché gli americani vogliono quel che i cinesi producono. Di conseguenza, se questi prodotti diventano più cari o spariscono completamente dagli scaffali, saranno gli americani a soffrire di più (i dazi sono pagati dagli importatori, non dagli esportatori). Più della metà degli smartphone venduti in America sono iPhone e l’80% di questi sono costruiti in Cina. L’80% degli air conditioner di tutto il mondo è prodotto in Cina (e una gran parte di questi finisce negli US), così come il 75% delle bambole e delle biciclette importate negli Stati uniti proviene dalla Cina. La Cina produce circa la metà degli ingredienti che finiscono negli antibiotici, da cui gli americani sono fortemente dipendenti. Ha pure un quasi monopolio sulle terre rare (ne controlla oltre il 60%). E, last but not least, i cinesi sono i secondi detentori, dopo il Giappone, di Buoni del Tesoro statunitensi (molto utili quando il mercato è sotto pressione!).
Il mercato americano rappresenta circa il 14% delle esportazioni cinesi (550 miliardi di dollari), ma l’economia cinese, nel suo insieme, vale qualcosa come 14-15 mila miliardi di dollari. Come dire che le tariffe trumpiane sono sì un fastidioso inconveniente, ma certamente non una minaccia per l’economia cinese. In un Paese guidato dal Partito comunista cinese, la popolazione è sicuramente meglio preparata ad assorbire un periodo di sofferenza economica che non negli Stati uniti.
Quindi, calma e gesso.
Da ultimo, non dimentichiamo, come ha scritto Roberto Saviano sul Financial Times (3 maggio 2025), che le tariffe americane sono un vero e proprio regalo al crimine organizzato. Sempre, nella storia degli Stati Uniti, le politiche protezionistiche sono state sfruttate dalla mafia per sviluppare le attività di contrabbando. I cinesi, fra l’altro, gestiscono una quarantina di porti in America Latina, porti che verranno utilizzati per esportare negli US merci cinesi che appariranno prodotte in America del Sud. Sarà contento il defunto mentore di Donald Trump, Roy Cohn, che negli anni ’70 rappresentò tutti i più grandi boss della mafia, da Galante, a Gambino, alla famiglia Genovese. Economia criminale, fase suprema del capitalismo liberista?