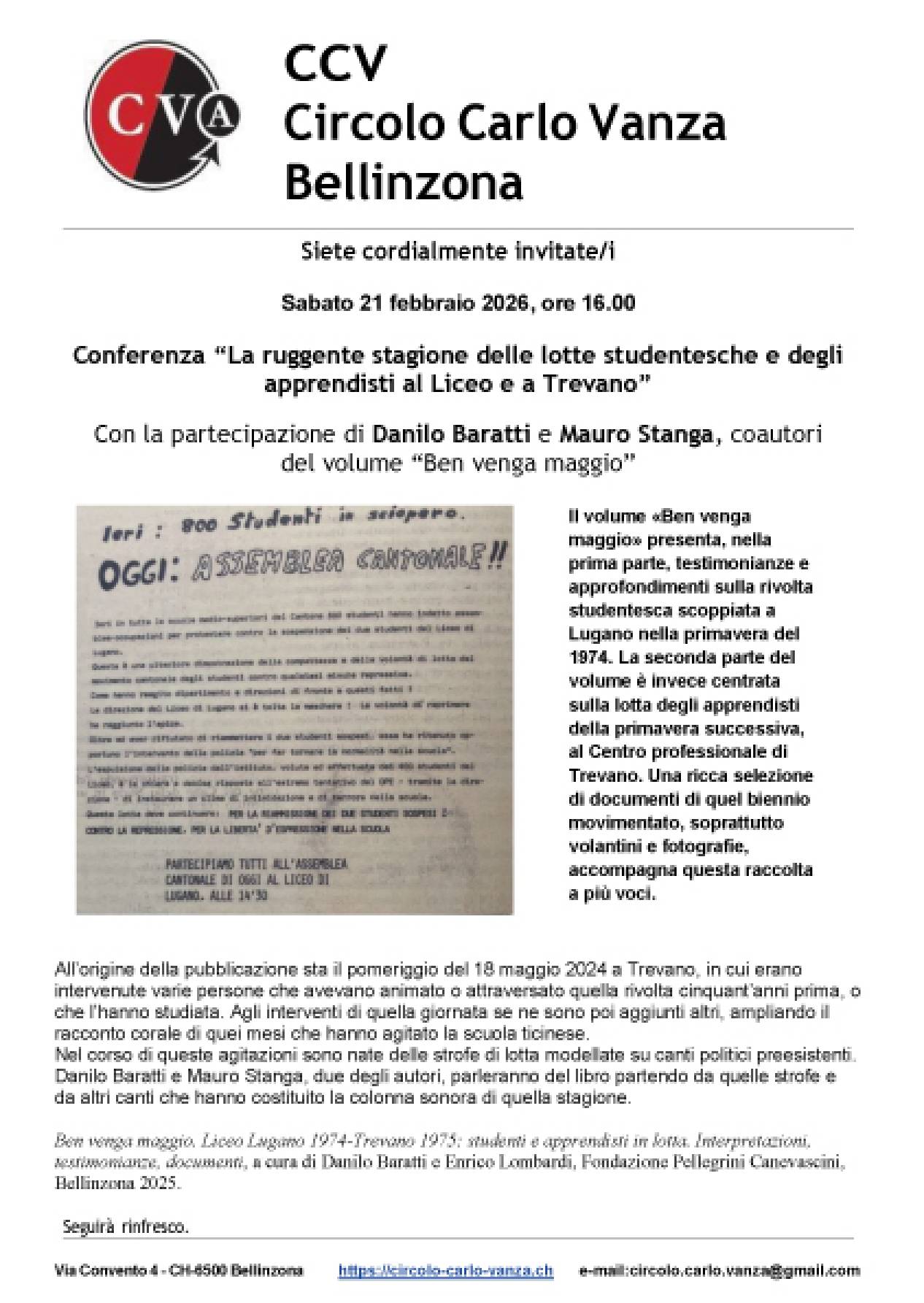La telefonata di Donald Trump a Vladimir Putin sembra aver accelerato i negoziati per la tregua in Ucraina ma il nodo centrale sul quale i due belligeranti sono ancora distanti è lo status dei territori occupati. Ormai è evidente che le altre questioni sono secondarie e che Mosca e Kiev sono disposte ad ammorbidire le proprie posizioni in cambio di un riconoscimento sul punto fondamentale. L’incontro di metà maggio a Istanbul non ha portato alla svolta tanto attesa, nonostante le delegazioni di Russia e Ucraina si siano incontrate per la prima volta dopo quasi tre anni. È un primo passo, certo, ma pieno di ostacoli e valutazioni contingenti. Pochi giorni dopo Trump ha provato a intestarsi quei timidi progressi e le versioni sulle parole che ha scambiato nelle quasi due ore in cui è rimasto al telefono con l’omologo russo si dividono nettamente.
Da un lato c’è chi, come l’ex ambasciatore Usa in Ucraina, Steven Pifer, il Financial Times o Axios ritengono che il tycoon abbia sostanzialmente lasciato il campo libero a Putin. Un ultimo tentativo prima di abbandonare il ruolo di arbitro che Washington si è auto-assegnata. Dall’altro si posizionano quanti credono che alla fine gli Usa riusciranno a convincere Mosca a qualche tipo di cessate il fuoco, magari in cambio di laute concessioni. Tuttavia c’è una questione fondamentale. Finora l’Ucraina ha ceduto alle pressioni della Casa Bianca, oltre che all’evidente necessità di dare respiro ai suoi uomini al fronte, ma sui territori occupati Zelensky non potrà essere altrettanto accondiscendente. Ne va del futuro del suo Paese e del suo futuro politico.
Partiamo dalle rivendicazioni ufficiali. Nell’autunno del 2022 Vladimir Putin ha inserito gli oblast di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson nella costituzione russa come parte integrante del territorio della Federazione. La Crimea vi era già stata inserita dal 2014. Ora i vertici russi, dal presidente ai funzionari, continuano a ripetere come un ritornello che «qualsiasi tregua in Ucraina deve eliminare le cause profonde che hanno fatto scoppiare la guerra». A quanto dice il Cremlino queste motivazioni vanno ricercate nell’aggressività del «regime neonazista di Kiev» contro i russofoni, nell’allargamento della Nato a est e nelle minacce strategiche per il Paese.
Per sentirsi sicura Mosca esige che l’Ucraina sia tenuta fuori dalla Nato per sempre, che il suo esercito sia ridotto (è spesso circolato il numero di 80mila unità) e privato dei rifornimenti occidentali e che le forze armate ucraine si ritirino di almeno 15 km dalle loro attuali posizioni per creare una zona cuscinetto che impedisca eventuali recrudescenze delle ostilità. Per mesi, inoltre, si è anche parlato della necessità di allontanare Zelensky dalla presidenza ucraina in quanto politico ostile, ma con l’inasprirsi del conflitto è diventato evidente che i problemi per il presidente ucraino nasceranno anche dall’interno e che quando si terranno le elezioni la sua nomina non è affatto scontata. Dunque Mosca ha abbandonato questa richiesta, concentrandosi sulle questioni pratiche. Ottenere i territori occupati e, magari, anche la parte delle regioni reclamate che non è stata occupata per Putin sarebbe una vittoria senza precedenti. Significherebbe il riconoscimento del fatto che l’operazione militare speciale ha avuto l’esito sperato: contribuire all’espansione neo-imperiale della Russia.
Dal canto suo, Volodymyr Zelensky continua a ripetere che l’unica pace possibile è una «pace giusta», pur dichiarandosi aperto a «trattative dirette» con Mosca e a «compromessi». Cosa voglia dire una «pace giusta» è stato spiegato chiaramente dopo l’incontro con l’omologo turco Erdogan alla vigilia del summit di Istanbul: «ripristino dell’integrità territoriale». Ma non si può garantire il futuro del Paese senza adeguate garanzie di sicurezza e infatti Kiev ha chiesto per anni l’ingresso nella Nato. Nonostante i proclami altisonanti – alla riunione per gli 80 anni dell’Alleanza a New York è stato stabilito che il percorso di adesione dell’Ucraina nella Nato è «irreversibile» – in questi tre anni l’eventuale ingresso dello stato est-europeo nel Patto Atlantico è diventato sempre meno probabile, fino a sparire completamente da ogni agenda programmatica con l’elezione di Donald Trump.
Se da un lato includere Kiev nel gruppo vorrebbe dire correre il rischio di trascinare la più grande alleanza militare del mondo in una guerra con una potenza atomica, dall’altro il tycoon non ha mostrato alcun interesse a uno scontro con la Russia. Al contrario, fin dal suo insediamento le mosse diplomatiche di Washington sono state tutte orientate alla riapertura delle relazioni diplomatiche con il Cremlino, in attesa di riaprire quelle commerciali sulle materie prime (dando la precedenza a idrocarburi e risorse minerarie). Nel corso di questi anni i vertici ucraini anche reclamato riparazioni di guerra e tribunali speciali per il Cremlino e funzionari russi di più alto livello, ma al momento questa eventualità sembra definitivamente tramontata.
Queste le due posizioni sulla carta, ma come in ogni trattativa si chiede il massimo per ottenere almeno ciò che si reputa indispensabile. E a proposito di necessità il discorso cambia radicalmente. Putin ha bisogno di ottenere qualcosa che sia palesemente presentabile come una vittoria, laddove Zelensky vuole dimostrare ai suoi che non ha ceduto all’invasore. In entrambi i casi lo status post-bellico dei territori occupati deciderà il futuro dei presidenti. Per Putin si tratterebbe di una prova della rinnovata grandezza russa. Abbiamo fatto la guerra per i nostri interessi, l’abbiamo vinta e ora il mondo ci rispetta e ci teme. Ma la volontà di legittimazione del Cremlino è tutta rivolta all’esterno, il problema di eventuali critiche interne neanche si pone al momento in quanto nessuna figura politica è in grado di inficiare il potere putiniano.
Il presidente ucraino invece ha ben altri problemi: il futuro del suo Paese è in seria discussione, oppresso tra i fuochi della depressione economica post-bellica, l’insicurezza derivante dagli strascichi della guerra, la perdita di territori economicamente molto rilevanti e la razzia da parte delle aziende Usa, di cui l’Accordo sulle terre rare è solo un assaggio per quanto già potenzialmente devastante, ed europee. Il presidente ucraino, inoltre, deve evitare che i militari lo esautorino, che gli avversari politici lo etichettino come colui che ha smembrato il Paese. Sono lontani i tempi in cui il mondo gli tributava ovazioni e la rivista Time gli riservava copertine. Risulta evidente che per la parte ucraina al momento ci sono molti più rischi che per quella russa. Senza contare che la situazione sul campo continua a essere favorevole alle forze armate del Cremlino in lento avanzamento sul fronte est e su quello sud-est.
A Kiev la tregua serve, continuare a combattere la guerra a questi ritmi diventerà presto insostenibile senza un supporto militare maggiore e, soprattutto, continuativo da parte dell’occidente. Putin invece temporeggia, vuole permettere ai suoi uomini sul campo di avanzare il più possibile per avere più chilometri quadrati da includere nei negoziati. «Non è chi sta perdendo che può dettare le condizioni per i negoziati» aveva dichiarato il presidente della Duma (la camera bassa russa) in risposta alle pressanti richieste ucraine sulla presenza di Putin a Istanbul. Il presidente alla fine non si è presentato e ha inviato una delegazione di basso livello svuotando completamente di senso una giornata che era nata come un momento di svolta epocale e si è risolta come il primo incontro di una lunga serie. Nel quale, a parte lo scambio di mille prigionieri di guerra per parte, non si è deciso nulla. Ora i due governi stanno preparando delle liste di richieste da presentare al nemico, una volta vagliate le rispettive posizioni si valuteranno i passi successivi.
Al momento l’unica cosa certa è che l’incontro tra Putin e Zelensky è ancora lontano. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che «solo quando si troverà una base comune» si potrà procedere alla redazione di un «memorandum» tra i belligeranti. Questo testo sarà la vera base per il cessate il fuoco. Ma «non ci sono scadenze e non possono essercene – ha affermato Peskov il giorno dopo la telefonata tra il suo capo e Trump – è chiaro che tutti vogliono farlo il più velocemente possibile, ma, ovviamente, il diavolo si nasconde nei dettagli».
Gli uffici governativi lavorano alacremente per portare l’opinione pubblica internazionale dalla loro parte e dimostrare che il nemico a non volere la pace. La guerra mediatica da un lato e dall’altro non risparmia nessun ambito della sfera informativa. Zelensky dopo Istanbul ha parlato di «occasione sprecata» e il suo consigliere capo Podolyak di «dimostrazione del fatto che la Russia non vuole concludere la guerra».
Da Mosca rallentano, continuano a dichiarare che bisogna muoversi per gradi, senza inutili accelerazioni. Putin guarda alle mappe geografiche. Stando alle valutazioni più recenti dell’intelligence occidentale al momento Mosca controlla quasi interamente la regione di Lugansk (99%), il 66% del Donetsk e il 73% di Zaporizhzhia e Kherson. A quanto dicono diversi rappresentanti di spicco del governo russo, l’Ucraina dovrebbe cedere integralmente quegli oblast, oltre a ufficializzare la cessione della penisola di Crimea.
Questa ipotesi andrebbe ben oltre il «congelamento delle linee del fronte» più volte evocato. Sarebbe una capitolazione. Tra l’altro quasi impossibile da formalizzare in quanto l’unico organismo internazionale che può ratificare il cambio dei confini è il Consiglio di Sicurezza dell’Onu al cui interno di trovano Francia e Gran Bretagna che voteranno di sicuro contro una tale frammentazione dell’Ucraina. Mancando l’unanimità non si potrebbe portare a compimento il processo in modo «legale» dal punto di vista del diritto internazionale.
Tuttavia, siamo ben lontani da questa eventualità: Zelensky ha più volte fatto capire che non avrebbe mai firmato un accordo che ratifica la cessione definitiva dei territori ucraini occupati alla Russia. Ha aperto, con cautela, su un possibile mantenimento dello status quo lasciando inalterate le attuali linee degli schieramenti. Il che assegnerebbe di fatto le regioni parzialmente occupate a Mosca ma permetterebbe a Kiev di reclamarle in futuro o di cercare ulteriori accordi.
Ma ora l’impressione è che siamo a un punto di svolta, se non altro per il ruolo degli Usa. Se Donald Trump deciderà di continuare a mediare oppure no lo sapremo a breve ma è certo che questa svolta condizionerà irrimediabilmente il tavolo. L’Ucraina la teme come la peste, essere lasciati soli in balia delle decisioni del Cremlino, magari senza rifornimenti militari adeguati, è il peggior incubo dei vertici di Kiev. La Russia non è altrettanto in difficoltà, ma ora spera di consolidare il suo rapporto con Washington. Nel mezzo, migliaia di soldati continuano a morire in attesa che, altrove, lontanissimo, magari oltreoceano, i politici riescano a mettersi d’accordo sulla loro sorte.